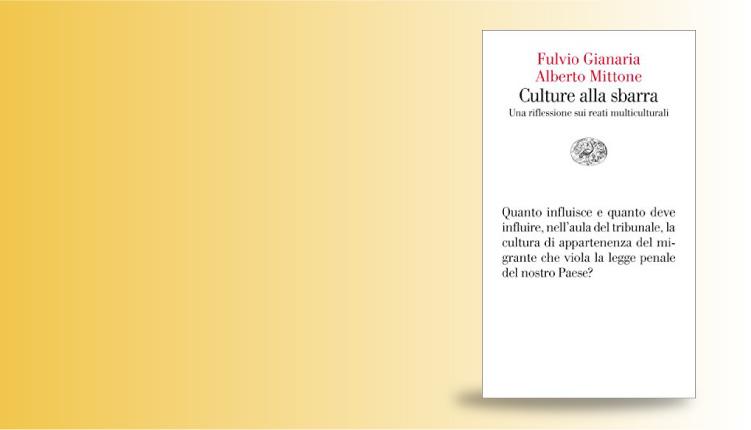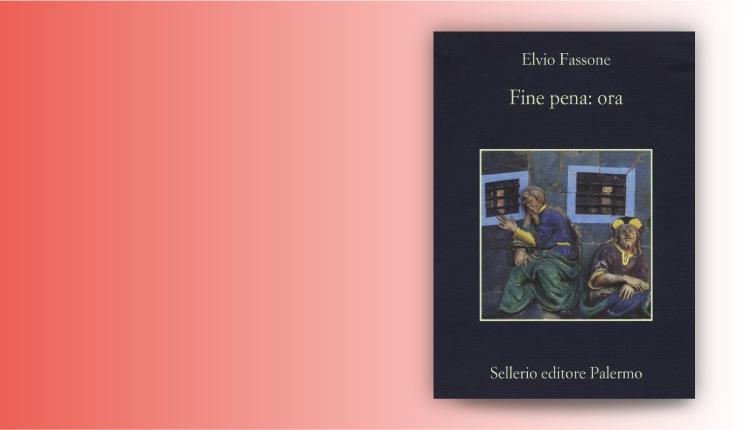Chi è Gustavo Zagrebelsky

Giurista italiano. Ha insegnato Diritto costituzionale e Dottrina dello Stato nelle Università di Sassari e Torino. Già socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, nel 1995 è stato nominato giudice della Corte Costituzionale dall’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro; ha presieduto la Corte dal gennaio al settembre del 2004, diventandone poi presidente emerito. È socio all’Accademia delle Scienze di Torino e dell’Accademia nazionale dei Lincei, nonché presidente onorario dell’associazione Libertà e Giustizia e presidente della Biennale Democrazia.
Illustre opinionista di attualità e politica, scrive per alcuni dei più importanti quotidiani italiani (tra questi La Stampa e la Repubblica) ed è autore di numerosi saggi; dopo La legge e la sua giustizia (2008), Intorno alla legge (2009) e Scambiarsi la veste (2010), tra gli altri ha pubblicato Simboli al potere (2012), Fondata sul lavoro (2013), La maschera democratica dell'oligarchia (con L. Canfora, 2014), entrambi nel 2015, Liberi servi e Moscacieca, Senza adulti, Interpretare (con M. Brunello), entrambi nel 2016 Loro diranno, noi diciamo: Vademecum sulle riforme istituzionali (con F. Pallante) e La tua giustizia non è la mia. Dialogo tra due magistrati in perenne disaccordo (con P. Davigo), Il legno storto della giustizia (con G. Colombo, 2017), Diritto allo specchio (2018), Mai più senza maestri (2019) e, entrambi del 2021, La giustizia come professione e Qohelet. La domanda. Il suo ultimo libro, La lezione, è stato pubblicato nel 2022 da Einaudi.
Juan Carlos De Martin (JCD)
Benvenuti a questa puntata di “Cinque Libri”, l'iniziativa del Politecnico di Torino che consiste nel chiedere a esperti di chiara fama di raccomandare cinque libri che, a loro avviso, sono particolarmente adatti per introdurre un grande tema a un pubblico interessato ad approfondire. Oggi siamo qui con un ospite prestigioso nonché - mi permetto di dire - collaboratore anche del Politecnico, visto che abbiamo spesso fatto cose insieme, che è il professor Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky è un noto studioso di diritto, per molti anni professore di Diritto costituzionale all’Università di Torino, Presidente della Corte Costituzionale, Presidente di Biennale Democrazia, la grande manifestazione culturale che ormai da qualche anno dialoga con Biennale Tecnologia, autore egli stesso di molti testi importanti a cui avremo magari l'occasione di fare qualche riferimento verso la fine della puntata. Al professor Zagrebelsky, a cui dò il benvenuto in questa bellissima cappella del Castello del Valentino, sede storica del Politecnico di Torino, abbiamo chiesto innanzitutto su quale tema aveva piacere di raccomandare cinque libri, e lui ci ha proposto un titolo intrigante: “Miserie e splendori del diritto e dei giuristi”. Cominceremo quindi con il chiedergli il motivo di questo titolo, per poi discutere più nello specifico dei cinque libri che il professore ha pensato di raccomandare ai nostri studenti e al nostro pubblico per affrontare il tema del diritto in senso ampio.
Gustavo Zagrebelsky (GZ)
Grazie dell'invito. E adesso vediamo di fare questa bella chiacchierata cercando di uscire un po’ dall’aridità del mondo giuridico. Diciamo subito una cosa: i giuristi non sono simpatici. E i giudici lo sono ancora meno dei giuristi e dei professori. Non sono simpatici, però il popolo italiano, nel mondo, è uno di quelli che più frequentemente si rivolge ai giudici, e quindi al diritto. Di fronte a un qualunque scoglio nella vita quotidiana, scoglio che implichi una controversia o un conflitto, anche minimo, con un nostro simile, in Italia si dice: vado per avvocati, vado dal giudice. In altri Paesi più civili, gran parte delle controversie che si incontrano quotidianamente si risolvono, come è naturale che sia, guardandosi negli occhi, discutendo, magari litigando. Ma alla fine trovando un accordo. Questo continuo ricorrere al giudice, invece, se ci pensiamo, è un modo per non assumersi le proprie responsabilità, per scaricarle su un terzo: che provveda lui. Poi, naturalmente, se il giudice ci dà ragione, quel giudice è un genio, se ci dà torto, è corrotto e non conosce la sua materia. Come voi capite, ogni processo, nel 50% dei casi, crea dei nemici della giustizia, che sono coloro che naturalmente hanno perso la causa. È una triste condizione, quella dei giudici. Sono malvisti. Quante volte abbiamo sentito il termine azzeccagarbugli, o lo abbiamo noi stessi utilizzato? Un termine che non è poi un’accusa campata per aria. Perché se c'è una mentalità respingente, è proprio quella dei giuristi, o meglio di quel tipo di giurista che spacca le questioni in quattro, poi in otto, poi in sedici. E poi alla fine non si capisce più niente. Invece di guardare le cose nella loro sostanza umana, culturale, quotidiana, questo guardare il mondo attraverso la lente del diritto è un qualcosa molto spesso di disumanizzante. E quindi si capisce bene come i nostri concittadini, in genere, abbiano un atteggiamento prudente nei confronti dei giudici e del mondo del diritto.
Il titolo “Miserie e splendori del diritto e dei giuristi”, forse molti di coloro che ci ascoltano lo sanno, è una citazione da uno dei romanzi della “Comédie humaine” di Honoré de Balzac, intitolato “Splendori e miserie delle cortigiane”. Ecco, mi è venuto in mente il giurista come cortigiano. Non è un gran complimento questo accostamento, ma forse non c'è professione come quella giuridica che è più esposta alla cortigianeria, cioè a mettere la propria scienza (giuridica) al servizio dei potenti. Anche da questo punto di vista è una professione rischiosa, scivolosa. Però ci sono anche gli splendori, e lo splendore della funzione del giurista si vede quando abbraccia delle cause nobili, magari delle cause povere, cioè che non hanno dietro di sé una committenza che dispone di molto denaro per arruolare. Ecco, le miserie: arruolare grandi giuristi che si prestano a sostenere le cause più assurde, magari facendo sfoggio di grande cultura giuridica, spezzando la questione in trentasei o settantadue, tanto da non capirci più niente, tanto da confondere il giudice stesso: di fronte al caos, il giudice come decide? Sarà portato a tirare a sorte?
Ecco, forse questa osservazione ci consente di partire da uno dei libri che consiglierei. Con un'avvertenza: dovete comprendere la difficoltà in cui mi trovo, introdurre al mondo del diritto e del suo ideale le persone inesperte è molto difficile, perché chi ne ha avuto anche solo una piccola esperienza, magari in un’aula di tribunale, sono sicuro che non vorrebbe più averne altre. Tuttavia, io sono qui per cercare non di far propaganda per il diritto, ma per spiegare in poche parole che cos’è attraverso l'uso di cinque supporti libreschi, di cinque testi che a me sono particolarmente cari. Compito molto difficile, come detto, anche considerata un’altra statistica: la percentuale di studenti che hanno scelto di studiare diritto e che decidono di abbandonare al primo anno è elevatissima. A testimonianza di come ci sia molta gente che entra nel suo mondo con certe aspettative, ma che poi viene in qualche modo delusa.
Allora cerchiamo di entrare in questo mondo spiegando, il più possibile oggettivamente, che cosa ci possiamo trovare. Qui abbiamo cinque libri, e a me viene in mente di partire da quello che forse è il più lontano dal mondo del diritto, visto che è un libro dedicato a come nella letteratura, nella grande letteratura, ci si avvicina al mondo giuridico, normalmente in modo critico. C'è un grande vignettista dell'inizio del Novecento che ha prodotto una serie di vignette satiriche sul mondo del diritto davvero straordinarie: rappresentazioni di avvocati con la toga nera che chiacchierano tra di loro e che sembrano dei corvi, impegnati a trattare di una causa, tutti contenti, con sullo sfondo il cliente, che è quello da spennare. Poi i giudici che assistono a queste udienze che si addormentano, oppure che odiano l'imputato perché l'udienza si trascina troppo a lungo mentre loro vorrebbero andarsene a casa. Insomma, tutto quel mondo di piccole miserie che sono peraltro comuni a ogni attività professionale, ma che viste nel tempio della giustizia creano un certo stridore tra miseria umana, quotidiana, e il grande ideale. I giuristi hanno questa idea di mascherare le loro debolezze dietro la figura della giustizia, che è sempre stata rappresentata come una bella fanciulla, giovane e seducente, con la bilancia, la spada, e poi la benda, che però compare solo alla metà del Seicento. È interessante riflettere su questa simbologia: prima c’era solo la fanciulla, che guardava bene negli occhi perché doveva essere imparziale (poi c’era chi già allora faceva ironia e sosteneva che, avendo una spada in mano, forse era meglio se avesse guardato lei per evitare di menarla a casaccio). Ma se il giudice, come rappresentante della giustizia, è costretto a guardare in faccia gli imputati, c’è il rischio che si pieghi all'interesse del più forte, e allora la giustizia, per essere imparziale, deve essere cieca, non deve guardare in faccia nessuno, come spesso si dice. Ma se non guarda in faccia nessuno non vede nulla e c’è quindi il rischio che operi a caso.
Ma veniamo ai libri. Non c'è un ordine logico. Ciascuno di questi libri tocca un capitolo del grande tema del diritto. Da quale cominciamo?
JCD
Comincerei forse da questo libro di cui accennavi brevemente prima, “La borsa di Miss Flite” di Bruno Cavallone, ricordando a coloro che ci seguono che tutti i cinque libri di cui parleremo, come quelli discussi nelle altre puntate, sono disponibili nelle biblioteche centrali del Politecnico, di Ingegneria e di Architettura. E dunque, perché questo libro?
GZ
Questo libro è un modo per introdurci ai discorsi più tecnici attraverso la letteratura, la grande letteratura. Il tema del processo, dei giudici, è un tema classico della letteratura. Basti pensare al Manzoni, giusto per fare un riferimento. Quando Renzo deve difendere la sua causa va dall'avvocato, che viene soprannominato dalla voce popolare l’azzeccagarbugli. Si presenta da lui con dei polli vivi, tenuti per le zampe, che si beccano tra di loro (una scena orripilante), e gli espone appunto il caso di un giovane innamorato che vuole sposare la sua bella. E poi c'è il signorotto locale, Don Rodrigo: anche lui ha messo gli occhi sulla bella e sostiene di avere delle pretese su di lei. L’avvocato, quando Renzo gli espone il caso, pensa sia lui il prepotente che ha delle mire ingiustificate su questa fanciulla. Quando poi viene fuori il nome di Don Rodrigo, che è il signorotto, allora si chiarisce l'equivoco e l’azzeccagarbugli, che prima gli aveva detto che aveva perfettamente ragione, che c'era proprio una legge, una grida, che gli dava ragione, ora - venuto fuori il nome del potente Don Rodrigo - gli dice di no e lo caccia via. “Riprenditi i tuoi polii!”, gli dice.
JCD
Se mi consenti sempre un piccolo riferimento alla letteratura ottocentesca italiana, sul tema penso anche all'episodio del giudice nel “Pinocchio” di Collodi, qualche lustro dopo il Manzoni.
GZ
Certamente. Perché è fin troppo facile fare ironia sul mondo della giustizia, un mondo che si avvolge dietro questa parola così nobile, la giustizia, ma che sotto sotto nasconde molte miserie. Dunque, l’autore di questo libro, “La borsa di Miss Flite”, è un professore di diritto processuale all'Università di Milano. Un uomo estremamente colto, di grandi letture. Se uno prende in mano il libro e lo sfoglia, si accorge subito che ciascun capitolo tratta di un episodio inserito in qualche grande romanzo oppure che fa riferimento a qualche importante testo integralmente dedicato ai problemi della giustizia. Kafka in primis, anche se Kafka, cronologicamente, è uno degli ultimi chiamati in causa. Quello da cui parte, per esempio, è un capitolo di “Gargantua e Pantagruel” di Rabelais: un testo smisurato (l'edizione di Einaudi sono due grossi volumi), non un romanzo come lo intendiamo noi, non c'è una trama vera e propria, ma un testo che racconta delle avventure di questi due personaggi fantastici, inventati, che a un certo punto incontrano la figura di un giudice. Un giudice che, alla fine della sua carriera, emette una sentenza che non piace ai suoi superiori, i quali si stupiscono e gli chiedono: ma come è possibile che tu che hai avuto tutta questa esperienza, che hai fatto il giudice per più di quarant’anni, hai emesso una sentenza così incomprensibile? E lui si giustifica dicendo che ha deciso come ha sempre deciso in tutte le altre cause. Ovvero, tirando a sorte. Dice: ci sono due litiganti con i dadi, io tiro a sorte e dò la vittoria a uno e la sconfitta all’altro, a seconda del responso dei dadi. In fondo - continua - mi è sempre andata bene. Gli altri si stupiscono, sostenendo che la sorte è cieca, che non si può far decidere alla sorte. Eppure, statisticamente, tirando i dadi, tra due opzioni, bianco o nero, ragione o torto, io - dice il giudice - ho la certezza di azzeccarla almeno nel 50% dei casi. Il giudice si rivolge allora ai suoi superiori chiedendo se sono sicuri di poter dire che le sentenze emesse da loro, almeno nel 50% dei casi, hanno deciso il giusto. E loro, chiaramente, rimangono imbarazzati. Oppure, dice sempre il giudice, decido in un altro modo: su questa mia scrivania ci sono due pile di scartoffie che si accumulano; quando hanno raggiunto una certa altezza, io poso le mani una su una pila e l’altra sull’altra pila e ascolto le vibrazioni provenienti da questi incartamenti, per poi decidere. Decido così, sempre con la convinzione che nel 50% dei casi posso avere la coscienza professionale tranquilla. E poi, sempre i suoi superiori gli chiedono: ma allora perché ci mettevi tanto a decidere? E lui risponde: perché la causa, per essere decisa, deve essere matura. Aggiungo che nel codice di procedura civile attualmente in vigore si dice che le cause “vanno in decisione”, che vengono “spedite in decisione”, cioè alla fine della procedura, quando sono mature. Anche noi, quindi, usiamo questa formula. Naturalmente, noi diciamo che la causa è matura quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre le proprie posizioni. Invece, per questo giudice la causa è matura quando dura talmente a lungo che le parti non ne possono più del processo, di averlo intentato o di doverlo subire: devono pagare gli avvocati, si rodono il fegato, odiano la controparte. E a un certo punto abbassano le braccia e dicono: purché questo tormento finisca, qualunque decisione venga presa è meglio che continuare. Questa, per questo giudice, è la causa matura.
Ecco, questa scena - descritta in maniera brillante in “Gargantua e Pantagruel” e riportata così bene anche in questo libro - per un momento non ci fa pensare tristemente a tanti aspetti problematici della giustizia del nostro tempo: la durata dei processi, il loro costo, la casualità delle decisioni. Insomma, noi abbiamo tre gradi di giudizio: il primo grado, l’appello e la Corte di Cassazione. Ora questi tre gradi di giudizio sottintendono il fatto che la stessa causa, la stessa questione, può essere vista in modo diverso. In fondo, si dice, avere tre gradi di giudizio è una garanzia, perché ce ne fosse uno solo le persone sarebbero totalmente esposte all'arbitrio di un giudice. Invece, in questo modo, c'è una sorta di controllo. Anzi, partendo dal primo grado ci sono due controlli. Però, se uno ci riflette, il fatto che ci siano questi controlli, che è un aspetto positivo, sottintende anche un certo grado di opinabilità: perché se ci fosse un diritto chiaro, e si sapesse come il diritto vigente indirizza la decisione, basterebbe un giudice solo. Si parte quindi dal presupposto che le controversie giudiziarie siano sempre sotto il segno dell'ambiguità. Il dubbio, ecco: la nostra giustizia è costruita attorno alla parola dubbio e non alla parola certezza. Sotto questa luce, tutte le sentenze che vengono pronunciate sono criticabili. Tuttavia, alla fine - siccome bisogna arrivare alla fine - la decisione viene presa (dalla Cassazione) e non è più discutibile. Giusta o ingiusta che sia.
Il dubbio percorre dunque in chiave letteraria questi racconti. Un’altra chiave di lettura, per esempio, è l'accanimento giudiziario. Un uomo o una donna qualunque che per una sciocchezza, che però mette in gioco il suo prestigio, come succede spesso nelle controversie di condominio, è capace di tutto, di aprire un’infinità di procedure giudiziarie che finiscono per rovinare tutti, mentre spesso, come dicevo prima, sarebbe possibile risolvere le controversie guardandosi direttamente negli occhi, sulla base del buonsenso.
JCD
Penso tu abbia scelto con grande saggezza di partire da questo libro, perché è il modo migliore per avvicinare al mondo del diritto quelle persone che hanno magari un interesse anche per la letteratura. Un’ottima porta di ingresso. Che cosa ci puoi dire invece del secondo libro?
GZ
Si tratta di un libro scritto da un giurista per i giuristi, o meglio per gli studenti di giurisprudenza, ed è intitolato “Prima lezione di diritto” dell'editore Laterza. L'autore è Paolo Grossi, massimo storico del diritto, illustre professore all'Università di Firenze, accademico dei Lincei, noto in tutta Europa, che ha scritto e fatto tante cose. Io ho portato questo suo piccolo libro, anche se il suo testo più classico è in realtà una storia del diritto europeo. È uno studioso con una caratteristica culturale sua, molto chiara, che lo ha portato a condurre vere e proprie battaglie accademiche, scontrandosi con cultori della stessa materia ma che erano su posizioni diverse. Come si può cercare di spiegare questo libro? Questo libro dà un'idea molto generale del mondo del diritto ed è per questo che l'ho indicato. Paolo Grossi combatteva la sua battaglia nei confronti di coloro che concepivano il diritto come l'insieme delle leggi, di quelle leggi che vengono prodotte da chi dispone del potere di scrivere la propria volontà in articoli di legge. In fondo questo corrisponde a un modo comune di intendere il diritto. Le facoltà di giurisprudenza sono spesso chiamate facoltà di legge oppure, nell'Ottocento, di leggi. L’idea alla base era che l'insieme delle leggi esauriva di per sé il diritto, un modo di concepirlo in senso positivo, o meglio positivistico. Il diritto è un artefatto, è l'insieme delle volontà del legislatore messe per iscritto. Questa è la legge e non c'è diritto fuori dalla legge: tutto il diritto sta nelle leggi. Ancora adesso quando chiedi a uno studente iscritto a Giurisprudenza che cosa fa lui risponde faccio Legge: un retaggio di questa idea che il diritto sia la somma delle leggi. Non è affatto naturale che sia così. La tesi di Paolo Grossi è che questa idea dell’esaurimento del diritto nella legge, o nell’insieme delle leggi, corrisponde semplicemente a una fase della storia del diritto, la fase che nasce con la Rivoluzione francese, con il legislatore dell'assemblea sovrana che si occupa di eliminare o di semplificare il mondo del diritto eliminando le scorie del passato, di quello che si chiama l'antico regime. I giuristi della Rivoluzione francese, ma poi anche gli illuministi, consideravano il mondo del diritto dell'antico regime un mondo caotico: c’erano le leggi del re sovrano, c'erano le consuetudini, c'erano sistemi giuridici particolari nelle diverse città, gli stessi ceti sociali avevano le loro leggi, che si facevano da sé. Ecco, quindi un grande pluralismo di diritto, o meglio di fonti del diritto, che agli illuministi non piaceva. Certo, c'erano anche esigenze di tipo storico-materiale. Il Settecento, che in Francia è il secolo dove nascono queste cose, è stato il momento in cui si è sviluppata per la prima volta un’economia che superava i confini dei borghi e delle città, un’economia che per espandersi aveva bisogno di mercati sempre più ampi; e, naturalmente, questo pluralismo normativo giuridico ostacolava la circolazione dei beni, e anche dei lavoratori. Una delle prime cose che la Rivoluzione francese ha fatto è stato infatti eliminare le corporazioni dei lavoratori: ogni individuo era un possibile impiegato o operaio di qualunque impresa del territorio. Quindi, dietro queste discussioni, ci sono poi, come ovvio che sia, delle ragioni molto pratiche, politiche, concrete. Comunque, dicevo, è in questo periodo storico che si afferma definitivamente l’orientamento che si esaurisce nel dire che tutto il diritto è nelle leggi, che devono essere generali e astratte, cioè valere per tutti nello stesso modo e in ogni tempo, contrariamente a quanto avvenuto fino ad allora, quando erano invece private, particolari, e si chiamavano privilegi. La legislazione diventa quindi questa rete universale di norme che si estende su tutto il territorio del Regno.
Ecco, questo è ciò che Paolo Grossi definisce “leggi-centrismo” o idolatria della legge. Ma perché Grossi assume questo oggetto come punto fondamentale della sua polemica? Perché secondo lui, invece, il diritto è un mondo molto più ricco di questo. E, soprattutto, perché questo “leggi-centrismo” fa pensare al diritto come a qualcosa che si sovrappone alla società, ai rapporti sociali e alla vita sociale. Se volessimo usare un'immagine nostalgica, potremmo pensare a quando eravamo bambini e sulla spiaggia, al mare, avevamo le formine e imprimevamo il pesciolino o la stella marina sulla sabbia. Ecco: Il diritto inteso come una serie di formine impresse dall’alto sulla società. La società, con tutti i suoi rapporti “caldi”, soffocata dalla freddezza di queste forme o formine legali. Questa è la storia del diritto europeo continentale, perché dall'altra parte della Manica c'è il diritto comune, che è rimasto legato a strutture pre-rivoluzionarie; e naturalmente se uno si rivolge a quel mondo giuridico trova molta più vita, diciamo così, perché il diritto inglese si basa sulle consuetudini locali, sui precedenti giudiziari e anche sulle leggi votate dal Parlamento. In tale contesto, le leggi diventano quindi una delle componenti, ma non il fattore decisivo ultimo.
In questo libro Paolo Grossi fa dunque un ricco affresco di tutta questa vicenda storica, arrivando a concludere in modo secondo me molto interessante, e anche problematico se vogliamo, che oggi, pur essendo figli della Rivoluzione francese, dell'Illuminismo e del “leggi-centrismo”, in realtà conviviamo con una pluralità di forze giuridiche. Una di queste, naturalmente, è la Costituzione. Pensiamo a come è nata la Costituzione: è un testo in cui si sono riversate esigenze che partivano dal basso. Era caduto il vecchio regime, il regime monarchico, e si trattava di scrivere un testo alimentato dalla società, che tenesse conto primariamente delle sue esigenze. Ed è ciò che è stato fatto. Tuttavia, l'assemblea costituente non è paragonabile a un legislatore sovrano, al re che impone, che cala dall’alto: è come se quel pesciolino si formasse un po’ da sé. Questo è già un esempio di come il diritto di cui oggi facciamo uso, che ha al centro una Costituzione, è un diritto che nasce dal basso, dalla vita sociale e dalle sue controversie, dalle opinioni politiche, da tutta la ricchezza dell'esperienza di una società.
Ma poi c'è ancora un altro elemento, l'ultimo di cui parlo a proposito di questo libro. Ovvero che le leggi, quelle che vengono dalla Rivoluzione francese, sono oggi sottoposte a un controllo in nome di questo strano principio che è la ragionevolezza. Le leggi che non superano il vaglio della ragionevolezza sono di fatto annullate. Una cosa del genere, per gli illuministi, era inimmaginabile, perché le leggi scritte in quel contesto culturale nascevano dalla ragione, erano intrinsecamente ragione, una ragione positivizzata. Invece, da noi, le leggi si scrivono ma poi vengono sottoposte - presso le Corti costituzionali che esistono in tutti i Paesi - a questo controllo di razionalità o ragionevolezza. Quali sono i parametri della ragionevolezza? I parametri non sono più scritti nelle leggi, ma sono categorie culturali che provengono dalla società e quindi cambiano nel tempo. Ecco questi due esempi ci mostrano i motivi per cui la tesi di Paolo Grossi ha fatto scandalo. Grossi è stato un innovatore ma allo stesso tempo è stato considerato un conservatore, perfino un reazionario, perché mettendo in discussione l’assolutezza della legge è stato accusato di voler tornare all’antico regime, quando invece il suo intento era più concretamente di tornare a valutare la legge nell'ambito di una ripresa di vitalità della società.
JCD
Dopo Paolo Grossi, esponente di punta del diritto italiano, mi sembra che questo terzo libro raccolga le tesi di un personaggio di altissimo livello, ma questa volta straniero. Di chi si tratta?
GZ
Si tratta di questo grande giurista del secolo scorso che si chiama Hans Kelsen, autore di “Che cos’è la giustizia”. Chi era costui? Era un austriaco ebreo che, fortuna sua, era riuscito a evitare i rigori e le persecuzioni del regime nazista per emigrare poi negli Stati Uniti, come accaduto a molti, dove ha poi finito la sua carriera. Nel mondo del diritto è celeberrimo per la sua dottrina “pura” del diritto. Viene bene parlarne adesso, dopo aver trattato di Fabio Grossi, perché in riferimento alla dottrina “pura” del diritto potremmo dire che la visione del diritto di Paolo Grossi corrisponde invece a una visione impura, nel senso che ci sono tanti elementi che formano il mondo giuridico. Per Kelsen la scienza del diritto è una scienza esatta, basata sulla regola principale della scienza: il principio di non contraddizione. Se noi, nella nostra scienza, troviamo una contraddizione tendiamo a superarla, a eliminarla. Per Paolo Grossi, invece, le contraddizioni sono vitali, servono alla vita del diritto. Per Kelsen la vera scienza del diritto e quella “pura”. Ma cosa vuol dire “pura”? Significa che, nel considerare il diritto, bisogna scremarlo da tutto ciò che ha a che vedere con la morale, con la storia, con la sociologia, con la religione. Cioè, la premessa di ogni concezione scientifica è prima di tutto la delimitazione chiara del proprio oggetto. E, in secondo luogo, l'applicazione a questo oggetto della metodologia adatta ad affrontarlo. Come definisce Kelsen il campo del diritto? Il campo del diritto è quello determinato delle leggi positive. Quindi torniamo al positivismo stretto. Potremmo dire che è una grande concezione. Kelsen è un grande costruttore di cattedrali giuridiche, un uomo di idee, forse un po’ freddo rispetto a Paolo Grossi. Allora, il diritto è un insieme di leggi positive create consapevolmente da un organo competente a legiferare. È una costruzione in cui tutto questo materiale legislativo si può, anzi, si deve collocare su strati gerarchici diversi. Al vertice c'è la Costituzione, poi c'è la legge ordinaria, poi ci sono i regolamenti del governo e i regolamenti degli enti territoriali. Poi si scende giù fino ai contratti tra privati, che hanno valore normativo per le parti, per arrivare infine alle sentenze. Questa grande struttura piramidale, e i rapporti tra le norme che stanno su ciascuno di questi gradini, sono determinati dal principio di non contraddizione. Onde per cui: se una norma che sta sotto contraddice una norma che sta sopra, quella è invalida e deve essere eliminata. Allora, proprio perché l’intento di Kelsen è trattare il diritto scientificamente, eliminando tutto ciò che giuridico non è, nella sua visione il diritto è autonomo, non deve fare i conti con la giustizia, perché il mondo della giustizia è il mondo della filosofia, della filosofia morale, dell'etica. Cioè, altri campi. Quindi per Kelsen il diritto è un mondo autosufficiente. Lui era un ebreo e, guardando alle leggi razziali del 1938, per lui erano comunque leggi. Leggi ributtanti ma assolutamente valide all’interno del modo di concepire il diritto che aveva. Per definirle ributtanti devo spostarmi in un altro ambito, fuori da quello giuridico. Dal suo punto di vista qualunque sistema giuridico, purché esista, cioè purché sia effettivo, purché sia in grado effettivamente di regolare la vita di un popolo, la vita sociale, è di per sé valido. Poi, puntualmente, ciascuno è libero di guardare al mondo non soltanto attraverso le lenti giuridiche ma anche attraverso quelle che appartengono ad altre dimensioni.
Questa struttura piramidale è tale per cui le norme che stanno sotto sono legittimate dalle norme che stanno sopra. C'è questa specie di “regressus”. Tu hai una norma qualunque in un regolamento comunale: perché è valida? Perché c'è un regolamento comunale generale e sopra quel regolamento generale c'è una legge, e la legge è valida perché è conforme alla Costituzione, ecc. Ecco, c’è questo “regressus ad infinitum”. Perché la Costituzione è valida? Cosa c'è sopra la Costituzione? Kelsen dice che la Costituzione è valida perché è efficace. Cioè le costituzioni valide lo sono solo se effettivamente applicate e rispettate. Quindi le costituzioni sono valide sulla base di fatti storici. La più bella Costituzione del mondo, la costituzione dell'Isola di Utopia, non avendo nessun potere sopra di lei che la garantisca, di fatto non è efficace e quindi non è valida. Allora, la tesi è una speculazione filosofica che si collega poi anche a questioni teologiche (il motore immobile, la catena infinita di cause che risalgono alla causa prima, cioè Dio). Ecco, secondo questa costruzione - che consente a Kelsen di essere rigoroso nel trattare il diritto soltanto come diritto - al di sopra di tutto c’è questa norma implicita per cui è valida solo una costituzione effettiva ed efficace.
JCD
Se posso fare un commento: l’efficacia, come dicevi, dipende anche e soprattutto da condizioni storiche. Ma ad un certo punto in questa sua cattedrale si incunea la realtà…
GZ
Si incunea nella maniera più forte e anche contraddittoria, perché Kelsen voleva solo poter trattare di norme, ma invece l'effettività o l'efficacia è un fatto, un fatto storico. Però lui la assume e la chiama la norma fondamentale, che non troviamo scritta da nessuna parte. Per lui è una norma ipotetica che ci serve per spiegare. Naturalmente, si capisce, che questo libro intitolato “Che cos'è la giustizia” è un libro che serve a smantellare l'idea secondo la quale i giuristi hanno a che fare con la giustizia. No: i giuristi hanno a che fare con la legge.
JCD
È molto interessante. Sospetto che tu abbia scelto questo libro perché, anche alla luce del pensiero che ci hai esposto e sintetizzato, è in qualche modo affine alla mentalità politecnica. Nel senso che mi verrebbe da pensare che non pochi membri della comunità politecnica troverebbero attraente questa idea di delimitare bene, di rendere tutto logico, coerente. Quindi una finalità epistemologica, in un certo senso.
GZ
Di fondo c'è questo progetto, illusorio, di separazione categoriale delle scienze e delle conoscenze. Ma noi sappiamo di vivere in un mondo di impurità, anzi forse preferiamo vivere in un mondo un po’ impuro, soprattutto rispetto a queste cattedrali di cristallo. Per concludere, in “Che cos’è la giustizia” si sostiene la tesi che alla fine non lo sappiamo che cos’è davvero la giustizia: non è il diritto naturale, non è il diritto sociale, non è il diritto divino. La giustizia, in fondo, è un fatto convenzionale o, se vuoi, culturale. E Kelsen, alla fine di questo testo, si interroga sulla validità stessa del suo costrutto, questa volta da un punto di vista strettamente morale: una cosa vale un’altra? Il diritto staliniano come il diritto nazista o qualunque altro diritto? Non è così. Io, dice Kelsen, togliendosi il cappello da giurista, ho una mia concezione della giustizia. Dal momento che sono un uomo di scienza e so che cos'è la scienza, ovvero il regno della libertà, per me la giustizia è libertà.
JCD
Interessante, quindi poi alla fine, smettendo i panni del giurista, tocca realmente con mano le cose. Anche perché, comunque, ho visto che queste lezioni Kelsen le ha tenute negli Stati Uniti, a Berkeley, in California, e credo quindi che, in qualche modo, abbia anche dovuto tenere conto dell'uditorio americano e dei suoi valori di riferimento.
GZ
Sì, in fondo è anche una prova di umiltà. Kelsen dice, io non posso parlare per tutti, io parlo per me, di che cosa è per me la giustizia, di ciò che mi consente di fare lo scienziato liberamente, anche di sbagliare liberamente.
JCD
Tra l'altro una di queste lezioni credo l’abbia tenuta negli anni Cinquanta, quindi poco dopo il maccartismo.
GZ
Ve bene, parliamo rapidamente del quarto libro. Fulvio Gennari e Alberto Mittone sono due avvocati importanti, famosi a Torino ma non solo. Avvocati penalisti, hanno scritto questo libro intitolato “Culture alla sbarra”, Einaudi 2015, che tratta dei cortocircuiti che si possono determinare quando, davanti alla giustizia penale (ma non necessariamente penale), i nostri tribunali hanno a che fare con persone che provengono da ambiti culturali lontani dal nostro. Gli autori fanno tanti esempi, non solo italiani. Vediamone qualcuno. In certe civiltà l'affetto che viene manifestato dai genitori nei confronti dei figli, dei bambini, affetto che noi manifestiamo con il prenderli in braccio, coccolarli, in certe civiltà questo affetto si manifesta attraverso atti che noi consideriamo invece osceni, quasi degli atti di pedofilia. Come li trattiamo? Secondo la loro mentalità o secondo la nostra? In India esiste una popolazione, i Sikh, i cui maschi usano portare tradizionalmente un pugnale alla cintura. Ora, nelle nostre civiltà portare un’arma con sé vuol dire che in qualsiasi momento tu puoi usarla per uccidere un tuo simile, ma per loro è un elemento di dignità che fa parte del loro abbigliamento e non si sognerebbero mai di usarla a quello scopo. I Sikh, che hanno fornito anche delle truppe scelte durante l'occupazione britannica, normalmente sono persone tranquille. Ecco, se tu mi avessi invitato qui portando con te un coltello dalla lunga lama, io mi sarei inquietato. Tra loro non succederebbe. Come considerare tutto questo? Sempre dal punto di vista nostro o dal loro? Intendiamoci, il diritto è fatto molto spesso non di norme precise ma di princìpi, che si tratta di valutare rispetto a situazioni concrete. Prendiamo il caso del velo nel mondo islamico, che è un caso classico. Allora, noi consideriamo il velo come qualcosa che, secondo la nostra cultura, viola la libertà o la dignità della donna. Non tanto il velo, ma l'obbligo di portarlo, perché molte ragazze, molte donne, dicono io porto il velo perché è un segno identitario in cui credo. Anzi, considero una violenza il fatto che voi vogliate togliermi il velo. Ma di fronte a una donna che si ribella all'obbligo di portare il velo, noi che cosa facciamo? Le offriamo protezione, in base alla nostra idea di libertà? Oppure, diciamo no, perché rispettiamo la libertà della sua cultura? È un problema. E ci sono varie risposte nelle sentenze.
Questo è un libro essenzialmente basato sulle sentenze. I casi che si esaminano sono tantissimi e ci interrogano. Intendiamoci, questo impatto delle culture diverse da quella dominante noi lo conosciamo bene, non è una novità. Per esempio, il fatto che nelle mense scolastiche si consenta ai bambini di religione ebraica di mangiare kosher, o che si cerchi di rispettare la sacralità del sabato, è un modo di adattare la nostra cultura ad un’altra, ad altre tradizioni. Questo libro, che si legge molto agevolmente, ci pone di fronte a una delle grandi sfide del nostro tempo, perché la gran parte delle questioni qui trattate fino a cinquant'anni fa non si immaginava nemmeno che potessero esistere, come ad esempio il multiculturalismo.
JCD
In fondo quello che hai seguito nella scelta dei testi è un arco partito dalla Rivoluzione francese, e quindi dall’eliminazione della complessità precedente e dall’uniformità sul territorio della nazione, per tornare per motivi diversi al pluralismo.
GZ
Naturalmente questo tema ha sullo sfondo il limite, perché è buona cosa rispettare le culture, ma se queste culture contengono elementi di violenza? Di fronte alla famiglia islamica che se la prende con la figlia che vuole fidanzarsi con un occidentale, fino a usarle violenza, non possiamo guardare altrove. Non è accettabile.
JCD
E c'è anche un altro limite che, forse per il momento, è ancora teorico e di cui però vediamo già qualche segnale inquietante: la frammentazione. Nel senso che abbiamo parlato di grandi religioni tradizionali, del nostro Mediterraneo, delle grandi differenze, ma la tendenza oggi è che ciascuno sembra volersi creare il proprio piccolo mondo, regolato da leggi proprie.
GZ
È vero. Io stesso desidererei isolarmi in un mio piccolo, personale ordinamento giuridico.
JCD
Beh, alcuni grandi magnati della Silicon Valley, questi miliardari che hanno fatto fortune con le tecnologie digitali, argomentano apertamente sul diritto di secessione, ovvero di creare i propri Stati su piattaforme, ognuna con le proprie leggi e le proprie regole.
GZ
Certo … Io vivo e vivo a Torino, mi sono inserito nella comunità nazionale e magari anche in qualche comunità un po’ più ampia. Ma la tentazione di ritirarsi in una sperduta vallata delle nostre Alpi, chiudere l'accesso e dichiarare il mio personale principato, esiste. Al di là degli scherzi, c’è sempre un doppio lato nella nostra vita: l'apertura universalistica e la difesa del nostro piccolo mondo.
Ma passiamo all’ultimo libro, che sta un po’ fuori dall’arco che abbiamo tracciato. L’autore è Elvio Fassone, un ex magistrato che si è sempre occupato di diritto penale, ed è intitolato “Fine pena: ora”, editore Sellerio. Tratta del più disumano fra i diritti, il diritto penale appunto, quel diritto che ha di fronte a sé l'imputato e la pena carceraria, nel quale si manifesta nel modo più evidente la forza dello Stato sovrano contro il povero diavolo. Perché, diciamolo, la gran parte di coloro che delinquono sono persone che, se potessero, non delinquerebbero. Il diritto penale è fatto di leggi generali e astratte, come si diceva prima, ma le vittime di questa specie di rete stesa sulla società sono spesso i poveri. Mi viene in mente una formula che riporta Plutarco, messa in bocca a Diogene Laerzio, che dice “il diritto è come una grande rete”. L'immagine è quella dell'uccellatore, quello che stende una grande rete sulla società. E poi aggiunge, ironicamente, “gli uccellini piccoli rimangono incastrati e gli uccelloni ci fanno buconi”, ci passano attraverso. Formalmente, dunque, è un diritto egualitario. Di fatto non lo è. In questo mondo le differenze sociali, come in tanti altri ambiti, si manifestano con evidenza. Questo libro è un libro di un giudice tormentato proprio per la difficoltà di far convivere l'astrattezza della ferocia della legge con l'umanità dei rapporti. Lui era presidente della Corte d'Assise in un grande processo di mafia con tanti imputati che si è svolto a Torino e in quell’occasione era entrato in un rapporto personale con un ragazzo che si presentava palesemente come un capo. Cosa che, naturalmente, gli aveva attirato critiche da parte dei suoi stessi colleghi, che gli ricordavano come fosse sconveniente avere rapporti con gli imputati al di fuori dell’aula di tribunale. Questo rapporto, cercato anche dallo stesso imputato, era comunque un rapporto basato sulla chiarissima definizione del ruolo del giudice, che non è un amico, e allo stesso tempo del ruolo dell'imputato, che non ha da cercare di commuoverlo. Questo imputato, il ragazzo, era un condannato all'ergastolo per gli omicidi che aveva commesso, però nel pieno rispetto dei ruoli il giudice ha come accettato su di sé il peso di questa frase che gli aveva buttato in faccia: “Signor Giudice, se lei fosse nato e vissuto nel rione X di Palermo lei sarebbe al posto mio”. È una cosa che questo giudice accetta come definizione del suo status. E, dell'altra, l'imputato, che piano piano riesce a entrare nella mentalità del giudice e, in qualche modo, accetta il fatto di essere imputato, accetta la giustizia tramite il dialogo con lui, anche attraverso un fitto scambio di lettere.
Questo è un lato del libro. L'altro lato consiste nella descrizione delle condizioni di vita di un internato in un carcere. Perché questo ragazzo, evidentemente un ragazzo di qualità, nei vari carceri riusciva a creare un ambiente umano in cui vivere. Si era perfino fidanzato con una ragazza di fuori, con la quale era riuscito a instaurare una relazione. Ragazza, poverina, che di fronte alla prospettiva dell’ergastolo, del “fine pena mai”, come si dice, non aveva resistito, aprendo una ferita nel condannato che si era illuso che, sia pure con i permessi premio o con la possibilità di uscire ogni tanto dal carcere, fosse possibile crearsi una vita normale anche sul piano affettivo. E poi tutte le difficoltà derivanti dai trasferimenti da un carcere all'altro e, quindi, della necessità di ricominciare sempre daccapo, in ambienti diversi, sempre molto chiusi, basati su forti gerarchie, sulla violenza tra carcerati. Questo libro finisce, anzi non finisce, perché ad un certo punto questo ragazzo scrive che ha deciso di farla finita, ma l’autore non ci dice se si sia suicidato oppure no. È un libro che “prende” molto, perché da una parte descrive i pensieri, le angosce di chi deve giudicare, con il rigore richiesto dal suo ruolo, e d'altra la difficile condizione di chi è oggetto della giustizia. È un libro splendido. Tra l'altro pare che siano stati acquistati i diritti per farne un film.
JCD
Bene, siamo giunti quindi alla fine di questa puntata di “Cinque Libri”. Ringrazio moltissimo il professor Gustavo Zagrebelsky per aver dedicato un po’ di tempo a noi, ancora prima di oggi, per pensare al tema, appunto “Le miserie e gli splendori del diritto e dei giuristi”. E poi, naturalmente, per averci illustrato questi cinque libri molto diversi tra loro. Penso che chi ci ascolta, chi è incuriosito da questo tema, troverà tra questi cinque libri sicuramente un punto di ingresso interessante, vicino ai propri interessi e vicino alle proprie affinità. Quindi grazie ancora, grazie di essere stato qui al Politecnico.
GZ
Grazie a tutti coloro che sono stati così gentili da ascoltare la nostra chiacchierata, senza dare segni di impazienza.
JCD
Grazie. Alla prossima puntata.