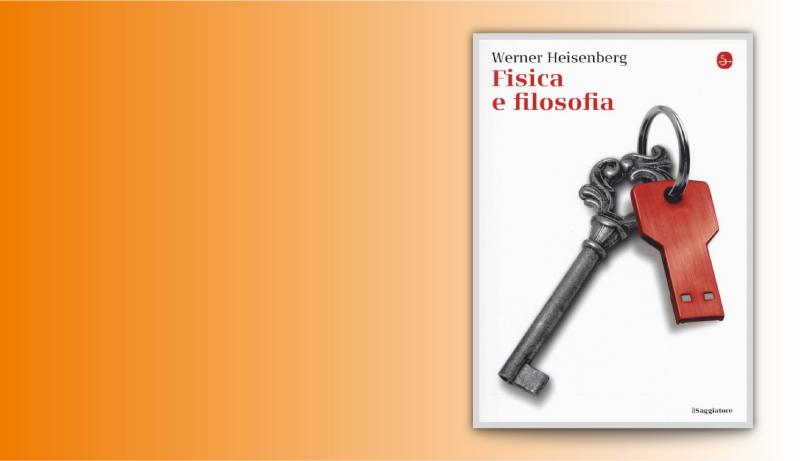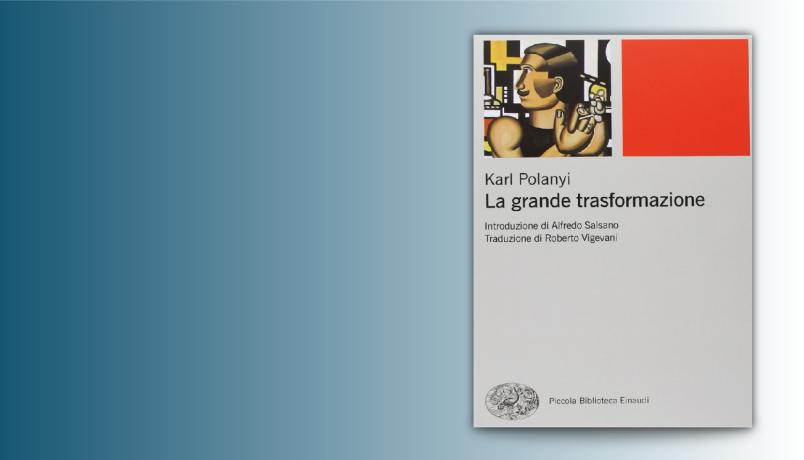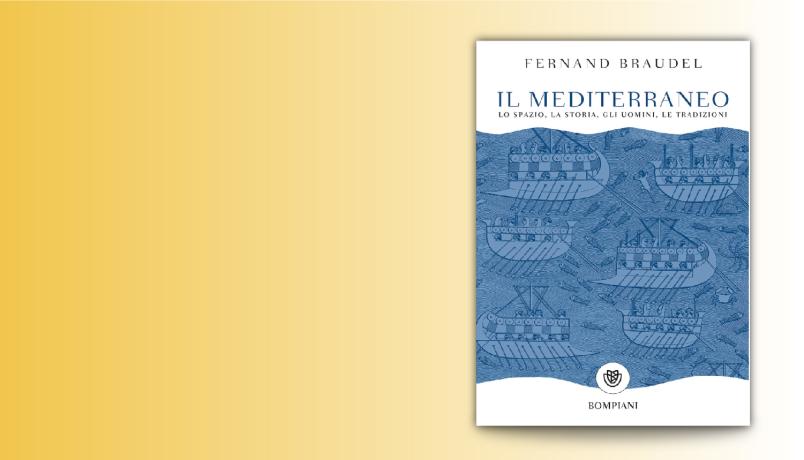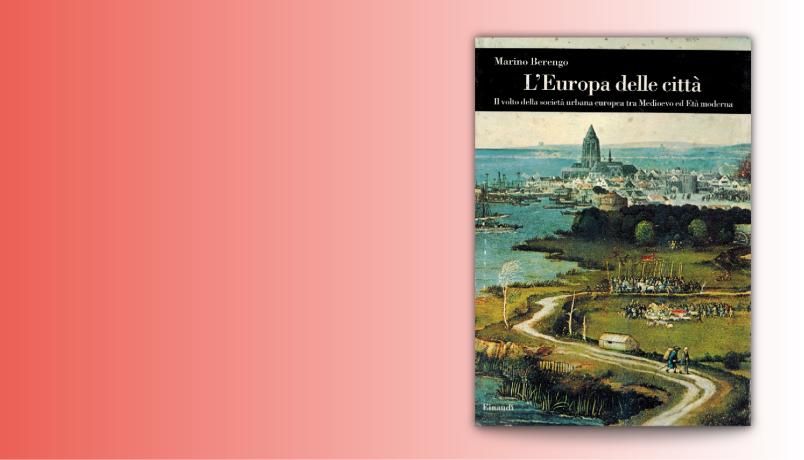Chi è Carlo Olmo

Professore emerito di Storia dell’Architettura al Politecnico di Torino, dove è stato Preside della Facoltà di Architettura.
Laureato in Filosofia e in Lettere Moderne a Torino tra il 1968 e il 1969, ha insegnato all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, al MIT di Boston e in numerose altre università straniere.
Curatore di mostre, studioso multidisciplinare, membro dei comitati di redazione di numerose case editrici e riviste nazionali ed internazionali, è stato direttore dello Urban Center Metropolitano di Torino dalla sua fondazione fino al 2014 e consigliere del Sindaco di Torino per la qualità architettonica ed urbana dal 2002 al 2006.
Autore di oltre 500 pubblicazioni, recentemente ha scritto: Progetto e racconto. L'architettura e le sue storie (2020), Città e democrazia. Per una critica delle parole e delle cose (2018), Urbanistica e società civile (2018), oltre ad Architettura e storia. Paradigmi della discontinuità (2013) e Architettura e Novecento. Diritti, conflitti, valori (2010).
Carlo Olmo ha partecipato a numerose iniziative culturali promosse dal Politecnico. Qui il video della serie PoliCult : Carlo Olmo rilegge quattro suoi libri (più uno) in dialogo con Sergio Pace
Benvenuti a questa prima puntata di “Cinque libri”. Sono Juan Carlos De Martin, Vice Rettore per la Cultura e la Comunicazione del Politecnico di Torino. Prima di presentarvi il primo ospite di “Cinque libri”, un caro amico e collega, due parole sull’iniziativa.
In un momento storico caratterizzato da comunicazioni estremamente numerose e spesso molto brevi, il Politecnico di Torino è convinto che il libro sia più importante che mai, un antidoto potente per orientarsi nel frastuono spesso assordante dell’attualità. Libro, quindi, inteso come oggetto a cui dedicare tempo e attenzione, che genera riflessioni e ragionamenti, stimola il dialogo e costruisce, pagina dopo pagina, le basi del sapere. Nasce così l’iniziativa “Cinque libri”. La formula (ispirata a quella di un noto sito britannico, fivebooks.com) è semplice: il Politecnico chiede a degli esperti di raccomandare cinque libri riguardanti un argomento di interesse non solo per la comunità del Politecnico, ma anche, potenzialmente, per molti cittadini - e di spiegare le loro scelte in un’intervista.
I libri sono importanti perché la forma libro risulta essenziale non soltanto per articolare bene un argomento, ma anche perché molti temi sono complessi e quindi richiedono una forma lunga per poter essere affrontati in maniera soddisfacente. Ecco perché i libri devono rimanere al centro della vita universitaria. Questa iniziativa, quindi, vuole essere un contributo in questa direzione. Leggere libri, commentarli, studiarli, contribuire scrivendo nuovi libri è una delle missioni fondamentali dell'università.
Ma passo a presentare il nostro ospite, il Professor Carlo Olmo, professore emerito del Politecnico, che ha servito per molti anni con diversi ruoli, anche molto importanti, e con altrettanto importanti collaborazioni internazionali: penso, in particolare, al tempo che ha passato a Parigi e al MIT di Boston. Il Professor Carlo Olmo, laureato in storia e filosofia, viene in un Politecnico e si occupa in particolare di architettura, storia dell'architettura, ma oltre a questo suo contributo disciplinare si è occupato, praticamente fin dall'inizio – tra l'altro lavorando con grandi studiosi del Politecnico come Roberto Gabetti – di cultura politecnica.
Siamo in un Politecnico, quindi è normale riflettere sulla cultura politecnica. In particolare è normale interrogarsi su che cosa si intende per cultura politecnica in un determinato periodo storico. La cultura politecnica odierna, infatti, è necessariamente diversa da quella che è stata alla nascita delle grandi scuole tecniche nel settecento, così come risulta molto diversa da quella ottocentesca e novecentesca. Ebbene, questa specifica attenzione di Carlo Olmo per la cultura politecnica è il primo motivo per cui abbiamo pensato di invitarlo a inaugurare la serie di incontri “Cinque libri”. C’è poi anche un secondo motivo, altrettanto importante: il prof. Olmo ha dato un contributo concreto, istituzionale, per favorire quel dialogo tra discipline che sta al centro della cultura politecnica. Cito solo un dato: Carlo Olmo è stato uno dei principali attori dell’Istituto di Studi Superiori di Scienze Umane (ISSSU), una pionieristica iniziativa del Politecnico attiva a cavallo tra il XX e il XXI secolo, un’esperienza che continua ad ispirarci ancora oggi. Per questo motivo abbiamo chiesto a Carlo Olmo di selezionare cinque libri a suo avviso importanti per la cultura politecnica in questo momento storico. Per iniziare ti chiedo: con quale criterio hai scelto questi cinque libri?
Carlo Olmo: Innanzi tutto grazie, Juan Carlos, la domanda è assolutamente centrale. Quando mi è stato proposto di scegliere cinque sono passato dai ‘miei’ cinque libri – che non sono questi, sono i libri che noi teniamo sul tavolino, come dicono i francesi, i livre de chevet – ai libri che in questo momento storico presentano forse una riflessione sulla nostra cultura politecnica e anche sulla sua storia. Perché ognuno di questi libri interpreta un momento storico, dà un contributo specifico alla cultura in generale e alla cultura politecnica in particolare. La scelta è stata fatta sulla base dell'importanza del libro nel momento in cui esce e anche su quella che si chiama fortuna critica, sulla sua diffusione in ambito culturale più generale e poi in ambito politecnico in particolare.
Alcuni di questi libri vi sorprenderanno, se intesi come basilari per una cultura politecnica. Nel presentarli cercherò di spiegare il perché.
JCDeM: Hai scelto un criterio cronologico nel presentare questi cinque libri, e quindi partiamo dal primo, un libro che è stato pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1859 (incidentalmente lo stesso anno in cui fu fondata la Scuola di Applicazione degli Ingegneri, l’istituzione progenitrice, col Museo Industriale, del Politecnico), l'Origine delle specie di Charles Darwin: che sia un grande libro è preclaro, ma perché a tuo avviso è un libro importante specificamente per la cultura politecnica?
CO: Perché il darwinismo e poi l'evoluzionismo – tutto ciò che da questo libro viene fatto nascere di giusto e di sbagliato – è forse l'anima più importante della cultura politecnica, intendendo per anima la capacità di spiegare come si legano per la cultura politecnica la ricerca, l'esperimento, la prova, la scrittura. Questo libro è l'esito del secondo viaggio che Darwin compie sul Beagle in cui arriva all’Isola di Pasqua; riporta e allarga le riflessioni, che lui ha sperimentato. Darwin è stato un viaggiatore, comprende in questo termine anche il concetto di rischio, che è un concetto fondamentale nella ricerca politecnica. Comprende in maniera molto anticipata una concezione dell’ambiente, perché Darwin era un viaggiatore innamorato dei posti in cui in cui viaggiava, e lui riporta in Inghilterra e in particolare ai Kew Gardens una serie di piante che lui trova, su cui studia, su cui formula le sue teorie. Sulla base di tutte queste esperienze formula una teoria.
Il nostro procedere – anche il mio procedere di storico –nasce dalle fonti e procede poi ad esprimere ipotesi, una teoria e poi la verifica su quello che ha. Questo libro è stato talmente importante che ha avuto sei edizioni diverse e decine e decine di traduzioni in tutte le lingue e ha originato quello che è stato chiamato darwinismo di destra e di sinistra, determinando nella scienza e nella tecnologia due atteggiamenti: quello di destra, molto conservatore, sull’evoluzione, che va a scontrarsi con il creazionismo, ossia con l'idea che il mondo fosse stato creato da un dio (lui era un pastore protestante, era religioso, non era un ateo); quello di sinistra, invece, che proprio prendendo spunto da due degli elementi centrali di questo libro (la selezione della specie e il salto di specie) mette in luce la possibilità di una non continuità, di un percorso non lineare. In altre parole, l’idea che un progresso non sia un progresso continuo e ininterrotto; un’idea per la quale Darwin introduce, per primo, anche se non in forma compiuta, il concetto che una catastrofe (una catastrofe ecologica o una catastrofe umana) possa interrompere l'evoluzione.
Rileggere questo libro, specialmente nella sua prima edizione (che è quella più fresca, e non quella riscritta più tardi insieme ad altri, perché sono intervenuti suoi amici e colleghi a scrivere con lui), restituisce a noi il senso più bello della cultura politecnica, che studia, ricerca, viaggia, rischia, teorizza, sperimenta e scrive, scrive, un’attività fondamentale, che oggi purtroppo stiamo perdendo.
Per scrivere un libro – L’origine delle specie – lui, Darwin, il viaggio lo compie negli anni Trenta, mentre il libro esce nel 1859: per maturare un libro e dunque un progetto di questa portata naturalmente c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di discussione, c'è bisogno di discuterlo come lui ha fatto in una quarantina di seminari prima di arrivare alla stesura definitiva. Darwin ha generato cultura, diffondendola intorno a sé, e forse per questo è stato poi attaccato in maniera anche violenta. Quando scrivi qualcosa di importante, tendenzialmente non conformista rispetto al proprio mondo, diventi un personaggio poco amato da quello stesso mondo. Lui non è stato amato dal mondo dei biologi, degli etologi, da quel mondo scientifico che si stava costruendo.
Io credo che uno studente del Politecnico che non ha letto L’origine delle specie abbia un buco nella sua formazione, perché è come se non sapesse da dove inizia e rispetto a cosa misura cosa è cambiato oggi rispetto ad allora: quanta ingenuità noi vediamo oggi in quel libro, e invece, se lo storicizziamo, quanto comprendiamo invece quanto questo libro fosse in anticipo rispetto al suo tempore. Ricordiamoci che siamo a metà dell’Ottocento, nel momento in cui dominano due concetti fondamentali: quello dello stato–nazione e di identità, che sono incompatibili con un libro come questo, perché l’evoluzione – come il virus di oggi – non conosce frontiere e nulla nella natura è simile a se stesso. La scienza non ha e non deve avere limiti, e quindi è un libro che ci insegna questa dimensione, ma soprattutto è un libro che fissa i paletti della cultura politecnica, una cultura sperimentale, capace di buttarsi a esplorare la realtà, che su questa base costruisca una teoria, che la metta alla prova, che la discuta con tanti, che sia un elemento di diffusione e non di selezione accademica. Di questo avremmo veramente bisogno.
JCDeM: Col secondo libro passiamo al Novecento, con uno dei grandi scienziati tedeschi che si è occupato però non soltanto della sua disciplina, ovvero, della fisica, ma anche di altro, in primis della relazione tra fisica e società. Nello specifico stiamo parlando di Werner Heisenberg e del suo libro Fisica e Filosofia. Perché secondo te è un libro importante che dovremmo conoscere sia come docenti che come studenti di un politecnico?
CO: I libri sono legati anche all'autore. Prima, con Darwin, abbiamo visto come la fortuna di un libro vada ben al di là del suo autore. In questo caso il libro (di libri i fisici non ne scrivono tantissimi o forse ne scrivono in una fase successiva a quella che è la loro fase di maggiore produzione scientifica). Questo libro è legato ad una figura che attraversa tutto il nostro Novecento, e non dal punto di vista della neutralità sempre invocata di a Einstein o della fuga dall'Europa nazista di altri grandi fisici (come Fermi e altri) ed è su questa contraddizione che io vorrei che ci si soffermasse: la scienza non necessariamente è una scienza progressista, non necessariamente porta con sé il bene della società.
Heisenberg, che ha dato un contributo fondamentale alla fisica – è premio Nobel per la fisica nel 1932 – scrive questo libro in cui il nodo epistemico fondamentale è il principio di indeterminazione, anche se poi è stato usato in termini talmente allargati che lui si sarebbe messo a ridere se solo gliel’avessero detto, dal momento che lo applica ai movimenti degli elettroni dentro l’atomo, elaborando una teoria sull’origine dell’universo di straordinaria importanza. Heisenberg, che ha i massimi riconoscimenti, che lavora con Bohr, che dialoga con Einstein, che rappresenta la scienza tedesca ad uno dei suoi massimi livelli – e che quindi tu ti aspetteresti che quando arriva Hitler, che rappresenta contrario dell’atteggiamento scientifico in tutti i sensi, si sottragga a questo mondo – è in realtà l’unico dei grandi fisici tedeschi che rimane in Germania e, tra molte virgolette, è il padre della bomba atomica tedesca, che per fortuna non è arrivato a completare, altrimenti vivremmo in un modo diverso.
Dopo la guerra, Heisenberg vive considerando la stagione nazista una parentesi, esprimendo così due nodi problematici della nostra cultura politecnica. Il primo è che dovremmo insegnare che la scienza e la tecnologia non sono neutrali, non possono essere collocate da ogni parte senza un’etica di fondo dello scienziato. Il secondo è un elemento che sulla società ha ancora più impatto, e che non riguarda solo Heisenberg: dopo la seconda guerra mondiale, vista anche la nascita dei vari muri che si costruiranno tra i paesi comunisti e quelli occidentali per motivi anche molto più sostanziali, la maggioranza di coloro che collaborarono con i regimi fascisti e nazisti – non solo in Germania e in Italia, ma anche nei paesi slavi per esempio – conservarono le loro posizioni. Non solo, Heisenberg diventa dopo la guerra il presidente del Max Planck Institute, della massima istituzione tedesca che si occupi di scienza in Germania. Anche questa è una lezione: etica e scienza possono scindersi. Tu puoi accettare di mettere te stesso al servizio di qualcun altro, e questa è una riflessione che andrebbe portata molto avanti da noi del Politecnico, perché troppe persone pensano che noi ci collochiamo tra quello che sta prima e quello che si farà dopo; che, cioè, il Politecnico si collochi tra i problemi che chiedono una soluzione e le risposte che si possono dare, non importa poi controllare in quale contesto ambientale, sociale, economico o politico.
In realtà il libro è stato scritto da lui durante la guerra, quando il nazismo stava finendo ed esce dopo la guerra. È un libro che viaggia parallelo con un altro grandissimo libro e con un altro grandissimo intellettuale, Essere e Tempo di Martin Heidegger, padre di tutti i filosofi relativisti occidentali, filosofo di una difficoltà teoretica veramente ardua, che scrive durante la guerra questo libro sul tempo e che avrà una parabola del tutto simile a quella del libro di Heisenberg. Autore e libro non saranno coinvolti nelle vicende dei processi post seconda guerra mondiale, e Heidegger continuerà la sua carriera accademica con grande serenità (non so se personale).
Heisenberg è però anche un personaggio chiave della cultura fisica e politecnica: il principio di indeterminazione, al di là del suo uso volgare, tocca un nodo fondamentale della nostra cultura, ossia la cultura binaria, mette in gioco lo 0–1 su cui si basava in gran parte dell’insegnamento.
Mi ricordo che quando sono entrato al Politecnico i primi confronti sulla sua messa in discussione li ho avuti con Mario Rasetti, all'inizio degli anni ‘70: Heisenberg, nell'introdurre un principio che certamente è limitato a un mondo subatomico, che però mette in discussione la possibilità di un determinismo nella fisica, ci dà un’indicazione straordinaria, dà a tutti un’indicazione straordinaria, che noi non abbiamo seguito fino in fondo. Ho avuto discussioni feroci sul determinismo che era implicito dentro agli insegnamenti del Politecnico, e anche sulla concezione della matematica e della fisica come materie che insegnano a essere lineari nei propri ragionamenti. Per uno storico il concetto di linearità non esiste, esiste la discontinuità proprio come concetto fondamentale della storia dell’umanità. Ecco, Fisica e Filosofia e la vicenda del suo autore ci dicono tantissime cose, fondamentali anche per l’oggi della nostra scuola.
JCDeM: Concordo pienamente, anche perché il determinismo che tu hai riscontrato entrando al Politecnico continua ad esserci anche oggi, anche se in forme in parte diverse. Questo libro, quindi, potrebbe innescare una riflessione di grande utilità in un momento in cui, per fare un esempio legato alla mia disciplina, l’ingegneria informatica, c’è una spiccata tendenza a credere che – grazie ai “big data” – sia possibile conoscere e capire tutto, o quasi.
Passiamo ora al terzo libro. Dopo un grande scienziato ottocentesco come Charles Darwin, e un grande fisico sui generis novecentesco come Werner Heisenberg, arriviamo a un terzo autore che è difficile richiudere dentro precisi confini disciplinari. Mi riferisco a Karl Polanyi e al suo straordinario libro, La grande trasformazione, pubblicato in lingua inglese sul finire della Seconda Guerra Mondiale e giunto in Italia nel 1974. Perché a tuo avviso La grande trasformazione è un libro importante per la cultura politecnica?
CO: La Grande Trasformazione è il libro, di nuovo, di una persona interessata da una vicenda che se non si racconta non si capisce neanche il libro. Ungherese, Polanyi partecipa alle vicende della Vienna Rossa in Austria, entra in questo mondo straordinario: Vienna in quegli anni era ancora la capitale del mondo, più di Parigi. Il dubbio che avevo è stato l'unico dubbio che ho avuto sui cinque libri: il libro che mi manca di più in questo elenco è un libro di Freud, L'elaborazione del lutto, ma sarebbe stato veramente complicato spiegarne l'utilità, non per le persone, ma per la scuola politecnica.
Lui elabora questo libro, mano a mano che fa queste esperienze: lui fa parte di quel movimento che si chiama austro–marxismo, questa esperienza che, diciamo, che è collocata tra il socialismo e la concezione umanistica, che avviene in quegli anni a dei personaggi che la rappresentano, dalla psicanalisi alla logica-matematica. Questo libro, dicevamo, viene elaborato tra Inghilterra e Stati Uniti quando lui, al tempo del colpo di stato e con l'annessione dell'Austria allo stato nazista, è costretto ad andarsene. Questo libro, lo ricordiamo, lui è un antropologo, descrive i comportamenti e l'economia dello scambio in alcune popolazioni che allora si chiamavano primitive (oggi il termine sembra politically scorrect) con una raffinatezza straordinaria. Lui aveva un grande amico, un riferimento, questo antropologo che si chiama Bronslaw Malinowski, altro autore che bisognerebbe che gli studenti leggessero.
La Grande Trasformazione, di nuovo, è un libro che non a caso oggi viene quasi assunto come riferimento nel momento in cui siamo – come dice lui – al completo dominio dell'economia sulla società. Il libro si fonda su una serie di elementi che in una scuola politecnica dovrebbero essere il centro della riflessione: noi lavoriamo, costruiamo delle soluzioni per l'economia, per l'industria che poi fa profitti, che poi vende, crea merci, induce bisogni, o lavoriamo anche per una società che ha bisogni, desideri, necessità, povertà, diseguaglianza? Polanyi sta tutto dalla seconda parte: attenzione – ci dice – il capitalismo è un'istituzione storica (nel suo libro ne ricostruisce la genesi come istituzione), il mercato è una produzione storica, non è non è il destino, non sostituisce dio – nonostante possiamo dire che teologi del mercato ne abbiamo avuti a iosa. E soprattutto per due ragioni di fondo, lui dice: perché sfrutta e usa indiscriminatamente le due risorse fondamentali che costruiscono la possibilità, attraverso un'economia sociale di mercato, di rispondere agli uomini e alla natura.
Polanyi è così centrale oggi, che noi parliamo di green e usiamo queste parole come se fossero senza storia e senza significato, perché dobbiamo costruire, progettare sistemi, risposte, soluzioni che abbiano come riferimento gli uomini, i loro bisogni, la loro vita, la loro salute (questo oggi come oggi, ma domani si tratterà di diseguaglianza, accessibilità, cultura, eccetera) e dobbiamo dall'altro lato introdurre un uso completamente diverso della natura. Pensate che muore nel ‘64, quindi parliamo veramente di mezzo secolo fa. È lucidissimo su questa cosa, e ben prima del famosissimo libro, dopo lo choc petrolifero, sulla crescita zero: lui non dice semplicemente crescita zero, ma sostiene la sua teoria, su una base straordinaria di esperienze. Karl Polanyi – ed è per questo che per noi è importante – non è un teorico, è uno che è stato in Africa fare indagini, ha studiato come funzionavano le economie di scambio, in cui si scambiavano oggetti e valori in funzione dei bisogni e del rispetto dell'ambiente naturale che soddisfa quei bisogni. Svolge indagini, costruisce strumenti e poi formula una teoria: di nuovo ci conferma, su altre basi, lo stesso processo che noi dovremmo sempre seguire nell'insegnamento e nella natura degli atenei politecnici.
Nell'esperienza che tu hai ricordato dell’ISSU due sono stati due i momenti fondativi questa esperienza: uno è stato il rapporto con il dipartimento di Humanities dell’MIT, con il suo direttore – che allora era Kenneth Keniston – e l'altro è stato il rapporto con la Maison des science de l’hommes, con il suo direttore – che era Maurice Aymard. In tutte e due queste esperienze, che hanno portato a seminari, lezioni, a tutta una serie di iniziative e attività, il centro era il fatto che qualsiasi sapere umano che abbia la pretesa di definirsi scientifico ha alcune caratteristiche che deve seguire: essere sperimentale, probabilista e non determinista, avere un campo su cui esprimere la propria sperimentalità, costruire degli strumenti epistemici, conoscitivi, che siano all'altezza di quello che indaga, a formulare una teoria, e metterla alla prova. Questo vale in qualsiasi settore in cui il Politecnico si muove, facendo attenzione al fatto che il metterlo alla prova non significa una autoreferenzialità di questo processo: la prova comprende uomini e natura, non è riferita solo alla funzionalità di quel sistema meccanico, chimico, aeronautico; essa comprende la società. D'altro canto il Politecnico è nato con al suo interno il laboratorio Cognetti de Martis, all’interno del quale prende forma l'economia politica italiana, dove studia Luigi Einaudi (che era Presidente della Repubblica) e in cui si fonda una dottrina che non è il liberismo di oggi, che, per quanto anch’esso mi faccia dubitare, era un liberismo del tutto diverso, che escludeva, ad esempio il mondo della finanza dall’economia. Un saggio bellissimo di Luigi Einaudi è sul sesto acro di Chicago: qui Einaudi fa l'analisi del processo di valorizzazione (sapete che Chicago brucia completamente nel 1866: era tutta costruita in legno e viene ricostruita con nuove tecniche, sperimentando i grattacieli) di un sesto di acro che non viene ricostruito; il proprietario di questo sesto di acro, che è al centro della erigenda città, lo mantiene così fino al 1900, per poi venderlo – qualcosa di poco di più di 200 metri quadrati – ad un milione di dollari. Einaudi scrive: questo è inaccettabile, è inaccettabile che qualcuno usi il lavoro degli altri, gli sforzi, i rischi per arricchirsi.
Karl Polanyi è la sintesi più importante che abbiamo oggi. Abbiamo sempre bisogno di simili riferimenti: la storia serve a questo, a sondare le riflessioni di oggi. Certo, non solo La Grande Trasformazione, ma questo libro in particolare ci aiuta a rilanciare una riflessione su una situazione, come quella di oggi, che è al limite del collasso ambientale, sociale, economico e anche medico.
JCDeM: Il quarto e il quinto libro sono di due storici. Il primo è di un sommo studioso del Novecento, Fernand Braudel, con il suo capolavoro sul Mediterraneo. Perché secondo te è importante per la cultura politecnica? Perché ci raccomandi di leggerlo?
CO: Faccio un minimo la storia del libro e ti rispondo. Come sapete Braudel scrive le bozze di questo libro che consegna a sua moglie mentre lui era internato in un campo di concentramento negli anni ‘40. Lui si salva – a differenza di Marc Bloch che viene ucciso dai nazisti – e nel 1945 comincia la stesura di questa che è una tesi di dottorato di stato. Tanto per fare facile ironia sull’oggi: in Francia, fino ad alcuni anni fa, per diventare professori universitari bisognava scrivere una tesi di dottorato di stato in cui c'era una soglia quantitativa che per noi è inimmaginabile, perché era sopra le 800 pagine. Pensate che noi oggi facciamo articoli di otto pagine: io credo che se uno sa scrivere non 800, ma anche solo 200 pagine, forse, può fare il professore universitario, ma questa è una mia idea del tutto fuori moda.
Ma perché questo è così importante? Perché un libro – non in una delle tante edizioni ridotte, ma nella sua edizione nei due volumi che costituiscono la tesi di dottorato di stato (uscito nel ‘49 e tradotto in italiano nel ‘53) – sulla civiltà materiale, l'economia e la società del Mediterraneo tra ‘400 e ‘700 è così importante?
Noi spesso usiamo nel nostro linguaggio comune il Mediterraneo come fosse una parola senza padroni. Tutti noi ci definiamo figli del mare nostrum, della cultura mediterranea. Uno dei miei più cari amici, Francois Hartog, ha scritto recentemente un libro dal titolo che sembra nostalgico, Il ritorno alla Grecia, alimentando questo flusso continuo di memoria (e poi la Grecia la trattiamo come l'abbiamo trattata, come l'Europa la ha trattata qualche anno fa).
Cosa fa Braudel? Braudel parte dalla storia politica di Filippo II: e in questo è proprio dentro una concezione della storia che ha gli uomini politici e la storia militare come grandi protagonisti. Nello scrivere il suo libro, Braudel ribalta completamente questa storia: ci racconta un Mediterraneo fatto di strade, mercati, città, scambi, che ci aiuta a capire, ad esempio, il ruolo dei commerci di Venezia o della battaglia di Lepanto nella creazione delle basi della civiltà occidentale, così come il mercato di Ostia (posto straordinario che lui mi ha portato a vedere) o il Palazzo di Diocleziano di Spalato.
Il Mediterraneo di Braudel è davvero la spiegazione, per tutti noi, oggi, del fatto che la cultura ha delle radici unitarie, che si sviluppano in un contesto geografico, tra l’altro molto conflittuale, perché il Mediterraneo è sempre stato un mondo conflittuale, e oggi lo è ancor di più: il conflitto fa parte della concezione storiografica e teorica del Mediterraneo. La cultura ha anche radici completamente differenti: quando racconta le strade attraverso cui passano le merci e le tecnologie che si usano per costruire le strade, e come le merci creano ricchezza e povertà, come questo mondo sia un modo in continuo dinamismo. Tutti i saperi di coloro che vivono in questo mondo politecnico, dove convivono architetti e ingegneri, di cui Braudel fornisce in alcuni passaggi descrizioni meravigliose, considerandoli i costruttori (termine forse oggi inappropriato), ci spiegano come il Mediteraneo sia insieme una realtà e un progetto (io con lui ho discusso lungamente di questa doppia anima del suo libro che è straordinaria). Da storico, fa il racconto di un processo, con tutti i suoi conflitti e contraddizioni, ma anche di un progetto che continua a evolvere e a divenire sempre più egemone.
La nostra cultura ha debiti infiniti con le culture che sul Mediterraneo si sono sviluppate: da quella giudaico–cristiana a quella greca, da quella romana a quella bizantina, fino anche alla cultura islamica più colta, che si sviluppa lungo tutta la sponda sud del Mediterraneo, ma che poi trova nella Cordoba del 1200 la sintesi forse più straordinaria di tutti quanti questi aspetti. La sintesi vera, più profonda delle due culture, ci dice una cosa molto importante (e proprio il libro di Snow del 1964 che sulle due culture è basato su una concezione della cultura che non è che quella che ha lui): che i grandi matematici arabi a Cordoba lavorano con i filosofi più raffinati – che hanno come principio quel fantastico testo che è La guida dei Perplessi, precoce versione se volessimo scherzare del princio di indeterminazione – ma anche con gli architetti che costruiscono 7 moschee una sull'altra, una più straordinaria dell'altra. Forse allora anche ‘le due culture’ è un prodotto storico di una divisione che si realizza nel ‘700 (questa è una delle sue principali tesi, che poi svilupperà nell’ultimo dei tre libri che ho citato prima e che vengono pubblicati negli anni ’70).
JCDeM: Siamo arrivati al quinto e ultimo libro, un’opera dello storico Marino Berengo, L'Europa delle Città, pubblicato da Einaudi nel 1999. Osservo che si tratta di un libro che nonostante sia così importante è quasi introvabile; si trova solo – e a fatica – nel mercato dell’usato, oltre che ovviamente nelle biblioteche (che il cielo le preservi). Perché hai scelto, per concludere questo ciclo sulla cultura politecnica, L'Europa delle Città di Berengo?
CO: La ragione è proprio nella tesi di fondo che Marino Berengo ci propone, come solo uno straordinario storico poteva fare, In realtà Marino Berengo ha scritto altri libri molto interessanti, proprio per le radici della scuola politecnica, come Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione. Berengo, per chi non lo conosce, è uno storico essenzialmente di tutta l'epoca moderna, ma in particolare del Settecento. Ho voluto scegliere questo testo perché noi, in quanto cittadini e noi come scuola politecnica, siamo in una fase estremamente delicata, fase in cui sta risorgendo l'idea che possa esistere un concetto di organizzazione statuale fondato su un'invenzione come sono le regioni – la cui più antica definizione è quella dei dipartimenti della Rivoluzione Francese, che ha faticato enormemente ad affermarsi – e sulla loro coesistenza con lo Stato e, come terzo inquilino estremamente scomodo, la globalizzazione (il fatto che il mondo sia unico).
Il libro di Berengo si fonda su una affermazione e poi sul tentativo – anche questo una sperimentazione che è quella tipica dello storico – di dimostrare che questa tesi di fondo ha un sostegno. La tesi di fondo è che l'Europa esiste come tale perché ha avuto una storia costruita sulle città. Naturalmente uno dice ‘sulle città’ e pensa di aver risolto il problema. Ma il vero problema nasce con questa affermazione: cosa sono le città, e qual è il rapporto che esiste tra città e altre dimensioni geografiche e giuridico–istituzionali? Marino Berengo in questo libro offre a tutti noi una straordinaria serie di spunti per riuscire a definire cosa distingua una città e perché le città siano state la culla dell’Europa.
Noi sappiamo che le scuole, anche il Politecnico, sono radicate nella città, il nostro Politecnico a Torino. Non a caso, anche se la nostra scuola ha l’ambizione di rivolgersi a un pubblico potenzialmente molto più allargato, lo può fare perché è a Torino, che ha non solo le sue radici storiche, culturali, scientifiche, ma che ha maturato quell’ insieme di valori che Berengo pone alla base del concetto di città.
Non è facile definire cosa sia una città, ancor più difficile farlo in un arco temporale che copre tutta l’età moderna. Senza questa definizione, tuttavia, oggi noi non ce la caveremmo: se non abbiamo l'idea che la città non è la comunità, che la città non è l'istituzione che fa funzionare i servizi per i cittadini, che la città non sono solo le sue mura (andando indietro, che nel tempo sono costruite da quelle militari a quelle fiscali), ma che la città è un insieme di opportunità che solo nella città si possono realizzare, di incontri.
Perché nella città si concentrano lo sviluppo culturale, musicale, tecnologico, artistico (nessun movimento artistico è nato in campagna)? Perché si creano opportunità di incontri, e più le città sono ricche di strutture che questi incontri facilitano, più questi incontri sono importanti e creano intrecci, incroci, possibilità di scambio, di quello che io chiamavo con lui ‘meticciato’. Le città sono il miglior esempio del ‘meticciato’ ed è questo il nodo centrale.
Certo, le città sono sempre stati i luoghi delle università: luoghi nei quali le culture religiose hanno espresso il meglio di sé. Il dibattito che si svolge a Siviglia nel 1555 tra un domenicano e un gesuita sulla natura dell’essere umano – facendo riferimento ai popoli indigeni – non poteva che svolgersi nella vera capitale della Spagna di quegli anni, così come Cordoba nel Duecento.
Certo, è impensabile che la nascita delle borse avvenisse al di fuori di una città e di Amsterdam in particolare. La prima borsa di merci e danaro riconosciuta come tale nasce in una città grazie a una straordinaria scienziata, che ha avuto due Premi Nobel, che è Madame Curie, e nasce all’Istituto Pasteur che diventerà oggi uno dei posti più importanti per la nostra sopravvivenza. La città offre queste opportunità, e se noi non abbiamo una cultura della città non possiamo avere chiaro a chi trasferire il nostro sapere, quale sia il contesto in grado di recepire e trasformare.
Perché il Politecnico si è creato e ha stabilito le sue le sue diverse e emanazioni in altri luoghi? Come mai Boston è diventato il centro della ricerca americana dopo che aveva tentato di decentrare le sue attività e adesso, insieme alle vallate californiane, è diventato sinonimo di quel che si pensa essere un’innovazione tecnologica? Perché, come è successo molto di recente, quando i grandi imperatori di oggi (Google et al.) hanno cercato di concentrare in un unico luogo – naturalmente progettato dall’archistar più celebre del momento – le persone, le innovazioni, la cultura e di cingere questi luoghi con mura informatiche, i più importanti tra coloro che dovevano essere rinchiusi sono ritornati nelle coste dell’est dichiarando di voler vivere in città (meglio Atlanta della Versailles che gli avevano preparato nell’altro mondo). Anche il più raffinato tecnologo e scienziato sceglie di vivere nella città; lo diceva Einstein in modo mirabile: anche le idee ti vengono camminando (in riferimento allo straordinario testo Camminare di Thoreau, padre della concezione americana della vita).
Solo in città possiamo realizzare quell’incontro necessario tra lo sviluppo di una serie di conoscenze e la misura che questi ci possono dare della loro capacità di trasformare un oggetto non tecnico, ma socio-tecnico, così come lo avrebbe chiamato Kenniston riferendosi alla società che fa uso di quell’oggetto. Perché ho scelto questo libro, per concludere? Nessuno mai leggerebbe un libro di quelle dimensioni, oggi più che mai che non siamo abituati a leggere gli articoli di giornale sul nostro Ipad o sul nostro Iphone. Quel libro è il frutto di una vita di lavoro, il frutto di una messa alla prova delle sue affermazioni nel mondo nostro, cioè nel mondo degli archivi, delle fonti, dei documenti incrociati, confrontati. In archivio si combatte, non si va a giustificare o certificare quello che si pensa, si mettono alla prova ipotesi storiche, economiche, culturali e generali. C’è un bellissimo libro, Histoire de la vie quotidienne, che spiega la storia quotidiana della città di Parigi e della società parigina partendo dalla vita quotidiana piuttosto che dalle istituzioni, dalle scuole, dalle culture, dai libri e via dicendo.
Io credo che avere come ambizione, per un professore universitario che sia degno di questo nome, la scrittura di un libro che sia anche la metà di quello di Berengo debba divenire precondizione al suo mantenimento come docente.
Questo pensiero deve essere un pensiero che in qualche modo noi dobbiamo poter leggere, discutere, accettare, non accettare, farne oggetto di polemica. Questo, tuttavia, non su un frammento di pensiero, ma su una organizzazione, tanto più importante quanto più noi lavoriamo in una scuola in cui la struttura di relazione – come la chiamava Husserl, grande filosofo che racconta la crisi delle scienze europee nel Novecento – è il fondamento della nostra cultura. Noi costruiamo strutture di relazione tra i principi etici, sociali, economici, le pratiche, il tutto attraverso dei progetti.
Il Politecnico è una scuola che in tutte le sue dimensioni ha sempre progettato, e il progetto si fa per un fine.
È difficile che si progetti, si restauri o si conservi qualcosa senza fine. Solo una società di feticisti conserva oggetti o manufatti che non abbiano una finalità. E se non vogliamo diventare dei feticisti dobbiamo imparare la capacità che hanno questi cinque libri di mettere in relazione gli infiniti problemi quotidiani, dobbiamo arrivare a questi livelli. A questi livelli si arriva solo scrivendo, e la scrittura, lo volevo dire proprio in conclusione, non è un dono di Dio. A scrivere e si impara, e si impara che ci sono scritture diverse; si scrive in un modo quando ci si rivolge a una comunità scientifica, in un altro quando ci si rivolge a un pubblico più allargato, quando si parla con gli studenti, quando si scrive per la didattica. La scrittura è il sistema di comunicazione più raffinato di cui l’uomo disponga, perché rimane nel tempo, perché poi quella scrittura diventa autonoma dall’autore e può essere riletta, ricollocata, ripensata, ridiscussa, contestata e confutata da altri. Insegniamo a scrivere, oltre che a leggere.
JCDeM: Il professor Carlo Olmo ha concluso come meglio non si poteva fare questa prima puntata di 5 libri. A mia volta concludo ricordando a tutti che i cinque libri sulla cultura politecnica sono disponibili nelle biblioteche del Politecnico. E grazie al prof. Olmo per il suo tempo, per la sua amicizia e per il contributo che ha dato – e che continua a dare – al Politecnico.
CO: Grazie a te Juan Carlos e grazie a voi tutti.