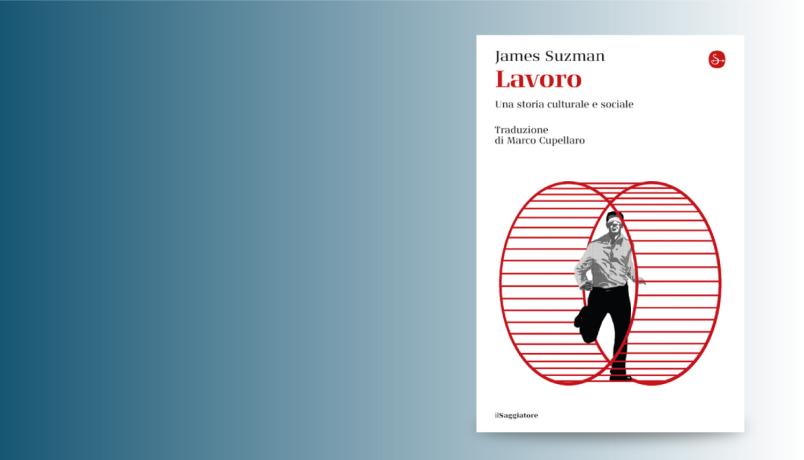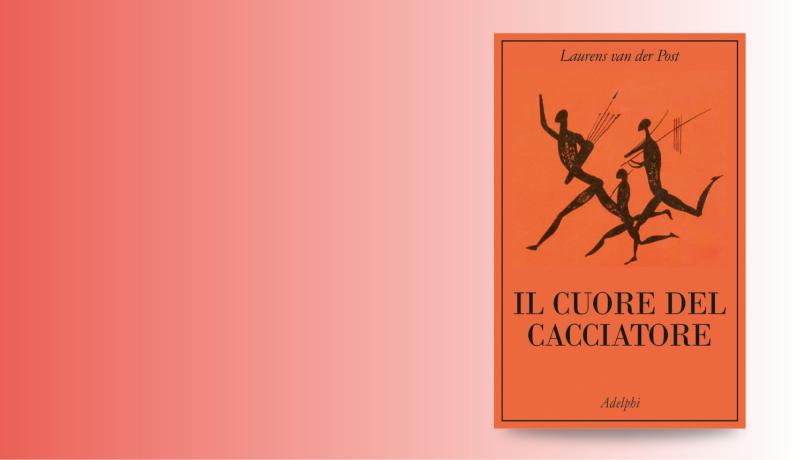Chi è Francesco Remotti

Professore emerito di Antropologia culturale, socio dell’Accademia delle Scienze di Torino e dell’Accademia dei Lincei, ha compiuto ricerche etnografiche tra i Banande del Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo) e ricerche etno-storiche sui regni dell’Africa equatoriale. Ha sviluppato riflessioni teoriche sui concetti di identità e somiglianza, nonché sulla teoria dell’antropo-poiesi. Di recente si è occupato di umorismo in ambito teologico e mitologico. Tra le pubblicazioni più significative: Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia (Bollati Boringhieri 20092); L’ossessione identitaria (Laterza 2010); Cultura. Dalla complessità all’impoverimento (Laterza 2011); Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi (Laterza 2013); Somiglianze. Una via per la convivenza (Laterza 2019); con M. Bettini e M. Raveri, Ridere degli dèi, ridere con gli dèi. L’umorismo teologico (il Mulino, 2020); con M. Aime e A. Favole, Il mondo che avrete. Virus, Antropocene. Rivoluzione (UTET, 2020).
“L’ultimo Sapiens. Viaggio al termine della nostra specie”

Gianfranco Pacchioni - il Mulino
“Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’Antropocene”

Simon L. Lewis, Mark A. Maslin - Giulio Einaudi editore
Mattia Plazio (MP)
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della serie “Cinque Libri” che, per chi ancora non la conoscesse, è un’iniziativa promossa dal Politecnico di Torino che vede protagonisti importanti esponenti del mondo della cultura, chiamati di volta in volta a scegliere un argomento di interesse per la comunità politecnica – ma non solo – e, quindi, i cinque libri che raccontano e analizzano meglio quello stesso argomento. Oggi siamo in compagnia di un ospite di eccezione a cui dò un caloroso benvenuto e che ringrazio davvero molto per la disponibilità: il Professor Francesco Remotti, tra i più autorevoli antropologi italiani, professore emerito di Antropologia culturale all’Università di Torino, socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dell’Accademia delle Scienze di Torino, oltre che autore di numerosi saggi che affrontano i temi, ma soprattutto le domande più significative alla base di una disciplina che, prima di ogni altra cosa, ama interrogarsi incessantemente su quella strana creatura che è l’essere umano. Il professor Remotti, oggi, ci introdurrà dunque con un taglio trasversale al mondo dell’antropologia culturale, che ha naturalmente molto da dire sul rapporto tra essere umano, tecnica e natura, e lo farà illustrando e commentando questi cinque libri che abbiamo di fronte a noi. Bene, professore, da dove vogliamo cominciare? Prima di scendere nello specifico del primo dei cinque libri scelti, possiamo forse partire dal titolo che ha significativamente dato a questa puntata, ovvero “Espedienti, manipolazioni, cumuli, trappole: la cultura di Homo sapiens”. La ascoltiamo, Professore.
Prof. Francesco Remotti (FR)
Sì, forse la domanda iniziale è proprio quella che riguarda il titolo, che è un titolo un po’ composito e che, quindi, va spiegato. Intanto, il sottotitolo chiarisce subito che intendo occuparmi della cultura di Homo sapiens, ma specialmente della cultura di Homo sapiens quale oggi si presenta. Ho scelto poi questi termini - espedienti, manipolazioni, cumuli, trappole - proprio per delineare un percorso tematico. La cultura, comunque essa venga intesa, è infatti prima di tutto una serie di espedienti. E, in particolare, per quanto riguarda Homo sapiens è facile dire che Homo sapiens se l’è cavata grazie alla cultura. Vale a dire, secondo una formula ormai molto diffusa: Homo sapiens era una preda collocata nelle savane dell’Africa orientale e se l’è cavata facendo ricorso alla cultura. Ma quale cultura? Non certamente la cultura come la intendiamo oggi, quella umanistica o scientifica, ma cultura nel senso di tecnologia. Homo sapiens, grazie alla tecnologia e ai suoi strumenti, ha ribaltato la sua situazione: da preda dei grandi felini, che si trovavano in Africa circa 200-250.000 anni fa, è diventato predatore. Vedremo poi meglio quali sono questi strumenti tecnologici. Manipolazioni, subito dopo, perché con questi strumenti Homo sapiens ha dato luogo a operazioni più o meno complesse di manipolazione dell’ambiente, degli oggetti, dei prodotti, ma anche dei rapporti sociali. Poi, cumuli: cumuli allude al fatto che la cultura di Homo sapiens, a differenza delle culture che noi troviamo nelle altre specie animali – perché diciamolo subito: anche molte altre specie animali dispongono di comportamenti culturali, cioè di comportamenti socialmente appresi – è una cultura cumulativa: ovvero c’è un “progresso”. La cultura di Homo sapiens accumula una serie di risorse, mentre invece quella delle altre specie animali è una cultura sostanzialmente stazionaria. Ecco allora che si formano quindi dei cumuli di cultura. Ma spesso questi cumuli si rivelano essere delle trappole e, in fondo, tutti questi libri di cui andremo a discutere ci parlano proprio delle trappole in cui, noi Homo sapiens, siamo finiti oggi.
MP
Bene, allora possiamo forse partire dal primo di questi libri: “L’ultimo Sapiens. Viaggio al termine della nostra specie” di Gianfranco Pacchioni, un chimico che insegna all’Università di Milano.
FR
Sì, ed è anche lui membro dell’Accademia dei Lincei. Pacchioni ha scritto questo libro che già dal titolo, “L’ultimo sapiens”, inquieta. Inquieta perché – e vado subito alla tesi sostenuta nel libro – Pacchioni ci dice che con gli sviluppi della tecnologia attuale stiamo creando sempre di più una specie di tecno-sapiens; e noi, che siamo semplici sapiens, stiamo diventando sempre più dei vetero-sapiens, ovvero i sapiens di una volta. Perché Pacchioni dice questo? Intanto, voglio dire cosa prima di dimenticarmela: all’inizio di ogni capitolo di questo libro, che tra l’altro si legge con grande piacere perché è scritto in maniera molto arguta e accattivante, Pacchioni fa riferimento a dei brani di Primo Levi, chimico anche lui; si rivolge però non al Levi di “Se questo è un uomo” o “I sommersi e salvati”, ma a quello degli scritti letterari, dei racconti, in cui l’autore torinese tira fuori la sua cultura da chimico. Detto questo, quello che Gianfranco Pacchioni intende sostenere è che noi, con la nostra tecnologia attuale, stiamo producendo, costruendo, creando delle macchine che sempre più ci assomigliano. Non sono più macchine a cui fare ricorso per spostarsi, per agevolare la nostra mobilità, o almeno non solo, ma macchine che utilizzano in modo sempre più massiccio sistemi di intelligenza artificiale. E, sempre più, noi vediamo come questi “prodotti”, basati sull’intelligenza artificiale, si stanno comportando esattamente come Homo sapiens. Qual’ è il punto di svolta, rispetto per esempio al computer, che siamo ormai abituati a usare tutti i giorni per le nostre attività? Pacchioni dice che mentre il computer, sostanzialmente, fa sempre le solite cose, cose certamente meravigliose, questi prodotti basati sull’intelligenza artificiale hanno la caratteristica di apprendere: nel momento stesso in cui funzionano apprendono dall’esperienza. E, per questo, sono prodotti sempre più simili a noi. Per esempio: ci sono intelligenze artificiali che sono in grado di produrre delle cantate di Bach. Qualcuno potrebbe dire, beh le cantate di Bach esistono già e quindi non si tratta nient’altro che di una riproduzione. No, non si tratta di una copia, si tratta di una nuova invenzione, con stile bachiano. È impressionante. Così come sono in grado di creare poesie, di fare arte. Questi prodotti, nella misura in cui entrano in collegamento tra di loro, danno luogo a delle reti che stanno assumendo una sempre maggiore autonomia rispetto a noi che siamo stati i loro creatori. E questo naturalmente crea una situazione di inquietudine, perché stiamo vedendo che sempre più le nostre creature stanno prendendo un po’ il nostro posto. A questo proposito, faccio un riferimento che Pacchioni non fa: ci ricordiamo del libro della “Genesi”? La divinità cosa dice ai nostri due progenitori? Dice: mi raccomando non cibatevi dell’albero della conoscenza. Loro, invece, se ne sono sono cibati. E quindi la divinità cosa dice? Ecco, ora sono diventati simili a noi. E poi dice: non toccate però l’albero della vita, cacciandoli quindi dall’Eden. Noi in fondo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un lungo percorso in cui non solo ci siamo cibati e continuiamo a cibarci dell’albero della conoscenza, cumulativamente, ma abbiamo messo ormai le mani anche sulla vita e abbiamo dato luogo a dei prodotti vitali, dove l’ingegneria si combina con la biologia. La divinità del VI secolo a.C., quale appare nella “Genesi”, aveva già intravisto una cosa di questo genere e se ne era preoccupata.
MP
Si può quindi parlare di una sorta di destino antropologico, in tutto questo percorso?
FR
No, se destino ha un significato di necessità direi di no. Non era necessario che le cose andassero così. Sono andate così per tutta una serie di motivi, che vedremo anche discutendo degli altri libri, ma sostenere che l’umanità era destinata a compiere questo percorso, no, lo escluderei.
MP
Possiamo allora passare al secondo libro, che è “Il gesto e la parola” di André Leroi-Gourhan. Qui torniamo forse un po’ indietro, trattandosi di un libro la cui edizione originale, se non sbaglio, risale agli anni Sessanta del Novecento, e che ha poi visto una serie di ripubblicazioni. Ecco, il gesto e la parola: un titolo evocativo.
FR
La domanda, che è un po’ contenuta nella sua osservazione, è proprio questa: perché tirare fuori ora un libro pubblicato la prima volta nel 1964? Questi ultimi decenni, d’altronde, sono stati decisivi per le problematiche di cui tratta anche Pacchioni nel suo libro. Che senso ha, quindi, affrontare i temi di un libro che potrebbe apparire come superato? Beh, io l’ho proposto intanto perché è stato ripubblicato in questi anni dall’editore Mimesis. Ma poi perché questo libro del 1964, pur scontando tutta una serie di aspetti che, come dire, in questi decenni sono emersi, e di cui Leroi-Gourhan non poteva certo avere contezza, è un libro che si accorda perfettamente con la visione di Pacchioni. Abbiamo visto che Pacchioni sostiene che noi rischiamo di diventare dei vetero-sapiens, dal momento che sta emergendo una nuova specie tecnologica, o meglio biotecnologica. Ebbene, guarda caso, Leroi-Gourhan, nel 1964, aveva esattamente previsto tutto questo, o meglio ipotizzato una cosa di questo genere. Ma Leroi-Gourhan è importante soprattutto per la sua impostazione, che merita tuttora molta attenzione, e che peraltro è stata poi confermata da molti altri studiosi dopo di lui. Impostazione relativa a che cosa? A quello che potremmo chiamare la genesi e lo sviluppo della specie umana, e di Homo sapiens in particolare. Già il titolo del libro di Leroi-Gourhan, “Il gesto e la parola”, è paradigmatico: da una parte il gesto che è, appunto, l'uso delle mani, e dall’altra la parola, che rappresenta la dimensione del linguaggio, la dimensione simbolica. Nel primo di questi due volumi, Leroi-Gourhan mette in luce esattamente questo parallelismo tra l'uso delle mani e la parola. Un parallelismo dovuto al fatto che entrambe queste acquisizioni sono dovute alla stazione eretta, ovvero al fatto che a un certo momento, prima di Homo sapiens - pensiamo alla denominazione Homo erectus, che è una specie del genere Homo che precede ovviamente Homo sapiens -, l'uomo ha cominciato a camminare su due piedi, e questo ha rappresentato un punto di svolta. Perché? C'è una frase di Leroi-Gourhan molto bella che dice: “ci saremmo aspettati di tutto, ma non di essere cominciati dai piedi”. Sembra strano ma è così: tutta la nostra storia è cominciata dai piedi, i piedi sono stati la cosa più importante del nostro sviluppo. Tutto questo per dire che la stazione eretta, il bipedismo, e quindi il camminare, ha dato luogo a che cosa? Qui c'è un termine, un concetto, che è anche poi una prospettiva che Leroi-Gourhan utilizza nel suo discorso, lungo tutto il suo libro, che è liberazione. Con la stazione eretta, quell'animale che era il nostro antenato, ha liberato sia gli arti superiori, ovvero le mani, sia la bocca. E, infatti, se noi osserviamo il comportamento dei nostri “cugini”, dei primati più vicini a noi, intendo dire scimpanzé, gorilla, orangutan, noi vediamo che, sebbene questi possano alle volte adottare la stazione eretta, per lo più camminano a quattro zampe. I loro arti superiori sono quindi impegnati in questa attività. Di conseguenza, questi primati usano la bocca per portare degli oggetti, per cercare il cibo, ecc. Ebbene, l'adozione della stazione eretta in maniera - diciamo così - biologicamente, anatomicamente programmatica, diventa assolutamente fondamentale perché consente la liberazione delle mani, ora in grado di dar luogo alla produzione di una cultura materiale che noi certamente non troviamo tra gli scimpanzé o i bonobo (gli scimpanzé al massimo usano dei rametti per prendere le termiti nel termitaio, ma non arrivano a usare le lance o l'arco e le frecce). Liberazione delle mani, e quindi liberazione della bocca, che attraverso la fonazione, è capace ora di dar luogo a un linguaggio articolato. E qui, di nuovo, noi ci distinguiamo in maniera netta da tutti i sistemi di comunicazione delle altre specie animali, che - secondo i linguisti - sono sistemi chiusi: a un determinato suono corrisponde un determinato significato, ad esempio “attenzione che sta arrivando il leopardo”. Il nostro sistema di comunicazione, invece, è un sistema decisamente aperto. Cioè, noi ogni momento innoviamo questo sistema e lo innoviamo persino con le bugie. Anche gli scimpanzé mettono in atto piccoli inganni, ma il raccontare bugie attraverso il linguaggio è una cosa tipicamente umana. A noi potrebbe sembrare un po’ stupido, una cosa di poca importanza, tutt’al più un difetto, ma in realtà raccontare bugie è la manifestazione della creatività del linguaggio. Con il linguaggio, dunque, da una parte nasce la cultura materiale, la manipolazione, dall'altra la dimensione simbolica, se è vero come è vero che il linguaggio crea dei mondi e i simboli che lo rappresentano. L'altro concetto assolutamente fondamentale di cui Leroi-Gourhan tratta nel suo libro è quello della esteriorizzazione. Con il concetto di esteriorizzazione Leroi-Gourhan ci fa capire che la nostra cultura, la cultura che produciamo noi, Homo sapiens, ha la caratteristica di essere esteriorizzata, cioè di essere portata fuori. Dove esiste la cultura? La cultura esiste tra noi. Esiste anche dentro ciascuno di noi, certamente, ma esiste in noi perché prima esiste tra noi, cioè esiste nello spazio esterno ai corpi. Esiste nelle relazioni. Il linguaggio esiste nella società. La scrittura è un'altra cosa, la scrittura interviene molto più tardi. Noi qui parliamo del linguaggio senza pensare alla scrittura, anche se la stessa scrittura è in fin dei conti un potenziamento della esteriorizzazione, laddove, per esempio con la stampa, i testi vengono depositati in un supporto esterno e replicati cumulativamente. Ecco, concludo questa parte su “Il gesto e la parola” dicendo che Leroi-Gourhan, già nel 1964, aveva previsto che questo processo di esteriorizzazione proseguisse ulteriormente, dando luogo esattamente a ciò che racconta anche Pacchioni nel suo “L’ultimo Sapiens”, ovvero all’esteriorizzazione non solo della nostra memoria, ma anche della nostra intelligenza. Nel 1964 Leroi-Gourhan già si riferiva ai programmi di tipo elettronico e sosteneva che quanto più questi prodotti diventano autonomi, tanto più noi diventiamo una specie obsoleta. Quindi è praticamente lo stesso ragionamento di Pacchioni. Per questo mi sono permesso di proporvi all'attenzione un autore che a me piace molto.
MP
Professore, passiamo allora al terzo libro che ha scelto per noi, che è il libro di James Suzman “Lavoro. Una storia culturale e sociale”. Qui torniamo anche un po’ all'oggi, ponendoci forse una domanda che, sotto traccia, è presente in questo libro: lavoriamo per vivere o viviamo per lavorare?
FR
Sì, torniamo all'oggi, anche se il libro di Suzman, come in realtà quasi tutti i libri di cui parliamo oggi, parte dalle società di caccia e raccolta. Precisiamo subito una cosa: Suzman è sudafricano, è un antropologo che ha studiato presso i Boscimani del deserto del Kalahari, su cui poi torneremo, soprattutto con “Il cuore del cacciatore” di Laurens van der Post. Lo sguardo di Suzman è uno sguardo sulle diverse tappe della storia dell'umanità e su come sono state affrontate da Homo sapiens. Quindi, certo, la preoccupazione di Suzman e di tutti questi autori è certamente quella di interrogarsi sul presente, ma partendo sempre dal passato, dalle società di caccia e raccolta. Suzman, nel suo libro, dà questa definizione del lavoro, una definizione abbastanza semplice che credo possiamo adottare anche noi: il lavoro è qualsiasi impiego intenzionale di energia per conseguire uno scopo. Quindi, qualsiasi sia lo scopo, quando impieghiamo intenzionalmente una certa quantità di energia vuol dire che stiamo lavorando. Nei primi capitoli di questo libro, l’attenzione di Suzman si concentra su un uccello dell’Africa australe che si chiama tessitore mascherato, e che ho visto anche io, in Burundi, sulle rive del lago Tanganika. La caratteristica di questo uccello, che si chiama tessitore mascherato perché ha delle macchie sul muso, è appunto di costruire dei nidi attraverso l'intreccio di fili d'erba, di rametti. Questi nidi sono appesi ai rami degli alberi per mezzo di un rametto e sono nidi che, naturalmente, i maschi costruiscono per attirare le femmine. La cosa particolare, però, è che una volta che la femmina è arrivata e lei e lui hanno fatto quello che dovevano fare, questo uccello, cosa fa? Smonta il nido. Occorrerebbe pensare, dottor Plazio, a tutta l'energia che questo uccello impiega per poter mettere insieme questi fili d’erba, questi rametti, e costruire un nido così intrecciato che, mi creda, è una meraviglia da un punto di vista ingegneristico. È stato calcolato che nell'arco di alcuni mesi, durante l'estate, il tessitore mascherato monta e smonta in media venticinque nidi, con un dispendio enorme di energia. Ecco, tutto questo Suzman lo racconta per dare una dimostrazione di che cosa vuol dire il lavoro. Quell'uccello sta lavorando. E lo fa con grande passione. Perché lo fa? Le risposte che gli ornitologi hanno dato, almeno da quanto dice Suzman, è che in questo modo lui apprende sempre più come si fa: monta e smonta nidi perché più lo fa più apprende come farlo. Una sorta di autoapprendimento. Ora, noi ovviamente non siamo interessati al tessitore mascherato dell'Africa australe. Siamo invece interessati al discorso che ci propone Suzman. Per essere molto schematici, per Suzman ci sono alcune tappe fondamentali per quanto riguarda l'uso dell'energia e quindi anche l'erogazione del lavoro da parte di Homo sapiens. Uno: l'acquisizione del fuoco. Il fuoco, evidentemente, è qualcosa che compare già prima di Homo sapiens, ma - dal momento che determinarne l’origine esatta è molto complicato - diamo per acquisito che a un certo punto Homo sapiens sia in grado di utilizzare il fuoco, di padroneggiare il fuoco, di produrlo, di conservarlo, mantenerlo, trasferirlo. Ecco, perché il fuoco sia così importante è facilmente intuibile, a cominciare dal suo impatto rivoluzionario in ambito alimentare. La dieta di Homo sapiens è radicalmente cambiata con l'uso del fuoco, con tutta una serie di cibi che, una volta cotti, possono ora essere ben assimilati. Si apre, dunque, una nuova gamma di risorse alimentari e l'ambiente diventa fornitore di una quantità di cibi prima inimmaginabile. Giustamente, Suzman dice che se noi proviamo a confrontare Homo sapiens con le specie di primati a noi geneticamente più vicine, che sono appunto scimpanzé e bonobo, vediamo che scimpanzé e bonobo impiegano tanto, tantissimo tempo a cercare cibo, sono sempre lì che vanno da un albero all'altro, e cercano, cercano, cercano. La cosa interessante - punto di partenza fondamentale in tutto il discorso di Suzman - è che gli antropologi economisti che fin dagli anni Settanta del Novecento hanno studiato (e studiano tutt’oggi) le società di caccia e raccolta (Suzman si riferisce ai Boscimani del deserto del Kalahari, che conosce meglio, ma ci si può riferire anche ai pigmei bambuti della foresta dell'Ituri, dove mi sono recato io per portare avanti le mie ricerche) hanno fatto dei calcoli sulle ore impiegate dai cacciatori-raccoglitori per lavorare, che per loro vuol dire fondamentalmente acquisire le risorse alimentari. Anche Suzman, più recentemente, ha fatto questi calcoli presso i Boscimani di cui si è occupato. Risultato: i Boscimani nell’arco di una settimana lavorano dalle quindici alle diciassette ore. Poche, molto poche, perché significa lavorare due o tre ore al giorno. Per il resto? Per il resto si “godono la vita”. Allora questo è un punto importante, perché sulla base di questi calcoli, fatti a cominciare dagli anni Settanta del Novecento, c'è stato un ribaltamento nell'interpretazione di queste società, diciamo “primitive”. Fino a quegli anni si pensava che queste società fossero società, come dire, attanagliate dalla fame, dal bisogno di cercare cibo. Non è vero. Tant'è vero che Marshall Sahlins ha tirato fuori questo concetto della società dell'abbondanza.
MP
Nel suo libro “Economia dell'età della pietra”...
FR
Sì, in “Economia dell'età della pietra”, che è certamente un testo rivoluzionario di antropologia economica, le cui tesi sono state peraltro confermate da studi più recenti. Quelle società non erano società nelle quali la vita dell’uomo era sofferenza. No, al contrario. Naturalmente, Sahlins dice una cosa che anche Suzman riprende: una società sostenibile, nella quale i suoi membri lavorano poco e hanno molto tempo libero, deve abbassare il livello dei bisogni dei suoi stessi membri. Ma torniamo a Suzman. Suzman introduce in diversi punti del suo libro una distinzione che noi antropologi avevamo un po’ dimenticato in questi ultimi decenni. Una distinzione che in antropologia risale a Bronisław Malinowski, che era un antropologo polacco di origine polacca, poi diventato britannico. Malinowski proponeva la distinzione tra bisogni primari e bisogni secondari. Questa distinzione noi la troviamo anche in John Maynard Keynes, tanto che è difficile dire chi l’abbia tirata fuori prima. Ad ogni modo, Suzman affronta appunto questa problematica, rifacendosi in qualche modo anche a Keynes. La cosa importante da tenere presente è che i bisogni primari sono di numero finito. Ne possiamo elencare cinque, sei, sette, dall'alimentazione al riposo, al ripararsi dal freddo, ecc. Ma, a conti fatti, abbiamo giusto una manciata di bisogni, soddisfatti i quali ci è garantita la sopravvivenza. Poi però ci sono i bisogni secondari. E Malinowski già allora, negli anni Quaranta, diceva che i bisogni secondari sono i bisogni tipicamente culturali. Ovvero: data una certa cultura, emergono dei bisogni secondari. Se in una determinata cultura è bene che i maschi si vestano con la giacca, io avverto il bisogno di farlo: oggi che sono venuto qui ho tolto il maglione che avevo in casa e mi sono messo la giacca. Questo è un tipico bisogno secondario, perché è vero che mi dovevo riparare dal freddo, ma potevo farlo in tanti modi diversi. Il fatto che io abbia sentito la necessità di mettermi una giacca, e se non l’avessi avuta di andare in un negozio a comprarla, ecco, questo è un tipico bisogno secondario. La differenza tra bisogni primari e bisogni secondari è che i bisogni secondari sono di numero praticamente indefinito. Allora, noi - secondo Suzman - ci troviamo in una società cumulativa, per riprendere un termine che abbiamo già utilizzato. Confrontiamo la nostra cultura con quella dei Boscimani. I Boscimani hanno una cultura molto limitata, e qui mi riferisco alla cultura materiale. Noi, al contrario, abbiamo una cultura enorme e ci muoviamo continuamente in ambienti culturali, fortemente culturalizzati: le nostre case, i mezzi di comunicazione e via dicendo. Tutto questo non può che generare ulteriori bisogni. La cosa importante di questo libro è farci capire che tanta cultura, tanta proprio in senso quantitativo, non è una risposta ai bisogni primari. Si tratta, invece di mera produzione di bisogni secondari. Ecco, non so, non ho qui con me il telefono, ma prendiamo lo smartphone, appunto: io prendo spesso la metropolitana e quello che vedo è che tutti sono sempre costantemente attaccati ai loro smartphone. Non ne possono fare a meno. Ecco, questo è un altro bisogno tipicamente secondario. Io ho due nipoti ed entrambi sono già utilizzatori di smartphone. Glielo vuoi impedire? Prendiamo anche la didattica: durante il covid, quanta didattica ho dovuto fare a distanza, usando gli strumenti digitali? Ecco tutta questa strumentazione è, di nuovo, una risposta a bisogni secondari. Il fatto che noi ci muoviamo in una cultura così elaborata è la conseguenza di un aumento di bisogni praticamente infinito.
MP
Ecco, possiamo forse dire – e con questo passare anche al quarto libro “Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’Antropocene di Simon Lewis e Mark Maslin – che è questo accumulo di cultura che ci ha portato sempre più a “dominare” la natura e, quindi, a entrare in questa nuova era, se si può definire tale, che noi chiamiamo Antropocene?
FR
Sì, certamente. Ma prima di rispondere a questa domanda, vorrei fare un accenno a un altro aspetto. Sia nel libro di Suzman sia nel libro di Lewis e Maslin, che andiamo a trattare adesso, c'è un riferimento al Club di Roma. Il Club di Roma era stato promosso, e vale la pena sottolinearlo, da un torinese, Aurelio Peccei. Siamo nel 1968 e lui, appunto, riunisce una serie di scienziati, di imprenditori illuminati, di pensatori che chiedono a due studiosi del MIT di fare una proiezione di cosa ci avrebbe riservato il futuro, tenendo insieme tutta una serie di dati relativi per esempio all'aumento demografico della popolazione umana, al deterioramento dell'ambiente, all'aumento del PIL, ecc. Il risultato fu che nel 1972 - ed entrambi questi libri ne parlano - i coniugi Meadows scrivono un libro intitolato “I limiti dello sviluppo”, che quando uscì fu duramente attaccato (il New York Times disse che era pieno di stupidaggini). Che cosa diceva questo libro? Diceva che dobbiamo rallentare lo sviluppo, perché a questi ritmi il rischio è di trovarci presto sull'orlo della catastrofe. Trent'anni dopo i coniugi Meadows aggiornarono lo studio con nuovi dati, concludendo che cosa? Concludendo che non si tratta più di rallentare: si tratta di tornare indietro. E, mentre quando era uscita la prima edizione di “I limiti dello sviluppo” ci fu questo attacco corale da parte dei media, ma non solo, anche da parte degli economisti, quando uscì l’edizione aggiornata la situazione era decisamente cambiata. Oggi, lo sappiamo, è ormai molto diffusa la nozione di Antropocene, una nozione coniata da Paul Crutzen, chimico e premio Nobel olandese che aveva studiato la composizione chimica dell'atmosfera. Secondo i suoi studi l'incremento di anidride carbonica nella nostra atmosfera crea il riscaldamento globale e, a cascata, tutti gli altri fenomeni ad esso collegati e che sono sotto osservazione da parte degli scienziati. Paul Crutzen, durante un convegno nel quale si stava parlando di Olocene, che è il termine che i geologi usano per indicare la nostra era (prima c'era il Pleistocene, poi l’Olocene che significa “del tutto recente”), si espresse dicendo che dovremmo avere il coraggio di dire che oggi non siamo più nell’Olocene ma nell'era dell'Antropocene. Cosa voleva dire con questo (che è quello che dicono anche Lewis e Maslin nel loro libro)? L'umanità, con la sua cultura, è diventata una forza naturale, cioè è ormai pienamente parte delle dinamiche geologiche. Noi non siamo più un elemento accessorio nelle dinamiche geologiche, ma siamo dentro quelle stesse dinamiche, che del tutto involontariamente abbiamo sconvolto con le nostre attività. Qual è il fattore che, maggiormente, ha determinato tutto questo? Sono le energie fossili, a cominciare dal carbone - pensiamo alla Rivoluzione Industriale - ma poi il petrolio e poi ancora il gas, il cui approvigionamento, a causa della guerra in Ucraina, è tornato oggi al centro del dibattito, lanciando una corsa disperata a fonti di energia alternative che ha portato in alcuni casi a dover far nuovamente ricorso persino al carbone, che il più inquinante, ma anche a pensare a forme di energia green per garantire la nostra mobilità e, più in generale, il funzionamento della nostra cultura e della nostra società. Lewis e Maslin usano esattamente questa espressione per indicare l'Antropocene: loro dicono che l’Antropocene è una mega civiltà globale. Ecco, io magari metterei al posto di civiltà, cultura, così il nostro discorso diventa più coerente: è una mega cultura globale. Alcuni studiosi, di cui parlano anche Lewis e Maslin, sostengono tuttavia che non è “antropos” in quanto tale ad avere prodotto questo guaio, ma è il capitalismo. E, infatti, ci sono delle proposte alternative sul nome da dare a questa nuova era, che per alcuni non andrebbe chiamata Antropocene ma Capitalocene. Io, alla fine, mi trovo d’accordo con Lewis e Maslin e continuerei a chiamarla Antropocene, perché certo il capitalismo ha dato una spinta enorme, ma quando noi usiamo Antropocene intendiamo dire che, ahimè, tutta l'umanità è coinvolta, anche chi li subisce. Pensiamo, ad esempio, alle tribù dell'Amazzonia, tanto per avere un riferimento di attualità, che di fatto subiscono gli interventi di disboscamento della foresta dell'Amazzonia. Antropocene, dunque, significa che è coinvolta la specie umana nella sua interezza, in modi e forme diverse.
MP
D’altronde il capitalismo è un prodotto dell’uomo, anche se forse è diventato ormai un “organismo” quasi autonomo.
FR
Sì, pensiamo al capitalismo di Stato. Se noi prendiamo i sistemi socialisti, l'Unione Sovietica ad esempio, beh l’Unione Sovietica era, ed è tuttora, un formidabile acceleratore di capitalismo, e quindi di Antropocene. O la Cina: il contributo che la Cina ha dato all'Antropocene è enorme. Per dire: siamo tutti un po’ coinvolti in questi processi. C’è una qualche speranza di venirne fuori? Lewis e Maslin, che sono due studiosi inglesi, si grattano un po’ la testa, nel senso che mettono subito in luce la difficoltà di giungere a una soluzione. In questo, c’è una certa convergenza tra quello che propongono Lewis e Maslin e quello che propone Suzman nel suo libro, ovvero l'opportunità di fare marcia indietro. Vi ricordate quando anni fa Serge Latouche parlava di decrescita e tutti gli “sparavano contro”? Beh, scommetto che ancora oggi se mi trovassi nel Parlamento italiano, prendessi la parola e proponessi come soluzione quella della decrescita mi “sparerebbero contro”. Insomma, per dire che a questo punto bisogna avere il coraggio di dirlo, di affrontare il problema in questi termini. Ricercatori, scienziati, esperti, con una grande quantità di dati raccolti, hanno detto che non basta più rallentare, ma che bisogna tornare indietro. E anche Lewis e Maslin sono di questa idea: bisogna avere il coraggio di dire che i nostri cari bisogni secondari, che si sono di fatto trasformati in bisogni primari, devono tornare a essere secondari. Bisogna riflettere su quali fra i nostri bisogni siano davvero quelli irrinunciabili.
MP
Passiamo allora al quinto e ultimo libro, “Il cuore del cacciatore” di Laurens van der Post, che proprio con questi discorsi sembra avere un aggancio diretto. Laurens van der Post, ho letto, è un discendente di un'antica famiglia boera. Era uno scrittore, esploratore sudafricano, non propriamente un antropologo, cosa che rende forse ancora più particolare questo viaggio che lui compie tra i Boscimani.
FR
Sì, ho scelto questo libro, intanto perché è stato recentemente pubblicato da Adelphi in traduzione italiana, e questo rappresenta sempre un vantaggio. Ma anche per un altro motivo: Laurens van der Post, nel suo libro, ci dice chiaramente che lui non è un antropologo, uno studioso professionista di queste società, e in particolare dei Boscimani. Lui era uno scrittore, un giornalista, ma soprattutto un grande esploratore. Aveva viaggiato in Giappone, nel Sud-Est asiatico, e in molte altre parti del mondo. Durante la guerra era stato fatto prigioniero dai giapponesi. Per sua fortuna, conoscendo la lingua, era riuscito a cavarsela. Era poi stato fatto prigioniero una seconda volta, se non ricordo male, nel Sud-Est asiatico. Altra particolarità della sua biografia è che lui era contrario all’apartheid e aveva polemizzato con Desmond Tutu, con Mandela, cioè con quelli che noi consideriamo i personaggi politicamente più significativi del Sudafrica, che avevano messo alle spalle l’apartheid. Insomma, per farla breve, era un personaggio un po’ curioso. Era molto legato all'Inghilterra, amico dell'attuale re Carlo, tant'è vero che erano andati insieme nel deserto Kalahari. Un personaggio un po’ così, insomma. Questo libro, però, che se non sbaglio è del 1961, è una straordinaria testimonianza di un non-antropologo che ha avuto l'opportunità di convivere a lungo nel deserto con i Boscimani, e quindi di apprezzarne la loro vita, la loro cultura. E ci sono indubbiamente alcuni punti di questo libro che vale la pena sottolineare. Intanto un aspetto che a tutti noi africanisti sta a cuore: il ridere, la capacità di ridere. Io quando ho letto questo libro mi sono imbattuto in questa osservazione di Laurens van der Post che dice: la cosa che mi ha colpito tra i Boscimani è il fatto che per loro quanto più la disgrazia è grave tanto più devi ridere. Come a dire, quando ti capita una disgrazia, il modo per venirne fuori è riderne. E questo è tipico dell’Africa, una cosa che ho riscontrato anche tra i miei Banande. Questa capacità di ridere, dice Laurens van der Post, è stata poi contrastata dall'arrivo della civiltà dei bianchi, che si sono da sempre considerati proprietari del mondo, della natura. I Boscimani, al contrario, considerano gli animali, le piante - le poche piante del deserto del Kalahari - e i vari fenomeni della natura come persone. Questa osservazione - bella anche perché in antropologia esiste un ambito di studi che prende proprio il nome di “Antropologia della persona”, che indaga il concetto di persona nelle diverse società umane -, questo allargare il concetto di persona, estenderlo, dilatarlo al di là del mondo umano, considerando persone anche la zebra o l’antilope che incontriamo, piuttosto che un albero, è straordinario. Perché crea un rapporto di convivenza, e non di sfruttamento, nei confronti dell'ambiente. Ed è proprio questo uno dei temi centrali di questo libro: far vedere come i Boscimani abbiano nei confronti dell'ambiente questo atteggiamento di convivenza, dove convivenza - dicevo sempre anche ai miei studenti - significa innanzitutto che tu devi conoscere molto bene l’ambiente, lo devi conoscere scientificamente. Ma non la scienza che studi sui libri, ma una conoscenza empirica, fatta di osservazione dei fenomeni naturali, che favorisca l’adattamento. In questo modo, il deserto, pur così difficile, diventa amico. Questo mi fa venire in mente anche l'atteggiamento dei pigmei bambuti nei confronti della foresta, che è l'ambiente esattamente opposto al deserto: per loro la foresta è padre e madre, così come per i Boscimani il deserto è un amico, e come tale lo devi trattare. Un altro tema interessante di questo libro è quello che fa riferimento al concetto di grazia. Laurens van der Post era rimasto colpito dal modo con cui si muovono i Boscimani che, lui dice, si muovono con grazia. A questo proposito racconta l’episodio di una mamma che solleva il proprio bambino verso un astro notturno e della grazia, appunto, con la quale tutto questo avveniva. Ecco la grazia, la stessa che i Boscimani osservano e apprezzano nelle movenze degli animali. Tutto questo forse saprà di romantico, non lo so, ma io sono disposto a sfidare un rilievo di questo genere ed essere accusato di un eccesso di romanticismo. No, per me c’è qualcosa di molto più profondo: se tu devi convivere in un determinato ambiente, devi necessariamente avere nei confronti di questo ambiente non solo conoscenza ma anche amore, anche empatia, persino nei confronti di quegli animali che poi dovrai ammazzare per necessità, per il tuo sostentamento. Concluderei soffermandomi su una cosa che mi ha colpito, e che è un tema che guarda caso si trova anche in questo libro di Laurens van der Post, e che serpeggia in tutti i libri di cui abbiamo discusso oggi: il tema della cecità. Laurens van der Post dice: noi, pur con tutto il nostro sapere, rispetto ai Boscimani - che invece sono così “primitivi” - soffriamo di cecità nei confronti del nostro ambiente, e del nostro destino. Per chiudere, riprendo un’affermazione contenuta in questi due ultimi libri, quello di Suzman e quello di Lewis e Maslin, che convergono nel sostenere questa cosa: l'economia di caccia e raccolta si è rivelata essere l'economia in assoluto più sostenibile. Se noi guardiamo l'intera storia dell'umanità, considerando ovviamente Homo sapiens (da 200.000 anni fa ad oggi), noi possiamo osservare che la maggior parte di questa storia è stata vissuta da società la cui economia era un'economia di semplice caccia e raccolta: un'economia di prelievo, nella quale tu ti limiti a prelevare quello che la natura mette a disposizione, senza mettere le mani nei processi di riproduzione delle specie. In questo senso, il grande salto, è rappresentato dalla rivoluzione agricola e poi dall'allevamento del bestiame, che - sempre con un grande balzo in avanti - hanno poi portato all'attuale ingegneria genetica: ovvero pensare di poter mettere le mani nei sistemi riproduttivi delle specie, senza limitarsi a prendere quello che la natura offre. Difficile, certo. I miei studenti, quando affronto questi temi, si entusiasmano e io cerco di abbassare la temperatura dicendo loro che, al di là di tutti i discorsi che si possono fare, se io mi fossi trovato a vivere tra i pigmei bambuti non avrei certamente raggiunto questa età.
MP
Parlando di giovani e di nuove generazioni, c’è anche da dire che una maggiore sensibilità nei confronti del tema ambientale c’è, esiste. Ed è una speranza per il futuro.
FR
Certamente.
MP
Bene. Grazie, grazie davvero, Professore, per questo bellissimo viaggio, ricco di spunti e suggestioni. Prima di chiudere ricordo soltanto a tutti coloro che vorranno approfondire ulteriormente i temi affrontati nella puntata di oggi che, già da ora, tutti i libri scelti dal professor Remotti sono disponibili nelle biblioteche del Politecnico. Ringrazio ancora il Professore, e grazie a voi che ci avete ascoltato.