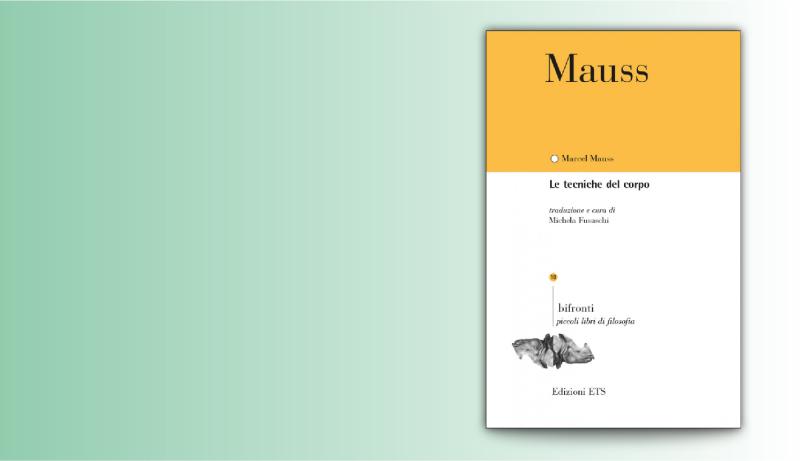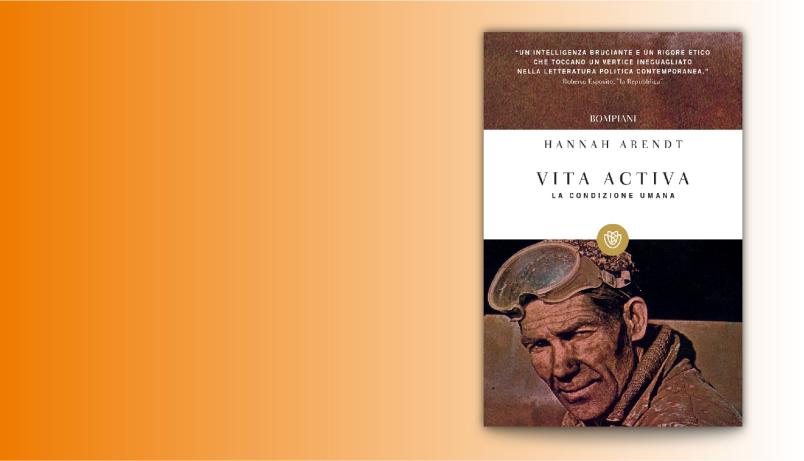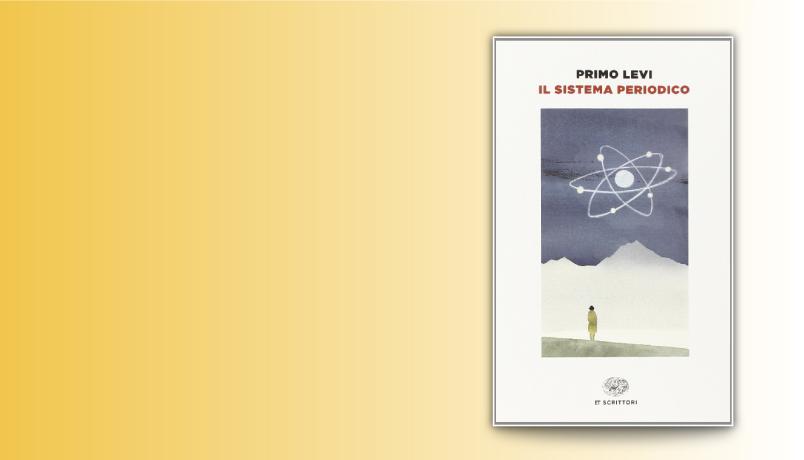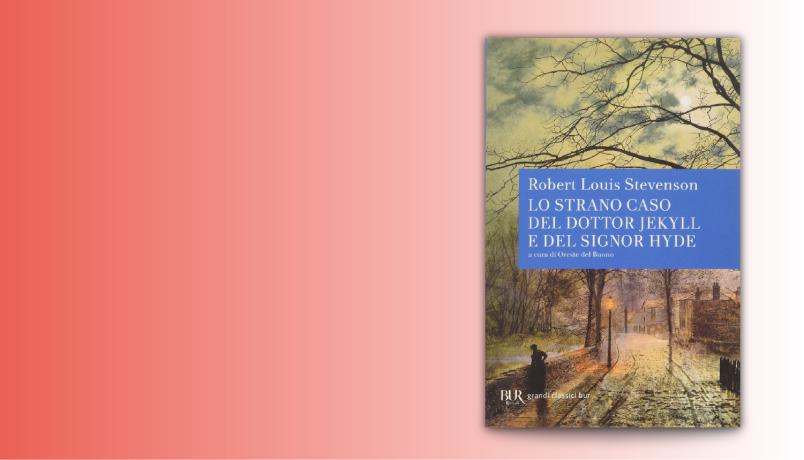Chi è Peppino Ortoleva

Nato a Napoli nel 1948, è stato professore ordinario di Storia e Teoria dei Media all’Università di Torino. Ha pubblicato oltre duecento lavori scientifici su storia, società e media. Tra i suoi libri si ricordano Saggio sui movimenti del 1968 (Editori Riuniti, Roma, 1988), Un ventennio a colori (Giunti, Firenze, 1995), Mediastoria (net, Milano, 2002), l'Enciclopedia della radio (Garzanti, Milano, 2003), Il secolo dei media (Il Saggiatore, Milano, 2009), Dal sesso al gioco (espress, Torino, 2012), Miti a bassa intensità (Einaudi, Torino, 2019). Il suo ultimo libro, pubblicato da Einaudi nel 2021, è Sulla viltà. Anatomia e storia di un male comune
Gli è stata decretato un dottorato honoris causa in comunicazione dall’Université Paris 2, Panthéon-Assas. È Profesor Ajunto alla Universidad de los Andes di Bogotà. È stato ed è curatore di mostre e musei su storia, società, comunicazione.
Angela La Rotella: Buongiorno a tutte e tutti. Siamo qui per una nuova puntata di Cinque Libri, e oggi abbiamo come ospite il professor Peppino Ortoleva, già insegnante all'Università di Torino di Storia e Teoria dei Mezzi di Comunicazione. Cinque Libri è un'occasione per raccogliere dei consigli di lettura che siano particolarmente utili non solo per la cultura politecnica, ma anche per tutti quei lettori curiosi che vogliono percorrere una strada di avvicinamento a libri che magari sono del passato, ma che vengono ritenuti di grande attualità per vivere il presente.
Il professor Ortoleva ci porterà in un percorso che incontra autori molto diversi tra di loro: Robert Louis Stevenson con Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde, Marcel Mauss con Le tecniche del corpo, la filosofa Hannah Arendt col suo Vita Activa, Marshall Mcluhan con Come capire i media. Gli strumenti per comunicare, e infine Primo Levi con Il sistema periodico. Ecco, quando ha proposto questi titoli, questi autori, davvero ho provato una fortissima curiosità, per capire che cosa li potesse tenere insieme. E quindi la ringrazio soprattutto per essere qui con noi, per averci voluto dare questo contributo, e inizio subito col domandare: perché questi libri, come mai ha scelto questi autori?
Peppino Ortoleva: Il sottotitolo di questa nostra conversazione è “Come la tecnica ha cambiato l'uomo” e io vorrei partire da un altro autore, il filosofo Aristotele, che in uno dei suoi scritti dice che la mano è lo strumento degli strumenti. Una frase secondo me di una ricchezza straordinaria, perché dire che la mano è lo strumento degli strumenti vuol dire che l'essere umano è un essere che produce e usa la tecnica, che è un fabbricatore di strumenti ma anche che usa gli strumenti perché è dotato nel suo stesso corpo di alcuni organi che sono essi stessi degli strumenti - come la mano appunto - che in qualche modo contribuiscono sia a fabbricare altri strumenti sia a utilizzarli. Noi, come esseri umani, siamo esseri strumentali che usano e “fanno” la tecnica anche perché abbiamo un corpo fatto in un certo modo. Ma la domanda è: perché il nostro corpo è fatto in un certo modo? E qui la risposta può essere molto interessante.
Prendiamo l'esempio di un bambino molto piccolo. Per lui, o per lei, la mano è una delle tante parti del suo corpo, ma è una parte che nel tempo comincia progressivamente a differenziarsi. Il bambino comincia presto a rendersi conto che la mano ha delle capacità e delle funzioni differenti dal resto del corpo. Il bambino, attraverso la mano, si impossessa del mondo in modo diverso da come lo fa con altri organi, compresi la bocca e le orecchie, e al tempo stesso, sempre attraverso la mano, si adatta al mondo che lo circonda. Ora, per me questo è un punto di partenza estremamente interessante perché dimostra che, nell’evoluzione dell’umanità, il rapporto dell’uomo con la tecnica è mediato prima di tutto dai suoi stessi organi fisici. Questo rapporto ha progressivamente fatto evolvere il nostro stesso corpo: la mano, nel corso delle centinaia di migliaia di anni, è diventata essa stessa uno degli strumenti più straordinari che siano mai stati costruiti. Qualcuno potrebbe sostenere che è la stessa mano dello scimpanzé, ed è in parte vero visto che comunque noi abbiamo il 96% dei cromosomi in comune, ma la nostra mano ha delle capacità che la mano dello scimpanzé non ha, perché il nostro è un organo più specializzato.
Tutto questo per dire che, in sostanza, l'essere umano adatta la tecnica ai suoi bisogni, ai compiti che le dà, ma contemporaneamente si è evoluto con la tecnica e grazie alla tecnica e, allo stesso tempo, si è in qualche modo adattato all'uso dei suoi strumenti. La mano, lo strumento degli strumenti per Aristotele, è l’organo intermedio più diretto di questo passaggio. Mi è caro ricordare che nel momento in cui è arrivata la tecnica informatica, che è apparentemente la più immateriale delle tecniche, un passaggio essenziale è stato introdurre, accanto alla tastiera e allo schermo, quell'oggetto che si chiama mouse e che serve essenzialmente a farci usare la mano “dentro il computer”. Quindi, con il mouse, questa tecnica apparentemente molto astratta e immateriale si è manualizzata più di quanto lo abbiano fatto molte tecniche precedenti.
Ho fatto questa introduzione, forse un po’ troppo lunga, per dire che tutti i testi di cui parleremo velocemente oggi ci aiutano proprio a riflettere su come la tecnica nasca dall’umanità e, contemporaneamente, su come retroagisca su di noi, a tanti livelli: dal fisico fino al sociale.
Questo è proprio il punto di partenza del breve volume di Marcel Mauss, Le tecniche del corpo, un libro di poche pagine, del 1934, che la prestigiosa casa editrice ETS di Pisa ha deciso di pubblicare in italiano con testo a fronte. Che cosa c'è di interessante nel libro di Mauss? Intanto il titolo stesso, Le tecniche del corpo. Perché Mauss in sostanza dice che non dobbiamo mai dimenticarci che l'essere umano ha delle tecniche che sono basate sull'uso di strumenti ma anche delle tecniche che sono legate essenzialmente al modo in cui adatta il corpo alle sue finalità. Io sono partito dalla mano, Mauss per esempio parte dalle tecniche del camminare e da quelle del correre, facendo notare che il modo di camminare e di correre di popoli anche apparentemente vicini è tra loro molto diverso. Questo, lui dice, non per una ragione strettamente fisica, né per una ragione solo culturale, ma per entrambi gli elementi insieme. E qui c'è il primo aspetto del libro di Mauss che vorrei ricordare e sottolineare, ovvero che noi dobbiamo considerare la tecnica come un fatto umano totale. Quando si parla di tecnica non bisogna parlare solo di un aspetto dell'umanità ma di tanti aspetti. La tecnica ci riguarda biologicamente, perché appunto il nostro corpo ne è coinvolto, e questo pertiene naturalmente le tecniche del corpo ma anche le tecniche esterne al corpo - il mouse per esempio è una tecnica che coinvolge comunque il nostro corpo. Mauss parla poi di psicologia, che per lui non è un fatto solo mentale ma che coinvolge, nell'uso della tecnica, anche elementi emotivi. E poi c’è l’elemento sociale, perché la tecnica nasce da esseri umani che non vivono da soli e che si rapportano con gli altri: la tecnica è al centro dei rapporti che gli esseri umani hanno tra di loro e tra loro e le cose, come amo sempre dire.
Questo carattere totale della tecnica è quindi una prima osservazione di Mauss che considero assolutamente preziosa. Una seconda osservazione è che esistono le tecniche del corpo. Come nasce il fatto che esistono modi di camminare, di correre, di cantare, di nuotare così diversi tra i vari popoli, anche tra quelli che sembrerebbero più simili? Secondo Mauss nasce dall’intreccio di fatti strettamente fisici, abitudini e educazione. Quindi sostanzialmente noi apprendiamo le tecniche, anche quelle apparentemente più banali, in parte istintivamente, in parte per l'uso che ne facciamo, in parte perché ci vengono insegnate. Per esempio, alcune delle pagine più interessanti di Mauss riguardano il ballare: il ballare è una tecnica, ovviamente, ed è una tecnica molto complessa. La danza si è evoluta molto nel corso del tempo, ma si è evoluta in modi che spesso non sono così lineari. Andando oltre Mauss, che cita comunque uno dei più importanti autori di storia della danza, Fuksas, se noi guardiamo alla storia della danza ci saremmo potuti aspettare un progressivo affinamento della tecnica. Invece, a un certo punto, si passa da tecniche molto rigorose, come i balli di corte, a tecniche diverse legate più al corteggiamento, come i balli di coppia, fino a questo scatenamento che sono i balli moderni, che richiedono comunque una tecnica perché bisogna saperli ballare. Quindi Mauss ci fa ragionare su quello che chiamerei un po’ scherzosamente il grado zero della tecnica, quella che sta dentro il nostro corpo prima ancora di usare gli strumenti.
Da Marcel Mauss ad Hannah Arendt, che è una filosofa politica che mi è molto cara e che a me piace ricordare, oltre che per la sua bellissima biografia, anche perché è bellissimo leggerla: una scrittrice tedesca che amava scrivere in inglese, un inglese assolutamente limpido. I testi di Hannah Arendt sono testi pieni di una immensa cultura filosofica, perché lei nell'arco di un capitolo può partire da Ulisse e arrivare fino all'automobile. Lei, poi, era una grande appassionata non solo di cultura greca ma anche di cultura romana antica, una cosa anche questa molto particolare, un’autrice ebrea, sostanzialmente atea, che ha scritto cose strane e interessanti.
E allora perché Vita activa? Vita activa è un libro cruciale nel pensiero di Hannah Arendt, un libro anomalo che è stato molto discusso anche da tanti altri filosofi. Un libro dedicato alle varie attività umane, ai vari aspetti della vita attiva dell'essere umano, nel quale Hannah Arendt introduce una categoria, non molto vicina a noi oggi, che è la vita attiva intesa in senso di attività politica e, più in generale vita pubblica, vita dedicata al confronto tra gli esseri umani. Tuttavia, accanto a questo, la Arendt introduce due modelli distinti e per certi versi opposti di attività produttiva. Da un lato il lavoro nel senso più standardizzato del termine, lavoro ripetitivo, sempre uguale a sé stesso, quello che lega al concetto di animal laborans, per il quale l'essere umano è un essere che per guadagnarsi da vivere deve lavorare versando il sudore della propria fronte, secondo la maledizione biblica: lavora per sopravvivere, per riprodursi sul piano biologico. Questo tipo di lavoro, che è essenziale all’essere umano, è un lavoro che si auto-consuma, che è sempre esistito nella vita dell’uomo, ma che come sottolinea Hannah Arendt nel sistema produttivo moderno è diventato particolarmente pesante proprio perché l’attività produttiva tende alla standardizzazione, alla ripetitività. D'altra parte questo lavoro viene fatto soprattutto per produrre oggetti di consumo che a loro volta saranno ciclicamente consumati in modo altrettanto ripetitivo. Dall’altro lato, Hannah Arendt sostiene che c’è anche il lavoro artigiano, quello dell’homo faber, contrapposto all’animal laborans, che invece introduce qualcosa di nuovo nel mondo: il lavoro dell'homo faber cambia in qualche misura l'umanità, cambia il mondo e l’ambiente, perché non è semplicemente un lavoro ripetitivo, bensì creativo, e va dal lavoro dell'artigiano fino al lavoro dell'artista. In un altro testo di dodici anni dopo, Sulla violenza, Hannah Arendt introduce anche una terza categoria molto importante di lavoro, che è il lavoro distruttivo: l'essere umano è anche un essere che usa la tecnica per uccidere, per distruggere. Hannah Arendt, quasi all'inizio del testo, riprende il concetto di Engels secondo cui la violenza umana, a differenza di quella animale, usa gli strumenti per diventare ancora più violenta. Tre categorie di lavoro, quindi, con una terza contenuta in un altro volume e che qui non ci interessa nello specifico.
Che rapporto esiste tra homo faber e animal laborans? Qui Hannah Arendt oscilla fra due modi di pensare: da un lato tende a pensare che noi, storicamente, siamo passati da civiltà più artigiane a civiltà più standardizzate, dove la tecnica è qualcosa che sta fuori dall’uomo o la donna che lavorano, qualcosa che è sopra di loro, che li domina. Questo vedere storicamente una tecnica che passa dal creativo al ripetitivo è un aspetto importante del libro di Hannah Arendt che è stato poi ripreso da un suo allievo, il grande sociologo Richard Sennett, che nel suo libro L’uomo artigiano idealizza il concetto che si possa tornare in qualche modo al modello artigiano di Hannah Arendt, la quale secondo me però non avrebbe approvato la sua tesi, prima di tutto perché lei non erano una nostalgica, ma poi perché, in realtà, in Vita activa l’altro modo di mettere in relazione il lavoro come ripetizione e il lavoro creativo è quello di vederli non solo come modelli alternativi, storicamente, ma come due poli dell'attività produttiva umana: l'essere umano vive la sua attività produttiva fra una tendenza alla standardizzazione e una tendenza alla creatività, come due possibilità che sono sempre presenti e che in qualche modo si alimentano a vicenda. A mio modo di vedere è nella tensione tra l’homo faber e l'animal laborans che dovremmo trovare in Hannah Arendt una chiave per capire la tecnica, perché la tecnica ci spinge verso la ripetitività però contemporaneamente è essa stessa un prodotto creativo e può anche essere usata in modo più produttivo.
ALaR: Hannah Arendt, come ha detto, è una grande filosofa politica che, fra le altre cose, indaga anche il rapporto tra libertà e potere, riflettendo sui sistemi che garantiscono la libertà e che contrastano il totalitarismo. Il tema della libertà e della contrapposizione, quindi, passa anche attraverso quello che ci stava raccontando, cioè mi sembra che il filo che tiene insieme l’analisi di questo uomo che può gestire in qualche modo la tecnica investa anche il tema di sé e come la tecnologia può invece diventare una forma di controllo della libertà.
PO: Assolutamente. Questo è evidente soprattutto nella parte sull'animal laborans, dove lei è molto critica sulle potenzialità schiavizzanti della tecnologia. Nel libro Sulla violenza, che è uno dei suoi ultimi, pubblicato nel 1969, Hannah Arendt parla anche, per esempio - ed è un tema che si collega molto a Vita activa -, della mostruosità della macchina burocratica. Cioè, lei non parla soltanto del lavoro alla catena di montaggio stile Chaplin, personaggio che ama moltissimo, ma anche delle tecniche di standardizzazione che sono applicate a tutti gli aspetti della vita contemporanea. Hannah Arendt parla del potere di uno, del potere di pochi, e dice che mentre la democrazia è, o dovrebbe essere, il potere di tutti, la burocrazia è invece il potere di nessuno, perché rappresenta il potere dell’irresponsabilità totale di una macchina che si nasconde dietro sé stessa. Quindi questa ripetitività della tecnica ha anche un versante politico.
Ricordiamoci che nella sua ultima opera, La vita della mente, rimasta incompiuta, Hannah Arendt fa una operazione in un certo senso analoga a quella di Vita activa, stabilendo una tripartizione della vita mentale degli esseri umani: il pensare, il volere e il giudicare. La parte sul giudicare non l’hai mai scritta, ma le parti sul pensare e sul volere sono molto interessanti perché prima parla della vita “esterna” degli esseri umani, ovvero la produzione, la relazioni con gli altri, poi passa alla “radice”, dando lo stesso peso all’attività del pensare e a quella del volere, perché in realtà la tecnica e tutte le attività produttive sono anche attività legate al volere, al voler raggiungere un certo scopo, un certo risultato. Marcel Mauss, come citavo prima, definisce la tecnica come un'azione prima di tutto efficace, efficace in relazione al fatto che gli esseri umani hanno una capacità di costruire un progetto e agiscono per cercare di realizzarlo. Naturalmente, dal suo punto di vista, l'artigiano ha con questa posizione un rapporto più creativo, che lascia più tracce del mondo di quanto non faccia chi svolge un lavoro più ripetitivo, come l'operaio della catena di montaggio ma, secondo Arendt, peggio ancora, come il burocrate.
Arriviamo a Marshall McLuhan, un autore canadese nato nel 1911 che ebbe un grande successo intorno alla metà degli anni Sessanta e che poi venne un po’ dimenticato. In seguito, quando alla fine degli anni Ottanta, se non sbaglio, nacque la rivista Wired, che per un certo periodo è stata la rivista della rivoluzione digitale, nel colophon della rivista ricomparve il suo nome, come santo patrono, perché di fatto era un riferimento fondamentale. A differenza di Vita activa di Hannah Arendt, il libro di Marshall McLuhan all'inizio sconcerta perché è scritto in un modo molto peculiare. Si tratta di un libro estremamente provocatorio, e una delle provocazioni di McLuhan è stata quella di scrivere un libro di teoria, un saggio, come l'avrebbe scritto James Joyce, affidandosi quindi a una tecnica letteraria innovativa che secondo lui era essenziale per rappresentare ciò che stava succedendo con quella che per lui è la base di tutte le rivoluzioni tecnologiche: l'elettrificazione. Per McLuhan è il passaggio all'elettricità che ha cambiato tutto, le altre rivoluzioni tecnologiche, compresa la digitalizzazione, sono state tutte una diretta conseguenza dell'elettrificazione. L’elettrificazione annulla il tempo, dà una simultaneità totale non solo ai comportamenti di piccoli gruppi, ma addirittura ai comportamenti dell'umanità intera. Di qui la famosa metafora del “villaggio globale”, che viene citata molto, ma spesso senza capire che cosa vuol dire.
In sostanza questo libro, per essere capito, deve essere letto fin dalle primissime parole, quelle del suo titolo, che in inglese sono “Understanding Media: The Extensions of Man”, tradotte in italiano prima con “Gli strumenti del comunicare” e poi con “Capire i media. Gli strumenti del comunicare”. Per McLuhan, che usa la parola “media” in modo molto lato, che comprende anche le armi, il treno, l’aereo, l’automazione, gli strumenti sono delle estensioni, delle protesi dell’essere umano. Questa idea della protesi non è solo di McLuhan, anche Freud in un libro importantissimo che si chiama Il disagio della civiltà del 1929 dice che l'essere umano contemporaneo è un dio-protesi, cioè è un essere così potenziato dalle sue protesi che si sente Dio. McLuhan non dice esattamente questo, ma problematizza lo stesso tema: l'essere umano, nel corso della storia, si è dotato di estensioni progressive. Alcune di queste sono specialistiche, sono estensioni di singoli organi, per esempio la ruota è tipicamente un'estensione del piede, i vestiti lo sono della pelle e così via. Altre sono invece estensioni più particolari. L'elettrificazione per McLuhan è un'estensione del sistema nervoso, intuizione che non è solo sua perché già nel 1839-40 quando Samuel Morse presentò al Congresso americano il progetto del telegrafo elettrico, che era il primo grande progetto elettrico della storia, scrisse che era un'estensione del sistema nervoso. Ecco, l’elettrificazione è un'estensione del sistema nervoso, nel senso che nel concetto di elettrificazione McLuhan unisce strumenti nati per essere usati in modo totalmente distinto ma che vengono progressivamente unificati perché è la loro applicazione a renderli versatili.
Per McLuhan c'è un grande paradosso, che è uno degli aspetti più affascinanti del suo pensiero. Generalmente noi tendiamo a pensare l'evoluzione dell'umanità in modo abbastanza lineare. Tra gli autori che influenzano di più McLuhan, e anche questo è molto interessante, c'è un filosofo italiano molto importante, seppur poco conosciuto, che è Giambattista Vico di cui lui, sulle orme di Joyce, era un lettore molto appassionato. McLuhan non pensa al progresso umano in modo lineare. Per noi, oggi, l’idea di progresso è superata, però il nostro modo di pensare alla storia continua a essere condizionato da questa idea, che lui invece ha rivoluzionato già negli anni Cinquanta e Sessanta. McLuhan dice che nella storia c'è un’alternanza di modelli diversi della nostra relazione con il mondo, e in particolare con la tecnologia. Perché? Perché la relazione caratteristica delle tecnologie più meccaniche, e in queste lui inserisce la scrittura così come le tecnologie industriali classiche, è una relazione di tipo specialistico. Noi tendiamo a suddividere i nostri sensi, i nostri organi dando a ciascuno una funzione precisa. In altre fasi, invece, c'è una tendenza a mettere più insieme le diverse funzioni, i diversi compiti. Per esempio, il parlare rispetto allo scrivere è molto meno specialistico perché nel parlare noi teniamo in considerazione le parole, ma anche la voce, il volto, i gesti e così via. Un colloquio orale non coinvolge uno solo dei nostri sensi, una lettura invece viene fatta soltanto con gli occhi, con la trasmissione di messaggi che vengono poi codificati dalla mente. Nell’oralità noi, pur avendo dei codici, come la conoscenza della lingua di chi sta parlando, non interpretiamo l'altra persona solo sulla base del codice linguistico, ma anche del tono, del volto, dei gesti, perché, come dice McLuhan, la nostra relazione di tipo orale è cinestetica, la nostra conversazione è multisensoriale.
Quindi ci sono epoche nella storia che sono più di tipo meccanico, e quindi specialistiche, e altre che sono più di tipo cinestetico, multisensoriale, e quindi meno specialistiche. Naturalmente, gli esseri umani sono passati da epoche di tipo multisensoriale, come lo sono state tutte quelle delle civiltà primitive, a epoche più specialistiche, a cominciare da quella che ha visto la nascita della scrittura, che è stata una grande rivoluzione. Poi il Medioevo è stato un ritorno alla multisensorialità, soprattutto l’alto Medioevo, e dopo, di nuovo con l'invenzione della stampa, la galassia Gutenberg di cui parla McLuhan, si è tornati alla meccanizzazione, con la macchina tipografica che è la prima macchina di produzione in serie. Da allora si è arrivati poi all’estrema meccanizzazione della catena di montaggio. Parallelamente, però, con l'elettrificazione si è tornati nella direzione di un’umanità multisensoriale e non più specializzata. E dall'elettrificazione, passando attraverso la televisione e poi l’informatica, si va decisamente in questa direzione. Il nostro rapporto con l'informazione cambia, sostiene McLuhan, che però ripeto non parla solo di informazione nel senso tecnico del termine, cioè dati, parole numeri che si trasmettono da un punto all'altro: tutto il nostro mondo è fatto anche di informazioni, in tutte le epoche della storia. Nel nostro mondo, dice McLuhan in modo profetico, noi non tendiamo più a essere coltivatori di informazione, ma cacciatori e raccoglitori di informazione, cioè ci muoviamo non come l'umanità dopo la cosiddetta rivoluzione neolitica, quando si è cominciato a coltivare e allevare, ma come l'umanità prima della rivoluzione neolitica, quando l’uomo viveva di caccia e raccolta. E quindi, oggi, viviamo un mondo saturo di informazione nel quale cercare e trovare mano a mano quello che ci serve: se uno pensa all'esperienza che noi abbiamo con l’informazione, anche nell'epoca della rete, è di un'evidenza cristallina e la cosa stupefacente è che McLuhan lo aveva intuito sessanta anni fa, aveva intuito che l'elettrificazione andava in questa direzione.
ALaR: C’è una preoccupazione di McLuhan nei confronti di questo processo? Perché dalla parola coltivare alla parola raccogliere c’è un salto, c’è qualche cosa che viene meno.
PO: Sì, però c’è anche qualche cosa che viene in più. Nel senso che McLuhan non era entusiasta della rivoluzione digitale, ma non era neanche contrario. La vedeva come un fatto storico non lineare, come un ciclo in cui siamo immersi e nel quale si perde qualcosa ma allo stesso tempo si guadagna qualcosa. Noi, oggi che abbiamo una possibilità, per esempio con internet, di vivere in un ambiente saturo di informazione e fare continuamente caccia e raccolta, per quanto molti dicano che il profumo del libro stampato sia un’altra cosa e altre frasi fatte, saremmo davvero disposti a rinunciare a questa enorme ricchezza, un po’ casuale, un po’ confusa, di informazione per tornare a dover andare in biblioteca a prendere un singolo libro e poi tornarci per restituirlo? Era un modello diverso, non dico peggiore, ma diverso, al quale noi non siamo più abituati. McLuhan ha avuto questa intuizione straordinaria, un’intuizione che gli è derivata dal leggere la strumentalità umana nella sua stratificazione di significati e nella sua complessità. Ed è anche questo che rende la sua scrittura così complessa, ma una volta entrati nel suo modo di pensare, molto affascinante, si scoprono delle connessioni che colpiscono molto. Io consiglio quindi a tutti di leggere questo libro, e di essere pazienti nel farlo, perché, ripeto, è un libro che porta dentro un modo di pensare la strumentalità umana molto originale.
Vorrei legarmi all’altro libro, quello di Primo Levi, perché in realtà vi è un legame, che secondo me è un aspetto importantissimo: parlando di tecnica abbiamo bisogno della letteratura, e questo è dovuto al fatto che la tecnica non è solo fatta di strumenti che sono fuori di noi, quanto piuttosto da una relazione tra noi e gli strumenti. Relazione reciproca, perché, come dicevo, gli strumenti agiscono su di noi tanto quanto noi agiamo sugli strumenti - concetto che è alla base di tutti questi autori. La tecnica, dunque, non solo non è fatta di strumenti separati da noi, non è fatta neanche soltanto di quello che noi fisicamente facciamo con gli strumenti. C'è un aspetto molto importante che secondo me viene troppo spesso trascurato da chi si occupa di tecnica, ossia l’esperienza della tecnica. Chi fa un lavoro con la tecnica, ma anche chi la usa semplicemente o chi se la inventa - c'è un passaggio bellissimo di Hannah Arendt che dice “ogni donna sa se non ha un martello basta un tacco per piantare un chiodo”, che secondo me è una frase straordinaria perché ci dice che noi ci arrangiamo, siamo fluidi con la tecnica - ecco, un'educazione tecnologica che tende a specializzarci troppo e farci dimenticare le capacità di arrangiarci, la fluidità, rischia di limitarci: l'esperienza della tecnica è complessa come tutte le esperienze umane; dicevamo, l'essere umano che fa un lavoro che richiede strumenti tecnici più o meno sofisticati si trova a vivere questa relazione con questi strumenti attraverso passaggi diversi - psicologicamente diversi, emotivamente diversi ma anche con storie diverse - lo stesso strumento, lo stesso lavoro può dar luogo in diversi momenti della vita a delle esperienze differenti, che si possono capire soltanto raccontandole. Da questo punto di vista, secondo me, sono pochi purtroppo i grandi scrittori che raccontano la tecnica nel modo in cui raccontano l'amore o quella particolare forma di tecnica che è la guerra - in quel caso sì che viene raccontato di più: ecco, l’Iliade per esempio è piena di narrazioni di tecniche belliche. La tecnica del lavoro, per esempio, viene troppo spesso accantonata dalla letteratura.
Dunque, gli scrittori che raccontano bene la tecnica non sono moltissimi; Primo Levi è un caso eccezionale, intanto perché siamo a Torino e ormai stiamo incominciando a rendercene conto: è uno dei più grandi scrittori torinesi degli ultimi secoli. Io ho avuto anche la grandissima fortuna di conoscerlo, e so che persona affascinante fosse anche umanamente, e tra l'altro era uno che parlava come scriveva e viceversa, ossia in maniera elegantissima. Vi sono due libri di Primo Levi che parlano della tecnica (lui è più conosciuto come lo scrittore che ha parlato di Auschwitz, uno dei grandi testimoni del genocidio): Il sistema periodico, un insieme di racconti che è stato premiato da una giuria internazionale come il più bel libro di scienza mai scritto, superando anche Darwin, un insieme di racconti che riunisce storie - anche fantastiche - sulla chimica e le sue esperienze di chimico. L'esperienza in questione comprende i processi di apprendimento e i fallimenti, perché anche questo è fondamentale: naturalmente tutti i saperi umani sono fatti di fallimenti; questo non vuol dire banalmente che sbagliando s'impara, poiché vi sono degli errori che insegnano altri che non insegnano niente (gli errori insegnano prima di tutto se li si comprende, e ciò nonostante ci sono errori semplicemente catastrofici). Ecco, lui non parla solo dell'apprendimento attraverso gli errori e le esperienze, parla anche di storie che possono capitare a un chimico: storie di grandi incomprensioni perché non si arriva a capire un fenomeno, storie su cosa si fa quando viene a mancare una certa materia prima, e così via.
Levi ha scritto un altro libro sulla tecnica che invece non è autobiografico - o lo è in maniera molto “laterale” - ed è La chiave a stella, che parla di un montatore, cioè un uomo che monta, monta ponti, monta tralicci monta piattaforme petrolifere, e costituisce un personaggio messo insieme assemblando diverse persone che lui ha conosciuto. Che cosa ha di straordinario La chiave a stella, che in questo è proprio l'altra faccia de Il sistema periodico? Prima di tutto, per certi versi, sono entrambi libri di avventure: raccontano che fare un lavoro con gli strumenti per agire sul mondo può essere appassionante, avventuroso tanto quanto una storia d'amore o di guerra o di sport. Così, infatti, si capisce la tecnica da punti di vista che spesso non si comprendono: l’essere umano dotato di strumenti vive delle esperienze, e anche delle avventure, che sono sue proprie. In secondo luogo, in questi testi Levi dice una cosa abbastanza sconcertante, però fortissima: che il lavoro può essere una delle esperienze che più si avvicina alla felicità. Il lavorare, l'agire tecnico può arrivare a livelli di pienezza umana che altri momenti della vita magari possono regalare, seppur diversamente.
ALaR: Ecco, quello che tu stai raccontando fa ritornare sovente al rapporto tra l'azione - intesa come rapporto tecnico e quindi anche con lo strumento, coi mezzi - e il corpo. In questi autori che ci hai raccontato, il dato dell'esperienza non riguarda solo l'esperienza della mente, si palesa maggiormente attraverso lo strumento “corpo” e la relazione del nostro corpo con i corpi esterni, con i corpi che creiamo, con i corpi della tecnica. Questo, secondo te, è qualcosa che può ancora essere vero? Questi autori potrebbero scrivere quello che hanno scritto guardando al rapporto tra uomo e tecnica oggi?
PO: Assolutamente sì. Il corpo è ancora elemento imprescindibile dell’umanità e dell’esperienza. Mauss, innanzi tutto, dice che dobbiamo vedere la tecnica come fatto umano totale. Facevo prima l’esempio sul fatto che, nel momento in cui si introduce la più mentale forma di tecnologia, si crea il più manuale degli apparecchi: questo McLuhan lo spiegherebbe molto bene perché - lui dice - “il tatto è il senso dei sensi” così come “la mano strumento degli strumenti”, mutuando il pensiero di San Tommaso d’Aquino. Lo stesso Aristotele sostiene, ben prima di lui, che gli esseri umani siano, tra tutti gli animali, quelli che hanno il tatto più sviluppato e di conseguenza i più intelligenti. Eppure è così, perché la tattilità, nell'informatica, è molto più importante di quanto sembri, poiché si possono pensare le tecnologie attuali in diversi modi, ed è giusto che sia così perché vanno concepite come progetti che vanno in direzioni differenti. Una di queste direzioni è portarci fuori dall’umano: cioè, sostanzialmente, verso un mondo che si autoriproduce e non ha bisogno degli esseri umani. Una direzione è, in un certo senso, costruire i suoi esseri umani: si pensi a tutta la mitologia della robotica, una mitologia su una tecnica che si fa la sua umanità, in qualche modo separata, distinta e superiore rispetto all'umanità ordinaria. Qui entrano in gioco dei fatti di un fascino straordinario: c'è una raccolta di racconti sui robot - che cito sempre - in cui uno scrittore di fantascienza dice “grande è l'interesse degli esseri umani per gli altri esseri umani: per questo dalle bambole fino ai robot continuano a costruire oggetti che siano una loro effige”. Ecco, trovo anche questa un'intuizione bellissima: perché si costruiscono i robot molto spesso in forma umana o para-umana? Perché, per l'appunto, non vi è solamente il bisogno di costruire uno strumento quasi perfetto, ma anche un bisogno, tra il mitico e lo psicologico, di riprodurre la specie umana attraverso degli oggetti tecnici apparentemente perfezionati. Possiamo aggiungere anche questo: che si tratta del sistema a cui tendono molte delle tecnologie attuali, tra cui la più mitica di tutti, che è l'intelligenza artificiale, che contiene un elemento narrativo quasi incrostato dentro l'idea stessa dell'intelligenza artificiale.
Sull’intelligenza artificiale io dico sempre due cose: la prima è che se esiste l'intelligenza artificiale non dobbiamo dimenticarci che probabilmente esiste anche la stupidità artificiale, che non è una cosa da sottovalutare, perché nel momento in cui ci si mette su quella strada ci si può mettere anche sulla strada di creare qualcosa di profondamente devastante (la stupidità non è totalmente altra cosa dall’intelligenza, ne è il rovescio). La seconda cosa che dico è che l'intelligenza artificiale viene mitizzata come qualcosa che è totalmente altro dall'umano, però è qualcosa la cui forza, il cui fascino, sta nell'agire nel nostro mondo, in relazione con la società: se ideassimo un’intelligenza artificiale per l'esplorazione dei pianeti che fa tutto da sola senza che a noi arrivi niente, probabilmente ci interesserebbe fino a un certo punto; vi sono necessariamente dei materiali, dei video, dei prodotti che entrano in relazione con noi e ci coinvolgono in delle esperienze. È proprio su quelle, e non sull’efficienza puramente tecnica, che noi misureremo questo oggetto.
Molta della letteratura di fantascienza ci dice delle cose interessanti in merito - e questo ci consente di avvicinarci anche all'ultimo dei nostri libri. Perché esiste la fantascienza dalla fine dell’Ottocento in poi? Perché sostanzialmente l'umanità non si può più pensare senza il cambiamento tecnico: è parte dell'esperienza umana il fatto che le tecniche cambino. La fantascienza è uno dei modi in cui ci si relaziona con il cambiamento tecnico. Quando arrivano le mitiche tecnologie tipo l'intelligenza artificiale si verifica sovente un fenomeno che io trovo abbastanza inquietante: la fantascienza diventa pessimista. La cosiddetta distopia diviene il genere dominante. Mentre la fantascienza è stata per lungo tempo oscillante tra il pessimismo e l'ottimismo, da un certo momento in poi si è rivelata tutta di stampo pessimista. Questa de-umanizzazione della tecnica che sembra accompagnare la fase attuale è vista come catastrofica. Io penso che in questo ci sia anche una forzatura, poiché la de-umanizzazione della tecnica non è totale, poiché è un fenomeno molto più articolato complesso di quanto di quanto possa sembrare, poiché il mito dell'intelligenza artificiale perfetta anche perché disumana sottovaluta la necessità dell'irregolarità dell'errore per l’avanzamento della conoscenza (rischia altrimenti di riprodurre solo ed esclusivamente sé stessa). Da questo punto di vista dobbiamo, a mio vedere, insistere oggi sul carattere umano, corporeo, sporco oserei dire, ibrido delle tecniche; è una questione particolarmente urgente, perché se si tratta tecniche allora si applicano in qualche modo al nostro corpo, ci si appiccicano addosso.
L'ultimo libro che citiamo è il primo in ordine di tempo, è una storia scritta in due mesi da uno dei più grandi narratori della storia. Robert Louis Stevenson morì nelle Isole Samoa perché soffriva fortemente di polmoni e quello era uno dei pochi posti dove poteva stare, anche se morì comunque giovanissimo, a 44 anni (gli abitanti delle Isole Samoa lo chiamavano Tusitala, ossia raccontatore di storie). Ecco, Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde è un breve romanzo, o se volete un lungo racconto. Si tratta per certi versi di una distopia, che però parte da un progetto, il progetto del dottor Jekyll, che è più sofisticato per certi versi di altri. La prima distopia tecnologica moderna si chiama Frankenstein, o il prometeo moderno, è del 1821 ed è di Mary Wollstonecraft Shelley: Frankenstein è il primo e tipico romanzo distopico in cui sostanzialmente c'è lo scienziato matto che vede la sua creazione ribellarsi contro di lui (il romanzo è molto più bello e sofisticato di tutti i film che ne sono stati tratti, ed è un romanzo che si legge ancora con grande passione). Il dottor Jekyll, invece, non vuole fabbricare il grande robot, ha piuttosto un progetto tecnologico morale: vuole separare il bene dal male, e pensa che la tecnologia serva a quello. Crea, in sostanza, un farmaco, una mistura chimica - la parola pharmakon in greco voleva dire che “strumento”, e questo è molto interessante - una mistura chimica che fa sì che in certi momenti lui sia Jekyll e certi momenti sia un altro essere, che si chiama Hyde, un essere mostruoso ove si concentra tutto il male che esisteva in Jekyll e che viene separato da lui. Il problema del dottor Jekyll e mister Hyde è che lui non riesce a liberarsi del male, e soprattutto non riesce a liberarsi di Hyde: la sua grande opera tecnica, che arriva al risultato di scinderlo in due esseri differenti, fallisce, perché innanzitutto Jekyll rimane una mistura di bene e di male, mentre Hyde di solo male, e in secondo luogo perché viene invaso progressivamente dal suo mostro, che lui stesso ha creato. Di tutti i romanzi moderni, questo è uno di quelli che sono diventati più mitici nel senso stretto (ne sono state fatte decine di film e sceneggiati televisivi) si tratta di uno di quei casi in cui il romanziere inventa una storia che coglie degli elementi profondi dell’umanità, come Peter Pan, come il Don Giovanni. Queste storie poi escono quasi dalle loro mani, dalle mani degli autori, e diventano più indipendenti.
Che cosa c'è in nel dottor Jekyll che ci interessa in questa sede? Il fatto che per l'appunto il dottor Jekyll fa un esperimento in cui la tecnica deve agire direttamente sull’essere umano, e lui pensa di avere il progetto per farla agire nel modo giusto, rendendo la tecnica quasi moralmente perfetta perché rompe la dannazione dell'essere umano, che è fatto di bene e male inseparabili e inscindibili, l’uno dentro l'altro. Questo esperimento fallisce proprio perché il modo in cui la tecnica agisce sull'essere umano non risponde a un progetto tecnico: è un processo storico, psicologico, anche biologico, troppo complesso per poterlo controllare. Il rapporto tra la tecnica e l’umanità procede lungo il corso del tempo, molto spesso secondo strade che nessuno ha singolarmente progettato; per questo anche, in fondo, potremmo dire un po’ scherzosamente che certi limiti dell'intelligenza artificiale - e non l’intelligenza artificiale in senso assoluto - vanno nella stessa direzione: quella della presunta tecnica che fa solo cose buone. In fondo il racconto di Stevenson ci parla dell'impossibilità di tutto questo, e ci parla del fatto che alla fine noi, probabilmente, se l'esperimento fosse riuscito, odieremmo Jekyll tanto quanto Hyde, il bene tanto quanto il male. Invece noi siamo profondamente affezionati al dottor Jekyll, perché rimane nonostante tutto un essere umano come tutti noi, e la tecnica lo cambia ma in modo diverso da come avrebbe voluto. La grande inventiva di questo scrittore, la grande bellezza di questo romanzo (e io ne ho dato una soltanto delle decine di letture che se ne possono dare: vi sono altri romanzi di Stevenson che hanno ricevuto più attenzione, si pensi all'Isola del tesoro o Il ragazzo rapito), di questo racconto scritto in due mesi, è che vi sono alcuni dei fermenti più profondi del nostro rapporto con gli strumenti, compreso il fatto che la tecnica deve comunque tener conto, tra le altre cose, della complessità morale dell’umanità, della nostra corporeità, della nostra psiche, e anche del fatto che l’umanità è fatto di bene e di male, è fatta di progetti che pensano di essere ottimi e sono disastrosi, è fatta di progetti che magari sono inizialmente pessimi e poi possono dare anche qualche risultato positivo.
Ciò non significa che tutto sia casuale: direi, piuttosto, che tutto richiede uno sguardo di lungo periodo, di largo respiro e anche una certa umiltà. In fondo il grande peccato del dottor Jekyll è la mancanza di umiltà. È quella che gli antichi chiamavano hybris, la sensazione di stra-potenza: la tecnica porta con sé questo rischio; dunque pensare, guardando la tecnica, che essa è comunque un pezzo di noi, che ha a che fare coi nostri limiti corporei, mentali, etici, è un modo di poterla usare in modo responsabile. Questo è un altro aspetto fondamentale: la responsabilità. C'è un dibattito interessante negli anni Ottanta e Novanta sull’ipotesi del disinventare le tecniche troppo disastrose: un’ipotesi impossibile. Non si possono disinventare armi nucleari o i pesticidi che hanno devastato l'ambiente, si tratta di prodotti che ormai hanno lasciato le loro tracce. La responsabilità della tecnica è uno dei motivi per cui dobbiamo saperla legare con noi stessi, col nostro corpo, coi nostri limiti, perché il grande sogno sennò è appunto quello di cui parla la Arendt, della burocrazia che non è colpa di nessuno. Rischiamo appunto di pensare a una tecnica che non è più colpa di nessuno, e questa è la peggiore forma di vigliaccheria.
ALaR: Ecco io colgo l'ultima parola, vigliaccheria, perché in realtà tu oggi ci hai raccontato e consigliato - e ti ringrazio tantissimo perché questo percorso ci ha veramente aperto una curiosità e la voglia di entrare ancora di più nell'introduzione che ci hai fatto di questi testi. Ti chiedo ancora un minuto per parlare di un sesto libro che è sulla viltà, un libro che è appena uscito, di cui sei autore e che richiama proprio questa materia complessa che è l'uomo. Il titolo è Sulla viltà: anatomia e storia di un male comune, edito da Einaudi. Il volume racconta quindi questo richiamo, ci riporta al male di cui tenere conto come di qualcosa che ci appartiene.
PO: Sulla viltà ci parla di qualcosa che sicuramente è un male, perché la viltà è uno scendere sotto di noi stessi al di sotto dei valori che dichiariamo di avere. È un venir meno agli altri e in qualche misura a noi stessi. È tuttavia un male comune perché - come dicono i grandi filosofi - nessuno vi si sottrae mai del tutto. La cosa molto importante è questa: essere consapevoli del fatto che tra i limiti dell'umanità c'è anche a volte il cadere in mani spregevoli come quelle della viltà; il fatto che è parte del nostro patrimonio, il fatto che comunque va combattuto, perché questi due aspetti devono convivere: riconoscerlo come parte di noi è però combatterla egualmente. Con la tecnica credo che c'entri molto, innanzitutto perché ci sono tecniche legate alla viltà: si pensi all’uso selvaggio delle armi da fuoco in situazioni in cui l’arma da fuoco conferisce un vantaggio su persone indifese, o ancora alla burocrazia che si nasconde dietro la tecnologia svuotando di responsabilità l’enorme potere che ha sulle persone, o infine alla generale dimenticanza di tutte le responsabilità connesse a questo tipo di realtà.
Le mie ultime riflessioni per l'appunto ci richiamano al fatto che dobbiamo essere sempre consapevoli del fatto che tutto quello che l'umanità fa comporta delle responsabilità, e che la de-umanizzazione della tecnica può avere l'illusione di essere una deresponsabilizzazione di chi la produce, ma in realtà può produrre delle conseguenze, delle responsabilità ancora più gravi. In fondo possiamo dire che la bomba atomica è una tecnica che pone fine a tutte le armi, come si è sognato anche per certi versi, però la responsabilità che si è assunto chi l’ha fabbricata e che si assume ogni giorno la riproduce che potrebbe essere alla fine la più devastante possibile rispetto alla vita sulla terra. Mantenere sempre questo elemento di responsabilità è quello che giustifica il continuare a dire che la tecnica siamo noi, e che noi siamo fatti dalla tecnica.
ALaR: Grazie mille di questa conversazione.
PO: Grazie a voi di avermi dato l’occasione.