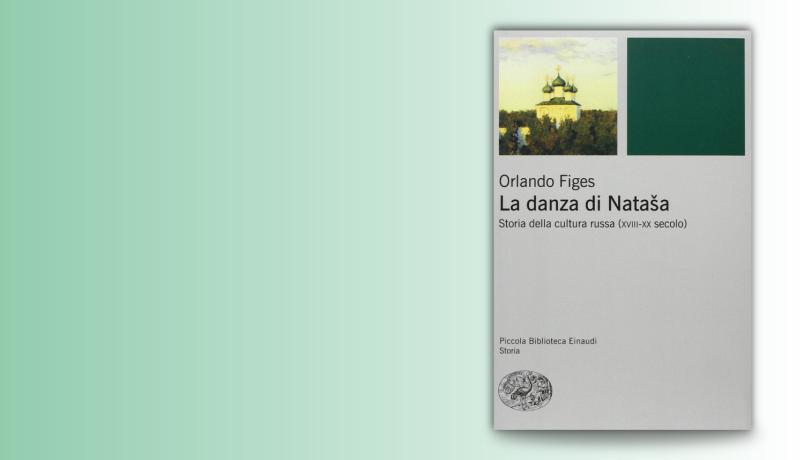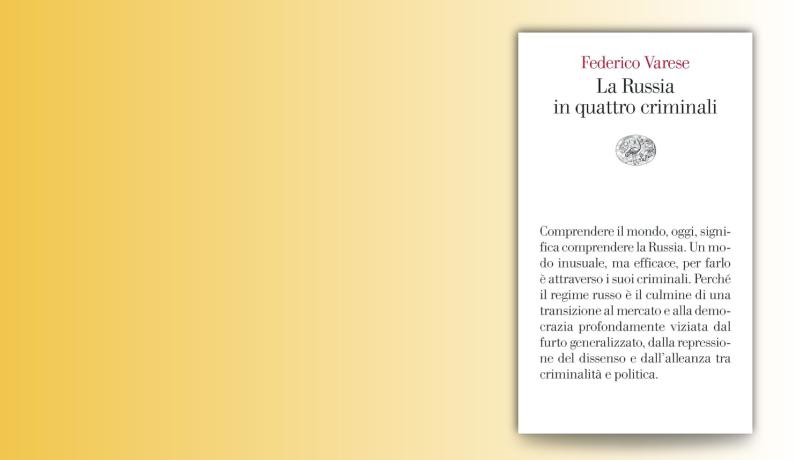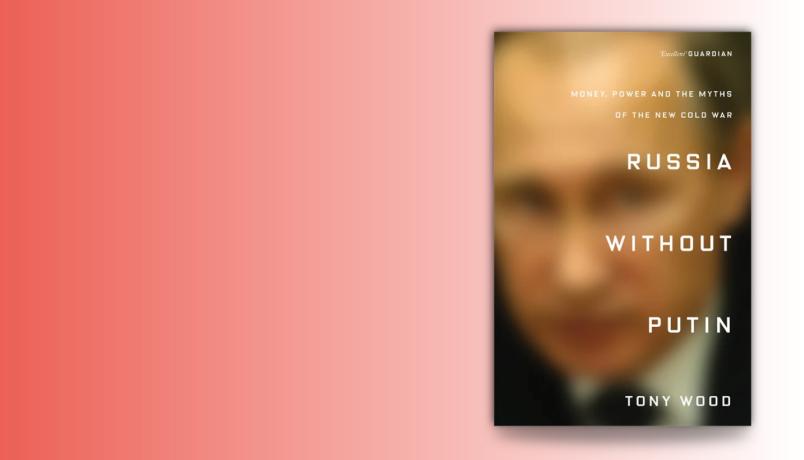Chi è Nicola Melloni

Esperto di relazioni tra Stato, democrazia e mercato. Insegna economia politica comparata all’Università di Siena. È stato fellow presso la Munk School dell’Università di Toronto e di Bologna e a lungo docente presso la London Metropolitan University. Da sempre interessato alle vicende politiche ed economiche della Russia, ha conseguito un dottorato presso la University of Oxford sulle problematiche della transizione post-Sovietica. Collabora con riviste quali “Il Mulino” e “Jacobin”.
Prof. Alessandro De Magistris (ADM)
Benvenuti a questo nuovo appuntamento di “Cinque libri”, l'iniziativa del Politecnico di Torino che invita a trattare temi e materie di grande interesse, talvolta anche di grande attualità scientifica, attraverso il filtro di una serie di letture proposte di volta in volta da uno specialista. Oggi parleremo di un tema di grande attualità, appunto, che mette al centro la Russia e la sua storia, un appuntamento particolarmente interessante proprio perché il modo in cui la tragedia degli avvenimenti ai quali stiamo assistendo, la situazione stessa che ha posto in essere questa immane tragedia, ha in qualche modo sollecitato una serie di semplificazioni, legate naturalmente anche alla congiuntura, alla contingenza, ai campi di forza che entrano in gioco in questa vicenda, e che tendono a oscurare la complessità, la stratificazione di qualsiasi discorso legato alla Russia. Ed è proprio per questo che l'appuntamento odierno acquista un significato particolare e un invito a tutti coloro che vogliono approfondire questo argomento a seguire i consigli di lettura che forniremo a breve. Letture che, fra l'altro, sono tutte disponibili nelle Biblioteche del Politecnico.
L'ospite di oggi è un grande specialista della materia. Nicola Melloni ha curriculum di studi molto corposo che parte da Bologna, passa attraverso Mosca, Oxford e un dottorato di ricerca che lo ha poi portato a insegnare economia politica in diverse università, tra cui quelle di Toronto e di Siena. Uno specialista che guarda all'economia politica ma anche alle complesse relazioni che intercorrono tra Stato, mercato, relazioni sociali, culturali e sviluppi storici. Quindi un profilo ideale per riflettere su questa materia così urgente. Non voglio anticipare discorsi che saranno approfonditi a breve, ma i cinque libri che affronteremo attraversano un ampio ventaglio di prospettive, tutte in qualche modo portate a sollecitare la nostra riflessione sulla complessità del “fatto russo”. Un libro di storia della cultura, un romanzo, un libro orientato a un'analisi più sociologica, un testo che invita a rileggere la straordinaria ricchezza di una pagina della cultura artistica sovietica, in uno dei tanti momenti della sua storia, e – finalmente - un libro che propone una riflessione molto attenta sulle vicende del periodo post-comunista, particolarmente utile proprio in relazione alle grandi semplificazioni alle quali siamo sottoposti costantemente da parte di voci più o meno esperte in campo geopolitico. Cedo dunque volentieri la parola al Prof. Nicola Melloni.
Prof. Nicola Melloni (NM)
Grazie Alessandro. Hai giustamente anticipato l’approccio che ho adottato nella scelta di questi cinque libri, che è la ricerca della complessità, in un momento peraltro molto difficile, molto grave, per parlare di Russia. Siamo sommersi da pseudo-informazioni che richiamano proprio quanto dicevi: la semplificazione di un contesto politico presente, ma anche di un percorso storico, che nasconde il rifiuto di un qualcosa che è diverso da noi ma che alla fin fine non è così diverso: perché la Russia è stata ed è ancora, in parte, Europa, un paese che ha avuto proprio con l’Europa molti scambi di natura culturale, politica, e che nel tempo è stato oggetto di curiosità, da un lato, e di timore dall’altro, soprattutto nel periodo post-rivoluzionario, quando la Russia, o meglio l’Unione Sovietica, ha rappresentato l’impero del male (pensiamo agli anni Ottanta), per poi tornare invece a essere la terra dell’avvenire, il sol dell’avvenire, da guardare appunto con curiosità. È sempre stato difficile parlare di Russia, ma oggi, più di allora, sembra diventato impossibile, visti anche i terribili eventi che ci hanno travolto. Eventi di cui, peraltro, non parleremo nello specifico, se non qualche accenno nell’ultima parte della nostra conversazione, quando tratteremo il libro di Tony Wood.
Il problema, piuttosto, è la percezione che abbiamo della Russia, una percezione che in qualche maniera non dico ci venga imposta ma che di fatto diventa molto mainstream nella discussione pubblica. Quello che dicevi quando hai parlato di specialisti è una provocazione che raccolgo, nel senso che, senza voler per forza difendere l’Accademia, spesso chiusa in sé stessa, è comunque dentro le sue mura, nelle sue pubblicazioni, che si forniscono informazioni e strumenti per una riflessione più libera da pregiudizi, al contrario di quanto accade nella pubblicistica un po’ bellicista oggi così diffusa, sulla quale però si forma l’opinione pubblica. Anche in Accademia, a dire il vero, negli anni più duri della Guerra Fredda, c’era un’impostazione che tendeva a parlare di “noi” e “loro”, soprattutto da parte di molti storici angloamericani, che però lo rivendicavano in maniera aperta e onesta, e questo secondo me fa una grande differenza. Era parte di una battaglia politica, culturale, militare - anche se militare alla fine non lo è per fortuna mai diventata realmente - che presupponeva, da parte di quegli studiosi, il riconoscimento di un'appartenenza, di una vera e propria partisanship, che tuttavia era essa stessa oggetto di dibattito. Adesso, invece, è proprio il dibattito a mancare. Sia da una parte che dall'altra vediamo una grande mole di dati che, naturalmente, vengono confermati anche dall'esperienza presente, quella di una guerra terribile, illegale, che ci distoglie però da ciò che davvero è stata la Russia, da quelle che sono davvero state le nostre interazioni con la Russia. Come d’altronde è successo con la rivoluzione, ora gettata nel cestino della storia, ma che in realtà è stata una rivoluzione che ha creato grandi speranze, grandi ideali, che ha contribuito all'evoluzione politica mondiale, in Occidente e nel mondo in via di sviluppo, e di cui è giusto rimarcare i dati, anche in questo caso terribili, sottolineando i costi umani devastanti del periodo staliniano, ma che non può essere un’esperienza equiparabile a quella nazista e fascista, come si tende a fare oggi.
L’idea, dunque, con questi cinque libri, è di offrire un percorso direi storico, nel senso che partiamo con un libro sulla storia culturale della Russia, attraversiamo la Mosca degli anni Venti e le sue utopie nell’arte, approdiamo al romanzo di un autore ebreo russo emigrato in America, Sergej Dovlatov, e alla sua capacità di descrivere la realtà in termini caustici ed ironici riallacciandosi alla tradizione letteraria russa di matrice cechoviana, per poi concludere con i due volumi di cui facevi cenno anche tu, quelli risepttivamente di Federico Varese e di Tony Wood.
ADM
Bene, direi allora che potremmo entrare nel vivo di questo primo, straordinario libro che rappresenta un esempio imprescindibile di storia culturale, particolarmente importante proprio perché, anche facendo seguito a quello a cui accennavi, tra le conseguenze più nefaste di quello che sta accadendo, della tragedia a cui stiamo assistendo in Ucraina, c’è senza dubbio l’applicazione di una sorta di cancel culture della storia e della cultura russa, che fortunatamente oggi si è un po’ smorzata ma che negli ultimi tempi si è espressa in forme che io ritengo veramente problematiche.
NM
Smorzata nemmeno poi tanto, se è vero che proprio oggi doveva essere rappresentata la Sinfonia “Leningrado” di Shostakovich al Met di New York, e invece è stata cancellata e sostituita da un'opera ucraina, che è anche comprensibile, nel senso che se il rigetto momentaneo della cultura russa va nella direzione di un'espansione, di una maggiore comprensione della cultura ucraina, per lo più ignorata o dimenticata, può venire fuori qualcosa di buono. Allargare gli orizzonti è sempre positivo, arricchisce sia la storia culturale sia il dialogo politico. Il problema è che, in questo caso, non stiamo allargando gli orizzonti, ma stiamo cancellando pezzi di storia: quello che sta accadendo con la storia e la cultura russa è l’esempio più lampante di cancel culture che io conosca. Ecco, ho scelto quindi di prendere come primo libro “La danza di Nataša” dello storico britannico Orlando Figes, proprio perché durante questo lungo anno abbiamo sentito ancora e ancora e ancora come Dostoevskij sia parte integrante dell'imperialismo russo e, per questo, non dovrebbe più essere insegnato. Dostoevskij era un decabrista, aveva combattuto contro lo zar, fu portato di fronte a un plotone di esecuzione. È anche vero che, a dimostrazione della complessità della storia russa, tutti questi grandi autori - si pensi anche a Tolstoj, che è stato il primo grande pacifista - hanno contribuito naturalmente alla creazione del mito nazionale russo: uno Stato che si è espanso con una frontiera aperta simile a quella degli Stati Uniti, anche se molto diversa come espansione, e che ha sempre avuto delle dinamiche molto complesse. E io che non sono uno storico, tanto meno uno storico della cultura, ma mi occupo invece di economia politica, penso però che per capire l'economia politica, per capire la storia, bisogna studiare la cultura, perché la cultura è politica e la politica è cultura. E l'economia è politica e cultura allo stesso tempo. Quindi, riprendere in mano questo libro è un’occasione per capire la complessità della cultura russa e del rapporto molto complesso che la Russia ha con l'Occidente.
ADM
In diversi cicli storici, anche negli ultimi decenni, c’è sempre stata questa tensione in Europa tra un guardare a est o a ovest…
NM
È un tema che percorre tutta la storia russa, tant'è che ricordo che, in epoca sovietica, subito dopo la rivoluzione il poeta Maksimilian Aleksandrovič Vološin dirà “Pietro il Grande è stato il primo bolscevico”. Interessante, perché parliamo dello zar che costruisce l'autarchia russa, e che però guarda all’Europa con l’obiettivo di modernizzare, che è uno dei grandi temi ricorrenti della storia russa. Pietro il Grande costruisce San Pietroburgo, copiando Venezia. La costruisce sul Baltico perché è il posto più vicino all'Europa, chiamando a lavorare gli architetti europei perché vuole un'influenza culturale europea. Ci porta tutta la Corte, che deve abbandonare Mosca e anche tutte quelle vestigia culturali che sono tipiche della vecchia Russia (per esempio, dice Fagis, non fu più possibile tenere gli animali dentro il cortile di casa). Però, nonostante tutto, Pietro il Grande viene definito “il primo bolscevico”, ma d’altronde è la stessa rivoluzione russa ad avere come obiettivo la modernizzazione, anche se in maniera naturalmente diversa, e a guardare all’Occidente per farla, sempre con quel misto di invidia e di paura. Stalin, alla vigilia della collettivizzazione, dirà “abbiamo dieci anni di tempo per recuperare uno svantaggio di un secolo”. E dieci anni dopo inizia la seconda guerra mondiale. C’è dunque questa idea di imitazione, che c’è anche nella transizione dall’epoca comunista a quella post-comunista: negli anni Novanta la Russia si rivolge all'Occidente, cerca di copiarlo, di copiare un certo tipo di capitalismo, che ha determinato la sconfitta storica dell’Unione Sovietica, pur con tutte le sue contraddizioni.
ADM
Su questo tema sarà poi l'ultimo libro a dare molti spunti, soffermandosi su quanto questo guardare probabilmente sincero all'Occidente permanga anche fino a qualche anno fa.
NM
Nel libro di Fagis rientra, appunto, tutta questa complessità, questa relazione molto forte, dialettica, con l'Occidente. Ma poi, naturalmente, ci sono anche altre relazioni interne alla cultura russa, che non è un monolite, è una cultura in evoluzione, come tante altre. Una cultura in cui è sempre esistita una tensione continua tra il centro e la periferia, tra il rischio di fughe centrifughe del Paese e il nuovo accentramento del potere. In risposta a queste fughe c'è spesso stata una lotta tra innovazione e tradizione. Oggi, così come nell’iconografia guerresca classica, la Russia, i russi, lo stesso Putin, vengono raffigurati come barbari delle steppe, come mongoli dei tempi di Gengis Khan. Anche questo è parte della cultura russa, che vive come ogni cultura di tanti elementi, di contaminazioni. La cultura russa, a mio parere, è contaminata culturalmente molto più di quella francese, che tende a essere più monolitica, sempre nelle sue complessità naturalmente. Nella letteratura russa ritornano i miti ucraini, la relazione molto complessa con la cultura ucraina, rientrano i suoi ritmi musicali. Pensiamo a Bulgakov, a Gogol, che scrive richiamando i miti ucraini, o a Musorgskij che riprende Gogol per la danza “Una notte sul Monte Calvo”, con quei ritmi tipici delle steppe centroasiatiche. Tutti autori eminentemente russi ma che sono imbevuti di una cultura contaminata, appunto.
ADM
È un aspetto importante che, latente, attraversa molte pagine, tutte splendide, del libro di Fagis. Solo talvolta, però, diventa esplicito un secondo aspetto molto importante della cultura russa, collegato a quello della contaminazione: lo spazio. Abbiamo in effetti a che fare con un Paese immenso i cui confini non sono vere e proprie barriere geografiche, ma si dissolvono. Una caratteristica che segna costantemente i grandi cicli storici, e anche la psicologia, di questa realtà: una dimensione spaziale che è espansione ma che è anche minaccia. Questi confini, che non sono tracciati, che sono permeabili, sono frutto di profonde interferenze nel corso della storia: ci sono parti di questi territori contesi che, di fatto, sono stati creati economicamente nel periodo dell'industrializzazione forzata attraverso l'afflusso anche forzato di manodopera, creando così commistioni culturali fortissime.
NM
Assolutamente. È dal 1991 che questi confini sono diventati politici, ma in precedenza erano confini solo amministrativi, con tutto quello che ne conseguiva: russi che stavano in Ucraina, ucraini che stavano in Russia, e poi tartari ed ebrei, come Dovlatov. Le costruzioni di identità collettive nazionali sono molto complicate in situazioni di questo genere. Proprio per questo, secondo me, riprendere il libro di Fagis è importante per illuminare come questa cultura si sia evoluta, si sia costruita assorbendo tutte queste influenze. È vero che nel periodo zarista la parte linguistica è stata molto russificata, però è anche vero che questa russificazione passa appunto attraverso l'inglobamento di diversi miti e tradizioni che poi diventano miti e tradizioni russe, ma che hanno origini di tipo diverso.
ADM
Nel rapporto centro-periferia vi è sempre una materia grigia e complessa, però nelle parti in cui Fagis parla della cultura dell'Eurasia, di questo guardare all'Oriente, risuona forte anche la cultura delle avanguardie che nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento esprimeva una vera ammirazione, un tentativo di abbracciare nuovi orizzonti, una nuova cultura.
NM
…e quindi, appunto, una cultura sempre in evoluzione. Volevo chiudere la parte dedicata a questo libro spiegandone il titolo, secondo me molto significativo. La Nataša del titolo è la Nataša Rostov di “Guerra e pace”, figlia di Ilya Rostov. È una ragazza allevata e cresciuta nella più classica nobiltà russa - che parlava francese - che a un certo punto va in campagna a trovare suo zio, ritrovandosi così immersa nella civiltà contadina russa dell’epoca, una cultura – di cui Fagis parla tantissimo – spesso idealizzata dagli intellettuali russi, che ne restano fortemente influenzati. La danza ripresa nel titolo è la danza che, in un momento del romanzo, Nataša compie con i contadini ai ritmi non certo di un valzer di Corte ma a quello di una musica popolare, riscoprendo così la vera anima russa, in una sorta di ritorno alle origini. Anche se parlare di anima russa, che richiederebbe un discorso a parte, rischia sempre di togliere complessità, di ideologizzare, come qualsiasi altra semplificazione. È un termine pericoloso.
ADM
Il libro ci porterebbe a parlare ancora molto, però ora dobbiamo passare al secondo testo che hai scelto, un testo di storia della cultura che getta uno sguardo su un momento molto particolare della storia del Novecento, un momento “sovietico”.
NM
Sì, “La Mosca degli anni Venti” di Giovanna Spendel. Si tratta di un libro che, onestamente, ho impiegato un po’ a scegliere, dal momento che va un po’ fuori dal mio seminato. Ma come quello di Fagis, è comunque un libro di storia della cultura divulgativo e accessibile, anche se parla in maniera molto approfondita di movimenti di avanguardia che, se il lettore non conosce rischia di perdersi. Tuttavia, come dicevo, continuo a pensare che non si debba raccontare la Storia solo attraverso gli eventi politici, le battaglie, i grandi leader, ma proprio attraverso la cultura che rispecchia quello specifico momento storico preso in esame, e che in questo caso è la Mosca degli anni Venti, la Mosca post-rivoluzionaria. Una Mosca percorsa da enormi tensioni, che tornava a essere capitale, che diventa tutto d’un tratto il centro del nuovo Stato, costretta anche lei a modernizzarsi. Una città a cui non guarda solo la Russia ma anche il mondo in cui si trovano tutti questi fermenti culturali, Occidente compreso.
ADM
…fermenti culturali che qui portano un segno di radicalità che, in quel momento, la cultura pur radicale degli anni Venti non portava altrove, proprio perché si trattava di un Paese che cercava di costruire qualcosa di nuovo, un'entità nuova.
NM
Nel libro si racconta proprio questo tentativo di “scalare il cielo”, come si diceva allora, e lo si racconta attraverso le lenti di queste nuove forme d'arte che rappresentano una società in movimento, che cambia radicalmente, che si fa massa, sia a causa dell'industrializzazione sia a causa della guerra, una società che, nello specifico in Unione Sovietica, si identificava nella massa proletaria, che era il nuovo centro di attenzione. E allora l’architettura, ad esempio, cominciava a occuparsi di organizzare la nuova città dei lavoratori. E poi c'è il cinema, che nasce proprio in quegli anni e che rappresenta un fantastico strumento di propaganda. Qui non abbiamo tempo, ma sarebbe poi interessante approfondire il discorso guardando a come, nel cinema, si passi da un certo tipo di film negli anni Venti, molto rivoluzionario, molto in movimento, a uno invece più simbolico, che riscopre la tradizione russa negli anni Trenta. Questi anni Venti, però, sono anni eccezionali, secondo me, e che però abbiamo perso perché poi quello che è venuto dopo – e il libro che mi hai fatto conoscere ma che non prenderemo in esame, “Cultura due” di Vladimir Papernyj, lo testimonia – è stato a sua volta cancellato, ridotto semplicisticamente a una formula, c’è stato Stalin, che ha fatto sparire tutto il resto, ovvero tutto quello che non è stato Stalin. Quindi, il giudizio politico e storico che attualmente diamo della Rivoluzione d’ottobre è quello del fallimento, perché l'Unione Sovietica non esiste più. Ma la Rivoluzione d'ottobre resta un grande evento storico, globale, un evento portatore di sogni, di aspirazioni, che non era necessario, né sicuro, che finisse come invece è finito. La Mosca degli anni Venti, e questo il libro della Spendel lo fa emergere bene, è la Mosca della NEP, della Nuova Politica Economica, la Mosca aperta alle influenze anche occidentali, tanto che Bukharin diceva “arricchitevi” …
ADM
… simbolo di un Paese che si apriva nuovamente, che apriva nuovamente i suoi confini e che lasciava agli intellettuali varchi molto importanti, si poteva viaggiare, si intensificavano gli scambi, ecc.
NM
Tanto che c’è una parte della diaspora russa che va e poi ritorna e poi, magari, va di nuovo. La parte del libro sulla letteratura è molto interessante, direi indicativa, come quella dedicata alla cinematografia o alla grafica, un'arte che a me piace tantissimo: in quegli anni si cominciano a produrre i poster con l’uso di una grafica assolutamente stupenda, e il coinvolgimento di grandi artisti come Majakovskij o Rodčenko, un’arte con una funzione inizialmente solo politica ma che poi comincia a guardare anche al mondo della pubblicità, con poster che ritraggono le marche sovietiche di sigarette o del burro. E questo proprio perché comincia a esserci un'interazione diversa tra l'arte e le masse: è nello spirito dei tempi. La letteratura, invece, soffre di diverse complicazioni, in primis il fatto che fino alla Rivoluzione d'ottobre l'80% dei russi era analfabeta e il pubblico di riferimento era quindi molto limitato. La letteratura degli anni Venti è quindi abitata da un lato dagli avanguardisti e dall’altro da coloro che si sentivano invece a disagio nel nuovo mondo, nel nuovo Stato, e che quindi cominciano a emigrare. Un movimento che continuerà, pur con ragioni differenti, anche nei decenni successivi, dando vita al fenomeno degli scrittori russi che non vivono più in Russia, come vedremo bene quando parleremo di Dovlatov. Tra l’altro, se ricordo bene, c’è questa conversazione tra Bulgakov, che a un certo punto viene messo sotto accusa, e Stalin, a cui piaceva comunque molto. In una lettera Bulgakov gli scrive chiedendogli di lasciarlo andare via o di dargli quantomeno un lavoro perché non poteva più sopravvivere. E Stalin gli fa questa domanda: “lei, compagno Bulgakov, vuole andare via dalla Russia. Ma è possibile per uno scrittore russo non stare in Russia?”. E Bulgakov gli risponde di no, che non è possibile, e decide di rimanere. Qui siamo già alla fine di quell'epoca in cui le speranze della rivoluzione e quel fermento culturale, quel fermento politico, era scemato. Le lotte politiche degli anni Venti sono fortissime e traspaiono nel libro. Il ministro della cultura degli anni Venti, Lunačarskij, un grande intellettuale prima ancora che un grande politico, ha una relazione di apertura con tutti gli artisti: nel libro si parla dei “compagni di strada”, una definizione di Trotskij, cioè di intellettuali, di artisti che non erano socialisti, non erano di estrazione proletaria, ma che potevano comunque essere “compagni di strada” in questo cammino verso il socialismo. Quindi, negli anni Venti, c'è un'apertura, che poi negli anni Trenta comincerà sempre più a scemare. La fine di quel decennio, anche simbolicamente, è forse rappresentata dalla morte per suicidio del grande Majakovskij, che per quanto non legato necessariamente a motivi politici, segna comunque una frattura: c’è insomma questa tensione fortissima che viene a crearsi fin dalla metà degli anni Venti tra cambiamento artistico e cambiamento politico, esacerbato dall’imporsi dello Stato totalitario di marca staliniana, che imporrà certi dogmi, certi criteri. Proprio nel libro che mi suggerivi, “Cultura due”, compare questa contrapposizione tra orizzontale e verticale, tra gli anni Venti, che sono più orizzontali, e gli anni Trenta, che sono invece verticali. E quando leggo verticale la prima cosa che mi viene in mente è la verticalità del potere di Putin.
ADM
Questo tema, d’altronde, sviluppato in modo straordinario e specifico in “Cultura due,” lo ritroviamo anche nel libro di Fagis, con San Pietroburgo che fin dalla sua fondazione è città verticale laddove Mosca, fino a quando non conoscerà le grandi trasformazioni dell'epoca staliniana, è una città invece tendenzialmente orizzontale. Prima di passare ad altro volevo ricordare che questo libro “La Mosca degli anni Venti”, è particolarmente importante in questa sede politecnica perché offre un uno straordinario, per quanto sintetico spaccato di un momento eccezionale della cultura degli anni Venti, un’epoca votata allo sperimentalismo in cui le varie arti dialogano e l'architettura, l'urbanistica, diventano uno dei terreni più importanti per sondare la possibilità di costruire una nuova società. Sono gli anni in cui la cultura sovietica si esprime in modo davvero eccezionale attraverso figure come Mel'nikov, che progetta una casa che è un unicum a livello mondiale, una casa costituita da un doppio cilindro. Oppure nascono e si sviluppano proprio in relazione alle tensioni, ai progetti sociali, queste sperimentazioni, queste ricerche tipologiche legate al tema della casa comunitaria, come ad esempio i club operai. Una pagina che ancora oggi si legge molto bene nella realtà fisica di Mosca, che tra l'altro è una città a suo modo emblematica di tanti discorsi che stiamo facendo perché, per chi la conosca, nelle sue forme, nel suo assetto spaziale, anche nelle sue architetture, è una città che registra con impressionante esattezza i diversi passaggi, i diversi momenti della storia Russa e sovietica, in particolare del Novecento. Quindi questo stacco tra “cultura uno” e “cultura due”, tra città delle avanguardie e città staliniana, qui si rimarca in modo impressionante. È una città, Mosca, che quando si potrà tornare, consiglio vivamente di visitare, perché davvero rappresenta la linea di frontiera tra l’Europa e un'altra realtà. Passiamo quindi alla letteratura, con un libro - “La valigia” - che fotografa un momento storico altrettanto importante, quello della crisi degli ultimi anni dell'Unione Sovietica visti attraverso una figura di un grande intellettuale, tra l'altro oggetto di un film che magari hai visto, “Dovlatov”, un film molto interessante, distribuito anche nelle sale italiane, e che è costituito da tutta una serie di frammenti della sua produzione letteraria.
NM
Il film non l’ho visto, ma lo cercherò senz’altro. Io fui folgorato da Dovlatov una ventina di anni fa. Lui rappresenta secondo me, nella sua scrittura, proprio questo lento decadimento, questo affaticamento sempre più duro della società sovietica. I suoi sono libri autobiografici. Dovlatov è un personaggio che sostiene che la repressione culturale in Unione Sovietica negli anni Settanta era peggiore di quella dell'epoca di Stalin, perché mentre nell'epoca di Stalin facevano scrivere e poi, in base a quello che scrivevi, finivi o meno in un gulag, negli anni Settanta non ti facevano proprio scrivere, tanto che lui per pubblicare dovrà andare poi negli Stati Uniti. Dovlatov, però, rispetto ad altri, va via controvoglia, perché lui si sente uno scrittore russo che ha dovuto abbandonare la Russia, e lo ha dovuto fare perché altrimenti non sarebbe stato uno scrittore. Dovlatov è scontento del regime sovietico, pur non essendo un dissidente classico. Lui si autodefinisce un dissidente dalla vita e rappresenta quell'animo un po’ russo di quegli anni, un animo affaticato, stanco. Al centro di molti dei suoi libri c’è la bottiglia, la vodka come compagna di vita, un problema devastante nell’Unione Sovietica di quegli anni, tant'è che poi quando Gorbaciov, qualche anno dopo, proverà a bloccarne la vendita, la sua popolarità scemerà immediatamente e non si riprenderà più. Dovlatov cambia il registro della letteratura russa perché comincia a usare un linguaggio più urbano, più colloquiale, con scambi di battute che in quegli anni chiunque faceva tra amici, per strada, ma che nel formalismo della letteratura ufficiale non compariva. E quindi lui se ne va, emigra. La valigia del titolo è la valigia che Dovlatov si porta dietro quando va via dalla Russia per andare negli Stati Uniti, quella valigia che all’epoca tutti coloro che emigravano avevano diritto di portarsi dietro, racchiudendovi tutta la propria vita. E lui, nella sua valigia, racchiude tanti elementi simbolici che sono semplicemente i simboli della sua vita quotidiana e che rappresentano la vita quotidiana fatta di piccole furbizie, del mercato nero, della polizia politica che ti controlla ma che è anche una polizia stupida, burocratica, incapace, dei politici interessati al proprio tornaconto, dei privilegi che la nomenclatura si concede, privilegi che se li guardiamo con gli occhi di oggi, con le differenze sociali della Russia attuale, non sono nulla ma che in un Paese come l'Unione Sovietica avevano invece un significato simbolico molto forte, di una classe legata al partito, di una burocrazia che si poneva comunque al di sopra della società, contraddicendo gli ideali e le aspirazioni di qualche anno prima.
ADM
È utile ricordare che parliamo di una di una società in cui non esisteva mercato, in cui la carenza di beni per noi essenziali era rilevante, e dove l'accesso a canali sotterranei era una delle forme dell'economia.
NM
Assolutamente. Era un'economia informale, che diventerà poi importante anche per capire la transizione a un’economia di mercato. Il primo degli oggetti che Dovlatov ha dentro la valigia sono dei calzini finlandesi, che non esistevano in Unione Sovietica ma che un amico di amici aveva fatto arrivare sottobanco. Calzini che però, appena prima di essere distribuiti, entrano in produzione nelle fabbriche sovietiche, disinnescando la funzione del mercato nero. E quindi, per concludere, possiamo dire che Dovlatov è il classico artista russo che si trova a disagio in Russia e che si troverà a disagio anche negli Stati Uniti, un po’ come Brodskij - di cui Dovlatov è amico, tanto da portarsi dietro una fotografia nella sua valigia -, che è vero che si americanizzerà, cominciando anche a scrivere in inglese, ma che non amerà mai l’etichetta del dissidente attivo, sostenendo anche lui che il sistema sovietico non gli piaceva, così come non gli piaceva molto quello americano. Brodskij e Dovlatov sono artisti che esprimono un dissenso che in larga parte non è politicizzato, o quanto meno non è politicizzato come lo pensavamo noi: si trattava più di una insoddisfazione verso un regime diventato intollerabile, quella stessa insoddisfazione strisciante che porterà, per implosione più che per una controrivoluzione, alla fine dell'Unione Sovietica.
ADM
Passiamo a questo punto a una realtà più vicina a noi attraverso lo sguardo sociologico proposto da questo libro recentissimo, dal titolo “La Russia in quattro criminali”.
NM
Un titolo eloquente ma un po’ fuorviante, anche se è un bel libro. Perché è vero che non si può spiegare la Russia in quattro criminali, però si possono usare questi quattro criminali come una parabola del disgregamento dell'Unione Sovietica nella follia degli anni Novanta e poi nella stabilizzazione successiva, con Putin. Qui ci sono quattro criminali. Il primo è un classico criminale, un “pendaglio da forca”, già criminale in epoca sovietica che diventa però un criminale di alto rango durante gli anni Novanta, quando in Russia scompare letteralmente lo Stato. Una cosa di cui non si dirà mai abbastanza, anche per spiegare il presente. Come sappiamo benissimo qui in Italia, per esperienza diretta, il crimine organizzato prende il sopravvento e rimpiazza lo Stato nel fornire quella sicurezza che lo Stato stesso non è più in grado di fornire. Nella Russia degli anni Novanta lo Stato in Russia perde la sua funzione fondamentale, che è il monopolio della violenza pubblica. Questo monopolio non esiste più e passa nelle mani del mercato, un mercato in cui gli oligarchi si armano e combattono tra loro per il controllo del Paese. Quindi, questo primo criminale, Ivan’kov, è un criminale che dà protezione e combatte questa guerra di strada.
Il secondo criminale di cui si parla nel libro, Boris Berezovskij, è un grandissimo oligarca, il capo degli oligarchi, che compare alla fine degli anni Ottanta durante l'epoca della perestroika a Togliattigrad, dove in questa grande industria, grazie anche al concorso della FIAT, si costruivano quasi tutte le macchine che venivano prodotte in Unione Sovietica. Ci sarebbe tanto da raccontare, ma insomma Berezovskij è un oligarca che poi contribuirà più di chiunque altro all’ascesa al potere della Federazione Russa di Putin, Putin che poi, proprio perché Berezovskij si credeva troppo forte, lo castigherà, obbligandolo a scappare. Berezovskij morirà esule in Inghilterra quasi in povertà, o comunque avendo perso quasi tutto quello che aveva, e questo ci riporta anche drammaticamente alla realtà di cui stiamo parlando, perché è vero che Berezovskij, come Khodorkovsky, è stato perseguitato da Putin, ma l'essere perseguitato da Putin non è una garanzia per essere considerato una bella persona, un buon politico, un simbolo di quello che la Russia sarebbe dovuta essere, perché questi personaggi, alla fine, volevano Putin, lo volevano per garantirsi i privilegi, perché pensavano che Putin fosse funzionale al loro potere. E per molti lo è effettivamente stato. In questo libro, insomma, Varese racconta velocemente la storia di questi criminali per raccontarci anche la storia degli anni Novanta, del colpo di stato di Eltsin, che nel 1993 bombarda il Parlamento, delle privatizzazioni del 1996, che sono quelle che arricchiscono gli oligarchi e che furono un furto di portata colossale. Non ci si può dimenticare che, all’epoca, tanti economisti e politologi consideravano che in Russia tutto andasse bene, perché, sì va bene, questi oligarchi stanno un po’ rubando ma dopo aver rubato chiederanno di sicuro quelle istituzioni di garanzia e di sicurezza e vorranno stabilizzare i diritti di proprietà, vorranno la dittatura della legge, salvo poi accorgersi che cosa vuol dire la dittatura della legge in quella Russia.
Parlando del terzo criminale, Varese illumina poi le condizioni drammatiche delle carceri russe in cui lo Stato, che ora non ha limiti né confini, si può permettere di torturare, umiliare i detenuti. Ma forse è il quarto a essere il più interessante perché è un hacker, che rappresenta una figura ambigua, di criminale a cui lo Stato russo concede comunque delle libertà, almeno fino a quando non attacca la Russia stessa. Una figura, quella dell’hacker appunto, che fa emergere l’immagine di uno Stato potente ma debole allo stesso tempo, che deve allearsi con dei contractor, come ha fatto nella guerra in Ucraina con la Brigata Wagner, o con entità esterne a cui chiede di collaborare nell’esercizio del potere e della violenza. Uno Stato che alla fine risulta debole proprio perché non è puntellato da una società civile, non è puntellato da istituzioni abbastanza forti e consolidate.
ADM
Bene, adesso potremmo aprire all’ultimo libro di questa carrellata, un libro che chiude perfettamente il cerchio ed è particolarmente interessante, come dicevamo, perché propone una lettura non così scontata della Russia, anche alla luce di quanto si va dicendo oggi sui media.
NM
Il libro di Tony Wood, il più importante dei cinque per capire la Russia di oggi. Si intitola “Russia Without Putin”, la Russia senza Putin. Oggi, dicevamo, nella pubblicistica occidentale abbiamo due miti contrapposti: la Russia come monolite asiatico dittatoriale, con la sua cultura, e la Russia di Putin, che è l'emblema del male, un deus ex machina che è stato piazzato sulla Russia e che è il padre di tutti i mali, quello che, saltando gli anni Novanta, ha riportato in vita l'Unione Sovietica. Su questo Tony Wood è durissimo, sostenendo che possiamo dire tutto della Russia ma non possiamo negare che la Russia sia di fatto uno Stato capitalistico, uno Stato che proprio dagli anni Novanta è diventato capitalistico, di un tipo di capitalismo diverso dal nostro, ma sempre profondamente capitalistico. Dare le colpe all'Unione Sovietica per la degenerazione putiniana è sbagliato. Anzi, la tesi di Wood è che non ci sia stata una degenerazione putiniana, che la Russia sarebbe diventata quella che è diventata anche senza Putin. Non bisogna dimenticare, come dicevo, che in Russia nel 1993 c'è stato un golpe, che la democrazia in Russia è finita nel 1993 quando Eltsin ha fatto bombardare il Parlamento, un golpe che è stato salutato dagli applausi fragorosi dell'Occidente. Clinton stesso telefonerà a Eltsin complimentandosi con lui. E non bisogna dimenticare le sofferenze atroci del Paese, i milioni di morti, leggibili anche sul piano demografico, se è vero che l'aspettativa di vita in Russia, nella prima metà degli anni Novanta, cala di più che durante la seconda guerra mondiale. E tutto questo in un periodo di pace.
A me non piace parlare di genocidio, non userei questa parola in quasi nessun contesto, ma se fossi costretto a usarla allora la userei forse anche per descrivere quello che è successo in Russia negli anni Novanta. Perché, se allarghiamo a dismisura questo concetto, i milioni di morti, il disagio sociale, le bambine prostitute, la gente che quasi moriva di fame, che doveva vendere due cetrioli in mezzo alla strada per sopravvivere, che si faceva la vodka in casa perché non poteva più permettersi di comprarla a causa dell'iperinflazione, e consideriamo che tutto questo disastro sociale veniva taciuto o addirittura celebrato in Occidente, allora forse non sarebbe così sbagliato paragonarlo iperbolicamente a un genocidio. L’economista svedese Anders Åslund, alla fine degli anni Novanta, scriverà questo libro dal titolo “How Russia Became a Market Economy”, ma di che tipo di “market economy” fosse realmente non è dato sapere, oppure Andrei Shleifer che all'inizio dell'epoca putiniana scriverà “A Normal Country”, descrivendo la Russia di Putin come un Paese normale, quello stesso Paese che vent’anni dopo non ci sembra poi così tanto normale. È un periodo drammatico della storia russa, che noi abbiamo celebrato facendolo passare come il periodo in cui il comunismo è stato sconfitto. Nella mia lettura, il comunismo a dire il vero si è auto-sconfitto, perché la Russia non ha mai avuto una vera rivoluzione, bensì una dissoluzione da cui sono poi emersi tutti questi fenomeni - che Gramsci avrebbe definito “morbosi” - di una crisi organica delle strutture sociali, che hanno però permesso a Putin di ricentralizzare uno Stato che rischiava di scomparire. È stato fortunato ad avere i prezzi del petrolio più alti, cosa che ha permesso di ingrassare le casse dello Stato ma anche di investire per migliorare le condizioni di vita della popolazione.
ADM
Soprattutto di Mosca e delle grandi città, dove questa trasformazione è stata particolarmente evidente. La Mosca degli anni Novanta era una Mosca che andava degradandosi sempre di più, mentre la Mosca dei primi anni del XXI secolo è una città che si è dotata di infrastrutture estremamente avanzate, che ha rinnovato profondamente il proprio volto, il proprio assetto, avvicinandosi a quella che poteva essere a tutti gli effetti una grandissima capitale del mondo globalizzato.
NM
L'ultimo capitolo del libro di Wood è dedicato alla geopolitica e ci racconta che Putin, in un certo momento, è stato un buon alleato dell'Occidente, ricordandoci come dopo l'attentato alle Torri Gemelle la Russia abbia espresso fin da subito una grande vicinanza agli Stati Uniti, aiutandoli poi pesantemente nella lotta globale al terrorismo islamico. All’epoca la Russia, per Putin, era Occidente, mirava anche a entrare nella NATO, o comunque a costruire una partnership forte, mentre noi occidentali abbiamo continuato a ignorarla, spesso a umiliarla. Wood ci ricorda anche che queste continue umiliazioni, cominciate dagli inizi degli anni Novanta, hanno portato i politici russi anche più filo occidentali a mettere in guardia l’Occidente sulla questione ucraina, ad avvertirli che se avessero proseguito su quella strada sarebbe potuto succedere qualcosa. Insomma, questa partnership così tanto desiderata dalla Russia non sarà mai portata a termine e da qui nascono questi fenomeni terribili di revanscismo russo che, secondo Wood, siamo stati noi ad alimentare, che siamo stati noi a non voler contrastare, perché alla fine ci è venuto comodo scrivere una narrazione in cui, nuovamente, ci siamo trovati un nostro nemico, una panacea per i mali dell’Occidente in piena crisi. Tant’è che nella mia lettura personale, questa Russia cattiva ha fatto il gioco dell’Occidente che si è subito ritagliato il ruolo di salvatore della democrazia, una democrazia che però nell’Occidente stesso era in crisi, erosa dal germe del populismo, che la stava indebolendo. Almeno fino a quando non abbiamo trovato il nostro nuovo nemico e siamo tornati a essere il bastione della libertà e della democrazia contro il male, il bruto, il barbaro alle porte, che è appunto Putin. Questa è un po’ la narrativa che si è imposta, quella narrativa di cui abbiamo parlato all’inizio e sulla quale forse è giusto anche chiudere. In fondo noi siamo un po’ l’altro e l’altro è un po’ noi, non bisogna dimenticarlo. Ora ci viene comodo dipingere Putin come fosse Hitler, ma Putin non è altro che un imperialista, un’imperialista assassino che fa i suoi interessi, certo, ma paragonarlo a Hitler, dire che l’Unione Sovietica è come la Germania nazista, voler sempre estremizzare, è un modo per non confrontarsi con la complessità. Leggere questi cinque libri penso possa aiutare ad aprire spazi di riflessione.
ADM
Sì, ad aprire spiragli di riflessione, e anche di speranza. Il consiglio per tutti è dunque di leggere questi cinque splendidi libri. Grazie Professore, e grazie a tutti voi per averci seguito.