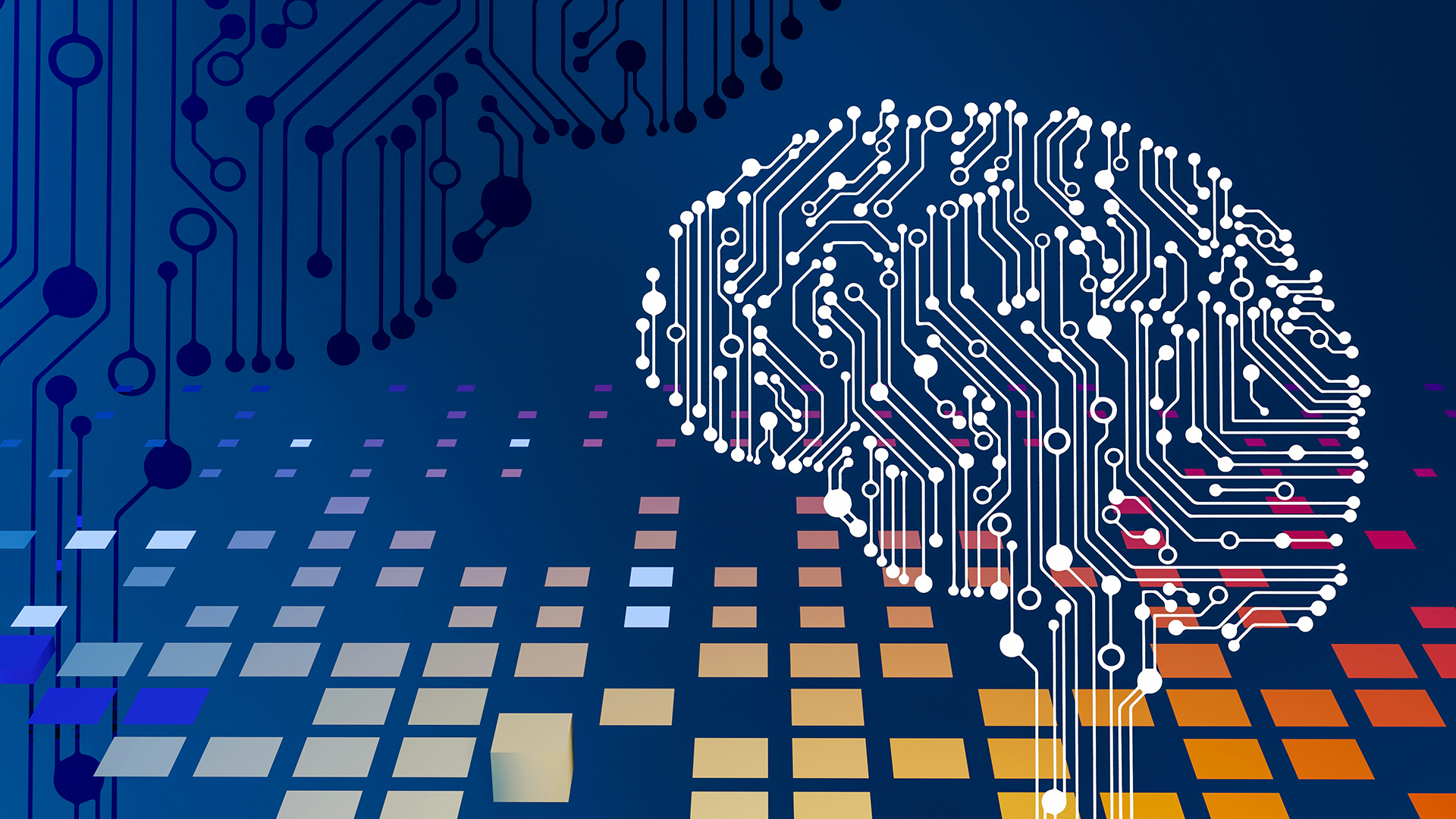
I robot imparano la paura per una migliore valutazione del rischio
L’istinto di bloccarsi davanti a condizioni di incertezza, abbassarsi a un rumore improvviso o scappare in situazioni di pericolo è una reazione rapida e fondamentale per la sopravvivenza degli esseri viventi in ambienti sconosciuti.
Una delle linee di ricerca più recenti nell’ambito della robotica sta esplorando come integrare i meccanismi di risposta emotivi tipici degli esseri umani, in particolare della paura, all’interno dei robot, al fine di migliorare la loro capacità di valutazione dei rischi e di prevenire insorgenza di situazioni pericolose.
Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica IEEE Robotics and Automation Letters da parte del professor Alessandro Rizzo - del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni-DET del Politecnico - dimostra un significativo passo in avanti in questo campo. La ricerca è stata ripresa su IEEE Spectrum – il magazine online di IEEE, la più grande organizzazione professionale al mondo dedicata all'ingegneria e alle scienze applicate – nella serie dedicata all’ingegneria e all’informatica IEEE Journal Watch in collaborazione con IEEE Xplore.
Il team del professor Rizzo ha evidenziato come i sistemi di controllo robotici attualmente in uso sono spesso progettati per compiti molto specifici, caratteristica che li rende inefficaci in condizioni complesse e dinamiche. "Di conseguenza, i robot potrebbero avere difficoltà a operare efficacemente e adattarsi a condizioni complesse e mutevoli", spiega Rizzo. A differenza degli esseri umani, che rispondono a stimoli diversi, complessi e unici, i robot faticano ad adattarsi efficacemente.
Una diffusa teoria sul funzionamento del cervello umano in situazioni di paura, chiamata “ipotesi del doppio percorso” (dual-pathway hypothesis), descrive due percorsi neurali principali che permettono di rispondere ai rischi. Il primo è la “via bassa” (low road), un percorso breve che produce una risposta rapida guidata dall'amigdala – la struttura cerebrale che guida le emozioni - e che permette di prendere decisioni basate su dati grezzi, come nel caso di un'azione immediata di difesa. Il secondo è la “via alta” (high road), un percorso che integra un ragionamento più articolato e sfrutta l'esperienza, con la mediazione dalla corteccia prefrontale, la regione del cervello responsabile delle funzioni cognitive superiori, come la pianificazione.
Il professor Rizzo e il dottorando del DET Andrea Usai hanno progettato un sistema di controllo per robot che emula la risposta alla paura tramite la “via bassa”. La paura è stata scelta perché è una delle emozioni più studiate nelle neuroscienze e riveste un ruolo critico per l'autoconservazione e le risposte rapide al pericolo.
L’algoritmo di controllo sviluppato al Politecnico combina il controllo predittivo (MPC) con il cosiddetto “apprendimento per rinforzo” (reinforcement learning). Il primo consente il controllo del robot in tempo reale, garantendo il rispetto dei vincoli imposti dal compito da eseguire. Il secondo permette al robot di adattare dinamicamente le proprie priorità sulla base di dati grezzi provenienti dall’ambiente, influenzando così il comportamento complessivo del sistema in maniera flessibile e intelligente.
Le simulazioni condotte da Rizzo e Usai hanno mostrato che il robot guidato dalla "low road" riesce a spostarsi in ambienti sconosciuti seguendo un percorso più fluido e sicuro verso il suo obiettivo rispetto ai design robotici convenzionali. Ad esempio, in uno scenario con differenti tipologie di pericoli in movimento, il robot programmato tramite "low road" ha mantenuto una distanza di sicurezza di circa 3,1 metri dagli oggetti pericolosi, mentre altri due robot convenzionali testati si sono avvicinati di più, rispettivamente fino a 30 e 80 cm.
L’ approccio della “via bassa” è promettente per quanto riguarda molteplici scenari, inclusi la manipolazione di oggetti, la sorveglianza e le operazioni di salvataggio, dove i robot devono affrontare condizioni pericolose e potrebbero aver bisogno di adottare comportamenti più cauti. Tuttavia, Usai fa notare che l'approccio "low road" è molto reattivo ed è più adatto per decisioni rapide a breve termine. Pertanto, il team di ricerca sta ora lavorando a un design di controllo che imiti il “percorso lungo”, il quale, pur essendo complementare al percorso breve, potrebbe aiutare i robot a prendere decisioni più “razionali” e a lungo termine, valutando i diversi scenari.
Per il futuro, i ricercatori considerano l'uso di modelli linguistici multimodali (come ChatGPT) per simulare alcune delle funzioni fondamentali della corteccia prefrontale umana, quali il processo decisionale, la pianificazione strategica e la valutazione del contesto. "Questi modelli potrebbero aiutare a simulare alcune delle funzioni fondamentali della corteccia prefrontale umana, come il processo decisionale, la pianificazione strategica e la valutazione del contesto, permettendoci di emulare risposte più cognitivamente guidate nei robot – spiega il professor Rizzo - In prospettiva, sarebbe anche interessante provare a estendere l'architettura per incorporare più emozioni, abilitando una forma più ricca e sfumata di comportamento adattivo nei sistemi robotici".